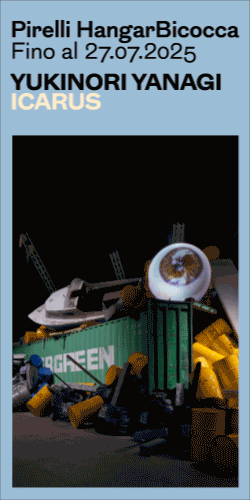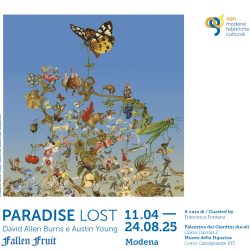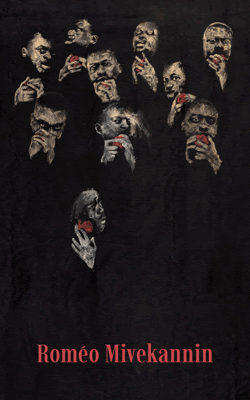[nemus_slider id=”46213″]
Quarto appuntamento con Fotografia d’avanguardia – il un ciclo di piccole mostre e incontri con cadenza settimanale ospitato alla Boss Gallery di La Spezia e a cura di Jacopo Benassi e Carlo Madesani -, con il progetto fotografico di Mario Dondero. Per conoscere le mostre passate: Fotografia d’avanguardia a La Spezia Ugo La Pietra, Ritratti d’artista di Maria Mulas; Tano D’Amico – Fotografia d’Avanguardia
Per il calendario completo degli appuntamenti
Scatti amorosi — Mario Dondero
Testo di Angela Felice
Negli anni Sessanta Pasolini non è più uno sconosciuto professorino dal passato scabroso, espulso nel 1950 dall’amato microcosmo friulano e trapiantato a Roma, a sopravvivervi con mezzi di fortuna. Con febbrile caparbietà, ha già risalito la china di una strada dapprima, per lui, tutta in salita e da subito costellata di attacchi denigratori, supportati anche da un pervicace accanimento processuale.
E’ ormai uno scrittore affermato, uno sceneggiatore e un critico letterario militante. Nel 1954 ha ricapitolato e sigillato l’esperienza lirica friulana con la raccolta La meglio gioventù. Nel 1957, con le poesie de Le Ceneri di Gramsci, ha conciliato la passione ideologica marxista con la pietas per i reietti e i senza storia. Un’Italia emarginata della vergogna -altra faccia del perbenismo della “ricostruzione” piccolo-borghese del dopoguerra-, di cui aveva già tessuto una cruda descrizione nel 1955 con il romanzo Ragazzi di vita, intarsiato con sperimentalismo gaddiano di un ibrido dialettale romanesco da borgate anni Cinquanta, e presto finito sul banco degli imputati per “oscenità”, ma con l’esito paradossale di accrescere la fama di maledettismo dell’autore “diverso”.
Il 1959, poi, è l’anno del successo internazionale con il nuovo romanzo Una vita violenta (presto tradotto in undici lingue), una parabola della formazione e del riscatto del sottoproletario Tommasino, dalla opacità alla coscienza politica, e un culmine della fede pasoliniana nel marxismo, poi destinata a sfociare, erosione dopo erosione, nel tormento dilacerante della disillusione, a fronte del genocidio culturale di tutta la società italiana, fagocitata e scempiata dall’omologazione tecnocratica e consumistica. Ma nel 1960, ancora, Pasolini sistema temporaneamente la sua attività critica nei saggi di Passione e ideologia, mentre Vittorio Gassman allestisce la versione pasoliniana dell’ Orestiade di Eschilo.
Sono anni vitali e cruciali, dunque, chiaroscurati tra un’incombente e lucida riflessione sulla “fine della Storia” e uno slancio volontaristico verso l’Utopia, anni ansiosi nel cercare e costruire modalità e forme nuove di testimonianza e di intervento. E perciò sono anni di cinema, in cui, da regista, Pasolini ambisce a riversare un animus febbrile di sperimentatore linguistico e di rottura formale, dall’alto o dal basso di un’assoluta verginità tecnica, digiuno com’era di formazione cinematografica e al più attrezzato di occasionali incursioni (ma, s’immagina, quanto voraci) sui set.
E così lo cattura l’occhio morbido di Mario Dondero, magnifico fotografo della scena pubblica degli anni Sessanta, a Milano e a Roma, di cui lo “scatto”, con nonchalance spontanea, quasi refrattaria alla formalizzazione estetizzante in sé, fissa i valori affettivi e umani, nel momento stesso in cui ne restituisce una formidabile galleria documentaria: di un clima culturale, di una tensione intellettuale e politica condivisa, di una rete di relazioni interne a tutta una comunità.
Non è assorbita su di sé neanche l’icastica presenza fisica di Pasolini, con la forza del suo corpo asciutto e atletico di quarantenne e del suo volto di trasparente fisiognomica espressiva, ancora non scavato dalla livida e macerata solitudine dell’intellettuale corsaro degli anni Settanta. Anche dietro la teoria dei bellissimi primi piani (è un Pasolini al montaggio della Rabbia), si intuisce il mondo partecipe con cui egli si relaziona e che ne condivide per affinità elettive e sentimentali perfino il vissuto quotidiano. Con ipotetico montaggio per un “fotoromanzo” amorevole, i ritratti di Pier Paolo si potrebbero abbinare ai volti, parimenti caldi di intelligente umanità, dei suoi amici e sodali: la Maraini, Parise, Penna e, naturalmente, Moravia e la Betti, questi ultimi fissati in due scatti con l’amico nell’istante rilassato di una triangolare conversazione tramata di un ritmico gioco di sguardi (e di silenzi) al tavolo della trattoria “Cesaretto” in via della Croce, mitico ritrovo della cultura romana almeno fino all’epilogo degli anni Ottanta.
Tre gruppi di foto, poi, tra quelle esposte in mostra, si riferiscono a tre film, realizzati tra il 1962 e il 1963, dopo l’opera prima Accattone, in cui quel fervore fitto di dialoghi e rapporti si incanala, con concreto impegno di comunicazione visiva: La ricotta, La rabbia, Comizi d’amore.
Un pratone polveroso e desolante della periferia romana, tanto cara a Pasolini, e, sul filo di un orizzonte in avanzata incombente, minacciosi e anonimi condomìni-già casermoni stile anni Cinquanta, sono il fondale per il Golgota della Ricotta, storia di un film da girarsi sulla Passione di Cristo e specchio della società italiana in mutazione, tra l’imminente estinzione del mondo arcaico dei “poveri cristi” sottoproletari e l’indolente sopravvivenza della classe borghese, incline al cinismo tattico di un gattopardesco trasformismo strategico. Di quel miserando baratro, che sta per inghiottire la Storia in una confusa e contraddittoria compenetrazione di tutte le classi, offrono una chiave, non solo documentaria, gli stessi scatti sul set di Dondero: con i suoi “ricconi” tirati a lucido accorsi per festeggiare l’ultimo ciak; con il Regista-Orson Welles, intellettuale ex-marxista sempre aggrappato, si direbbe, all’àncora di salvezza di pagine di libro e fogli di sceneggiatura; con la folla di romanissime comparse e maestranze in pausa, in attesa forse dell’agognato cestino; con la spettrale visione delle tre croci, su cui, per questa grottesca sacra rappresentazione (sotto accusa anch’essa per “vilipendio alla religione di Stato”), è issato Stracci, campione del Lumpenproletariat borgataro, con tutta la forza espressiva di un corpo di popolare arcaismo destinato a morte, per testimoniare la sua esistenza solo così, per tragico paradosso. A quell’affresco, acido e caricaturale, Pasolini oppone la resistenza di un’irridubile alterità, marchiata dal decoro di serietà, in cui anche la cravatta pare investirsi di valore significante.
E tale, con un’apparenza “borghese” di non corriva connivenza, perfino più marcata dall’eleganza della giacca tweed, Dondero lo fissa anche alle prese con la moviola della Rabbia, primo esperimento in campo documentaristico (poi in accesa polemica con il co-autore Giovanni Guareschi), velocemente ritirato dopo le prime proiezioni dell’aprile 1963. Con montaggio per opposizioni dialettiche da spezzoni di vecchi cinegiornali e con intenzioni dichiarate di “saggio ideologico e poetico”, Pasolini vi sferrava un’implacabile denuncia della deriva feroce, guerrafondaia, irresponsabile e mercificata dell’Italia borghese attirata nel dopoguerra dal modello americano, ivi compreso il “comunismo conformista” delle Nomenklature e delle giovani generazioni, ma contrapponendovi insieme la necessità dell’Utopia e la prospettiva della Rivoluzione delle coscienze, la sola praticabile. Un magma per visioni di ribollente polemica che, nelle immagini di Dondero, Pasolini pare affrontare alla moviola con sospesa, trasognata, quasi serafica enigmaticità, appena schiarita a tratti da una piega fragile di sorriso mite e malinconico.
E poi Comizi d’amore, semiserio spaccato del 1964 dell’Italia del boom (da Nord a Sud, in città e in campagna), scandagliato attraverso interviste sul campo nei suoi cliché e nei suoi atavici pregiudizi intorno al tema del sesso, allora emblematica cartina di tornasole del tabù. Sull’arenile di Viareggio, sullo sfondo di una schiera di ombrelloni da ferie di massa, Pasolini guarda il suo fotografo amico (e noi) con un sorriso sornione, di ammiccante e divertita complicità, sicuro nella postura fisica, si direbbe, modernamente sportiva, da “Socrate sulla spiaggia”, come chiosa benissimo Federico De Melis.
Piace chiudere con questo “scatto” quasi scanzonato di Dondero, a contrappeso di altre immagini di anni successivi (fornite da altri maestri della fotografia), fino a quell’ultimo flash da obitorio e da cronaca nera – atroce – su un corpo quasi irriconoscibile, massacrato, sconciato, brutalmente messo a tacere il 2 novembre di trentacinque anni fa.
Alla “disperata vitalità” del Pasolini combattivo degli anni Sessanta, e alla categoria del “rifiuto”, non controllabile né condizionabile, da lui fatta anche carne viva, la mostra Scatti per Pasolini è dedicata. Anche con riconoscenza al cuore puro, e all’occhio leggero, di Mario Dondero, che dell’amico Pier Paolo ha saputo cogliere, e ci consegna, spiragli vividi di verità, incantati e decantati da una condivisa irregolarità esistenziale e intellettuale.


Cerco nel mio cuore, solo ciò che ha!
A questo mi son ridotto: quando
scrivo poesia è per difendermi e lottare,
compromettendomi, rinunciando
a ogni antica mia dignità: appare,
così, indifeso quel mio cuore elegiaco
di cui ho vergogna, e stanca e vitale
riflette la mia lingua una fantasia
di figlio che non sarà mai padre.
Eccomi nel chiarore di un vecchio aprile,
a confessarmi, inginocchiato,
fino in fondo, fino a morire.
Ci pensi questa luce a darmi fiato,
a reggere il filo con la sua biondezza
fragrante, su un mondo, come la morte, rinato.
Poi… ah, nel sole è la mia sola lietezza…
quei corpi, coi calzoni dell’estate,
un po’ lisi nel grembo per la distratta carezza
di rozze mani impolverate…le sudate
comitive di maschi adolescenti,
sui margini di prati, sotto facciate
di case, nei crepuscoli cocenti…
………………………………………………….
Ma in che cosa sperano? che raggio
di luce li colpisce, in quella faccia
dove l’attaccatura dei capelli
alla fronte, i ciuffi, le onde sono grazia
più che corporea?… Dolcemente ribelli,
e, insieme, contenti del futuro dei padri:
ecco che cosa li fa così belli!
Anche i torvi, anche i tristi, anche i ladri
hanno negli occhi la dolcezza
di chi sa, di chi ha capito: squadre
ordinate di fiori nel caos dell’esistenza.
In realtà, io, sono il ragazzo, loro
gli adulti. Io, che per l’eccesso della mia presenza,
non ho mai varcato il confine tra l’amore
per la vita e la vita.
( )Il mio amore
è solo per la donna: infante e madre.
Solo per essa, impegno tutto il cuore.
Per loro, i miei coetanei, i figli, in squadre
meravigliose sparsi per pianure
e colli, per vicoli e piazzali, arde
in me solo la carne. Eppure, a volte,
mi sembra che nulla abbia la stupenda
purezza di questo sentimento. Meglio la morte
che rinunciarvi! Io devo difendere
questa enormità di disperata tenerezza
che, pari al mondo, ho avuto nascendo.
Io sono un uomo libero! Candido cibo
della libertà è il pianto: ebbene piangerò.
Sesso, morte, passione politica,
sono i semplici oggetti cui io do
il mio cuore elegiaco… La mia vita
non possiede altro. Potrei domani,
nudo come un monaco, lasciare la partita
mondana, cedere agli infami,
la vittoria… Non avrebbe perso
nulla, certamente, la mia anima!
Rimane l’inclinazione allo scisma:
un naturale bisogno di farmi male alla ferita
sempre aperta. Un configurare
ogni rapporto col mondo che a sé m’invita,
al rapporto del mio figliale
sadismo, masochismo: per cui non sono nato,
e sono qui solo come un animale
senza nome: da nulla consacrato,
non appartenente a nessuno,
libero d’una libertà che mi ha massacrato.
Morirò senza aver conosciuto il profondo
senso d’esser uomo, nato a una sola
vita, cui nulla, nell’eterno, corrisponde.
Ma se guardo intorno questi avanzi
d’una storia che da secoli ha dato
soltanto servi… questa Apparizione
in cui la realtà non ha altro indizio
che la sua brutale ripetizione…
Ebbene: sono felice della mia mostruosità.
O vogliamo ingannare lo spirito? Uomini
che condannano uomini, in nome del nulla:
perché le Istituzioni sono nulla, quando
hanno perso ogni forza, la forza fanciulla
delle Rivoluzioni – perché nulla
è la Morale del buon senso, di una
comunità passiva, senza più realtà.
I miei amori –
griderò – sono un’arma terribile:
perché non l’uso? Nulla è più terribile
della diversità. Esposta ogni momento
– gridata senza fine – eccezione
incessante – follia sfrenata
come un incendio – contraddizione
da cui ogni giustizia è sconsacrata.
Questo può urlare, un profeta che non ha
la forza di uccidere una mosca – la cui forza
è nella sua degradante diversità.
Solo detto questo, o urlato, la mia sorte
si potrà liberare: e cominciare
il mio discorso sopra la Realtà.
Pier Paolo Pasolini, frammenti dalla sezione “La Realtà” della raccolta “Poesie in forma di Rosa”).