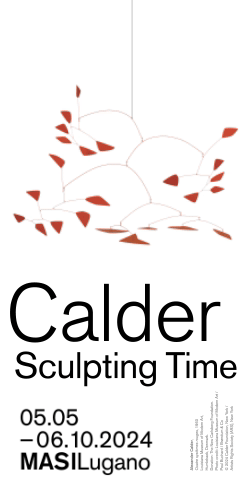[nemus_slider id=”45779″]
Fino al 11 ottobre 2015, sarà visibile al Castello di Rivoli “Made / Unmade”, la prima mostra dell’artista svizzero Uriel Orlow. L’esposizione include una selezione di opere nuove e recenti, come “Unmade Film” (2012-2013). Concepito come una serie di installazioni audio-visive, opere su carta e fotografie, Unmade Film prende la forma di un film impossibile, frammentato nelle sue parti costitutive: storyboard, fotografie, fotogrammi, colonna sonora, musica, titoli di coda, etc. “Made / Unmade” si sviluppata in tredici sale storiche del Castello di Rivoli creando un continuo dialogo tra alcune tra le più importanti opere dell’artista, che spaziano da “1942 (Poznan)” (1996-2002) fino alla serie attuale di lavori al neon “La storia è il futuro / Il Futuro è storia” (2013-2015) per finire con il più recente progetto “Grey, Green, Gold” (2015).
“Evitando una rappresentazione narrativa diretta, le opere di Orlow spingono i visitatori a colmarne delle lacune e a impegnarsi in un dialogo con la realtà attuale e con il ruolo che la nostra consapevolezza storica può avere nella costruzione, nel nostro stesso presente, di un futuro differente”, scrive la curatrice Marcella Beccaria.
Costruita mettendo in opera un’ampia varietà di registri visivi e modalità narrative, la mostra ci accoglie attraverso un percorso costellato nel quale micro-narrative e intenzionali punti ciechi rimandano a più ampi contesti storici.
Segue un’intervista con l’artista.
ATP: Come ha avuto inizio l’opera articolata e complessa “Unmade Film” (2012-2013)? Da cos’è nata l’idea iniziale?
Uriel Orlow: Ho deciso di fare un film su un luogo specifico vicino a Gerusalemme: il villaggio palestinese di Deir Yassin, che è stato distrutto nel 1948 durante un massacro molto significativo che ha contribuito all’esodo palestinese. Centinaia di migliaia di palestinesi sono fuggiti dopo questo avvenimento. Tre anni dopo, nello stesso luogo, si è stabilito un ospedale psichiatrico israeliano per il ricovero dei sopravvissuti all’Olocausto. Una mia prozia, che è sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz ed è finita a Gerusalemme dopo la guerra, fu internata in questa clinica negli anni ’50, dopo un esaurimento nervoso. È rimasta lì fino agli anni ’80 quando è morta. Da bambino andavo a trovarla lì ma non sapevo niente della storia violenta del luogo. Quando l’ho scoperta qualche anno fa, ho sentito l’esigenza di dovermi impegnare nei confronti di questa storia difficile.
ATP: Perché hai sentito il bisogno di dividere l’opera in un’installazione composta da lavori su carta, fotografie e parti audiovisive?
UO: La doppia storia, e il doppio trauma di questo luogo, ci presentano subito un’aporia morale: non si può paragonare un trauma o un dolore ad un altro. Sarebbe sbagliato paragonare l’Olocausto e la Nakba. Per questo motivo, sembrava impossibile contenere questi due traumi in un’opera e il progetto del film è crollato; si è letteralmente frantumato in pezzi. La seconda ragione ha a che fare con il concetto di catarsi. Dal momento che il trauma non è completamente finito – l’ospedale psichiatrico e l’occupazione sono ancora lì – non volevo creare un lavoro ‘chiuso’ che potesse produrre una sorta di catarsi. Con catarsi intendo un senso di sollievo, che si attiva quando si affronta una storia traumatica e, infine, ci si sente liberati da essa come uno spettatore. Questa è la strategia adottata dalla maggior parte dei film sulla guerra, sull’Olocausto e su altri traumi. Si vive attraverso questi traumi e se ne esce sentendosi quasi purificati da quest’esperienza terribile, perché se ne esce vivi ed è tutto finito. Non volevo creare questo tipo di effetto, o qualche tipo di riserbo. Ovviamente ci sono delle strategie per evitarlo perfino all’interno di un singolo lavoro, ma per me è stato importante riconoscere l’andamento del trauma e non circoscriverlo ad un’unica opera. Così ho finito per lavorare su diversi elementi di un film, la sceneggiatura, lo storyboard, la colonna sonora, l’allestimento, i titoli di coda…. ma non c’è nessun film vero e proprio. Gli spettatori devono ricostruirlo nella loro mente.
ATP: La tua ricerca è inframmezzata da numerose storie. È come se ogni pezzo rivelasse o approfondisse un importante evento storico. Sto pensando all’opera sulla storia del fiore chiamato Mandela. Quali criteri hai usato per scegliere quest’importanti eventi storici?
UO: In realtà, molto del mio lavoro tratta di eventi piccoli o dimenticati, siti invisibili che indirettamente fanno riferimento a contesti storici più grandi. Non mi sento di aver scelto quelle storie o quei luoghi ma piuttosto che loro hanno scelto me. Qualcosa cattura la mia attenzione quando m’imbatto in loro. E ancora più importante, si connettono a qualcos’altro. Quindi, nel caso del fiore che è stato chiamato Mandela’s Gold nel 1994, quello che mi interessava era che il fiore fosse stato allevato per quasi vent’anni presso il South African Botanical Garden a Città del Capo, mentre Mandela era in carcere proprio vicino a Robben Island. Il seme che è esposto nella mostra si riferisce a un nuovo inizio, una nuova era dopo l’apartheid. Ma porta dentro di se anche un riferimento al tempo: quello trascorso in prigione. E mentre Mandela era in prigione, lui e i suoi compagni prigionieri politici hanno creato un giardino nel cortile del carcere. Questo giardino ha giocato un ruolo importante; ad esempio, la biografia di Mandela – Lungo Cammino Verso la Libertà – che ha scritto in carcere, è stata sepolta lì. Quindi vi è una connessione tra piante e storia, piante come testimoni della storia, silenziose ma eloquenti.
ATP: Potresti dirmi a cosa si riferisce il titolo Made/Unmade?
UO: Il titolo Made/Unmade si riferisce a una dialettica. La storia non è solo in costruzione ma è anche in decostruzione. Alcune storie vengono raccontate mentre altre rimangono non dette. Il titolo, però, allude anche a strategie all’interno del mio lavoro: costruire e decostruire narrazioni, mostrare le immagini ma anche essere consapevole dei limiti e dei divari della rappresentazione.
ATP: Al giorno d’oggi, l’arte sta diventando sempre più una sorta di attività collegata all’intrattenimento. La proliferazione di biennali, ma soprattutto di fiere d’arte in tutto il mondo, in qualche modo ha privato l’arte della sua capacità di ‘smuovere’ le coscienze. Pensi che l’arte sia ancora in grado di raccontare eventi traumatici contemporanei? O pensi che ora sia diventato ‘impossibile’?
UO: Come artista ancora credo nel potere dell’arte per ampliare la nostra coscienza, la nostra visione del mondo. Con l’accelerazione delle immagini nei mezzi di comunicazione e la diffusione di una cultura visiva consensuale, di breve durata e basata su eventi, molto rimane inosservato, trascurato o dimenticato. Quindi penso che ci sia un bisogno ancora più urgente di produrre immagini di storie non raccontate, storie nascoste, traumi repressi; anche di produrre immagini che operino in un’economia visiva diversa: immagini lente, immagini simili a fantasmi, immagini che ci raccontano qualcosa sulla presenza e sull’assenza, immagini che ci ricordano adesso di attività incompiute del passato.
Traduzione dall’inglese di Gabrio Micheli.

Uriel Orlow: Made / Unmade
curated by Marcella Beccaria
Castello di Rivoli, until 11 October 2015
Castello di Rivoli presents Uriel Orlow: Made / Unmade, the artist’s first exhibition in an Italian museum. In his work, Orlow engages with the way the past emerges and lives on in the present and often repeats itself, questioning linear chronology. “Avoiding direct narrative representation, Orlow’s works prompt each visitor to fill in the gaps and engage in a dialogue with the current reality, and with the role our historical consciousness can have in shaping a different future in our own present”, says curator Marcella Beccaria.
In Uriel Orlow: Made / Unmade the artist brings different image-regimes and narrative modes into correspondence and prompts blind-spots and micro-narratives to reverberate in larger historical contexts.
Interview with the artist.
ATP: How did the articulated and complex piece “Unmade Film (2012-2013) start? How did you get the first idea for it?
Uriel Orlow: I set out to make a film about a specific place near Jerusalem: the Palestinian village Deir Yassin that was destroyed in 1948 in a very significant massacre that contributed to the Palestinian exodus. Hundreds of thousands of Palestinians fled after this event. Three years later, in the same place, an Israeli psychiatric hospital was established, to treat Holocaust survivors. A great aunt of mine, who survived the concentration camp Auschwitz and ended up in Jerusalem after the war, was interned in this clinic in the 1950’s after a breakdown. She stayed there until the 1980’s when she died. As a child I visited her there but didn’t know anything about the violent history of the place. When I found out a few years ago, I felt an urgency to engage with this difficult history.
ATP: Why did you feel the need to divide the piece into an installation composed by works on paper, pictures and audio-visual parts?
UO: The double history, and the double trauma of this place, immediately presents us with a moral aporia: you cannot compare one trauma or suffering with another. It would be wrong to compare the Holocaust and the Nakba. For this reason, it seemed impossible to contain these two traumas in one work and the planned film fell apart; literally splintered into fragments. The second reason is to do with the notion of catharsis. Since the trauma is not really over – the psychiatric hospital and the occupation are still there – I did not want to produce a closed work which could produce some kind of catharsis. By catharsis I mean a sense of relief, which is triggered when you encounter a traumatic history and eventually get released from it as a viewer. This is the strategy employed by most films about war, the Holocaust or other traumas. You live through these traumas and come out feeling almost cleansed from this terrifying experience, because you come out alive and it is over. I did not want to produce this kind of effect, or some kind of containment. Obviously there are strategies to avoid this even within a single work, but for me, it was important to acknowledge the ongoingness of the trauma and not containing it in a single work. So I ended up working on different elements of a film, the script, the storyboard, the score, the staging, the closing credits…. but there is no actual film. The viewers have to put it together in their mind.
ATP: Your research is punctuated by several stories. It’s like if every piece unraveled or expanded an important historical event. I’m thinking about the artwork about the history of the flower named Mandela. Which criteria did you use to choose these important historical events?
UO: Actually, a lot of my work is about small events or forgotten, invisible sites that obliquely refer to larger historical contexts. I don’t feel that I chose those stories or places but rather that they chose me. I come across them and something arrests my attention. And more importantly it connects to something else. So in the case of the flower which was named Mandela’s Gold in 1994, what interested me was that the flower was bred for almost twenty years at the South African botanical garden in Cape Town, during which time Mandela was actually in prison nearby on Robben Island. The seed, which is exhibited in the show refers to a new beginning, a new era after apartheid. But it also carries within it a reference to time; time spent in prison. And while Mandela was in prison, he and his fellow political prisoners created a garden in the prison courtyard. This garden played an important role, for example, Mandela’s biography – Long Walk to Freedom – which he wrote in prison was buried there. So there is a connection between plants and history, plants as silent yet eloquent witnesses of history.
ATP: Could you tell me what the title Made/Unmade refers to?
UO: The title Made/Unmade refers to a dialectic. History is not just in the making but is also being unmade. Stories are told while others remain untold. But the title also alludes to strategies in my work: constructing and deconstructing narratives, showing images but also being mindful of the limits of representation, the gaps.
ATP: Nowadays, art is becoming more and more a sort of entertainment-related business. The proliferation of Biennals, but especially of art fairs all around the world, somehow deprived art of its capability of “moving” consciences. Do you think art is still able to tell traumatic contemporary events? Or do you think now it became “impossible”?
UO: As an artist I still believe in the power of art to enlarge our consciousness, our vision of the world. With the acceleration of images in the media and the proliferation of a short-lived, event-based and consensual visual culture, a lot remains unnoticed, overlooked or forgotten. So I think there is an even more urgent need to produce images of untold stories, hidden histories, repressed traumas; also to produce images which operate in a different visual economy: slow images, images that are close to ghosts, images that tell us something about absence and presence, images that remind us in the present about unfinished business from the past.