
Aurelio Andrighetto: Appoggiando la fotocamera sul diaframma colleghi lo sguardo al respiro che noi, imbevuti di cultura greca e latina, possiamo intendere come πνεῦμα-pnệuma, soffio o principio vitale. Attraverso questa postura insuffli vita nell’immagine fotografica, la rianimi come una volta si rianimavano le creature nei santuari del respiro. In questi santuari (à répit) disseminati in varie località alpine i bambini nati morti potevano essere riportati simbolicamente in vita per il breve istante di un respiro, il tempo necessario per essere battezzati. Nell’altrettanto breve istante di un click rianimi l’immagine fotografica.
I tuoi à répit fotografici sono paesaggi aurorali e crepuscolari che si espandono lungo un orizzonte visto dall’altezza del muscolo diaframma, che si alza e abbassa nel respiro unendo il corpo al paesaggio, il dentro al fuori. TU ed IO, come nell’installazione permanente Atto unico – campane, che hai inaugurato ieri (5 ottobre 2024) nel Bosco della Nova a Mondovì (a cura di landandart in collaborazione con Associazione Arte Continua) , dove la linea circolare che gira intorno a una delle campane è l’orizzonte che unisce. Unisce l’IO al TU suscitando una sensazione di fusione, ma anche di smarrimento.


La sensazione di perdersi in questo orizzonte che si dilata all’infinito mostra delle analogie con quella di Quinn nella Trilogia di New York di Paul Auster: «New York era uno spazio inesauribile, un labirinto che si snodava infinito sotto i suoi passi e nel quale, ogni volta, anche senza spingersi troppo lontano dai paraggi ben noti di casa propria, veniva sopraffatto da un senso di totale smarrimento: perso alla fine, non solo nella città, ma anche dentro di sé». Con un semplice gesto fotografico ti perdi nel paesaggio e al tempo stesso dentro di te attraverso un respiro che diventa immagine.
Questa tua postura fotografica, che chiama prepotentemente in causa il corpo, potrebbe essere interpretata nel senso proposto da Hans Belting, secondo il quale «il corpo rimane l’anello di congiunzione nel quale si incontrano tecnica e coscienza, mezzo e immagine» (Antropologia delle immagini, Carocci editore, Roma 2011, p. 41). Il corpo diventa il luogo dove l’immagine si forma controllando il respiro, così come si controlla l’apertura del diaframma fotografico.
La geometria ottica della fotocamera deve molto alla prospettiva lineare, e il tuo posizionarla all’altezza del diaframma anziché a quella dell’occhio, come nella piramide visiva di Leon Battista Alberti, tradisce un probabile rapporto geometrico con il corpo dell’Uomo vitruviano, un disegno a matita e inchiostro su carta conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Mi riferisco al controverso circini centrum vitruviano, frainteso come oculi centrum della prospettiva rinascimentale. L’aver creduto che il circini centrum di Vitruvio fosse lo stesso oculi centrum della prospettiva lineare ha tratto in inganno alcuni traduttori e commentatori del De architectura. Il circini centrum è il centro di un cerchio tracciato con il compasso, nel contesto di un disegno icnografico e ortografico (non prospettico), forse lo stesso centro del cerchio nel quale è inscritto l’Uomo vitruviano disegnato da Leonardo da Vinci e ancor prima da Giacomo Andrea da Ferrara (Enrica Battifoglia, Elisa Buson, Leonardo scienziato, Hoepli, Milano 2019). Mi piace pensare che il tuo portare la fotocamera sul diaframma (prossimo al centro del corpo nei disegni di Andrea da Ferrara e Leonardo) sia un modo d’integrare la rappresentazione prospettica con altre geometrie non prospettiche, e neppure euclidee, che disegnano l’orizzonte in modo diverso (mi riferisco all’oriciclo, alla curva che hai disegnato su un’altra campana dell’installazione permanente).
Tutt’altra questione è invece l’aspetto orientale della metamorfosi di cui mi hai parlato, una mutazione che sembra trovare una corrispondenza con l’estensione semantica del temine greco dal quale siamo partiti: pnệuma, tradotto da Ovidio con il termine latino spiritus: «Tutto muta, nulla muore. Lo spirito è errabondo» (Ovidio, Metamorfosi XV, 165-170).
Tutto muta anche nel fluire di questi pensieri.
GO – Proprio da Ovidio… Finisci lì dove forse è la mia partenza. Per me più che un dare respiro all’immagine è un respirare vita (energia). Inspirare. Quando lasci entrare raccogli tutto ciò che è fuori e ti nutre, non c’è più spazio tra io e orizzonte, tra te e il tutto.
Penso sempre al materiale sensibile, alla pellicola, al film che ha la sua gelatina. Noi siamo altrettanto sensibili. Allora respirare mentre il diaframma è aperto crea una connessione. Mi sono reso conto ora che il termine diaframma si usa sia per l’obiettivo fotografico che per il muscolo che ci fa respirare… curioso. Noi siamo materiale sensibile come lo è la pellicola o il CCD, poco importa.
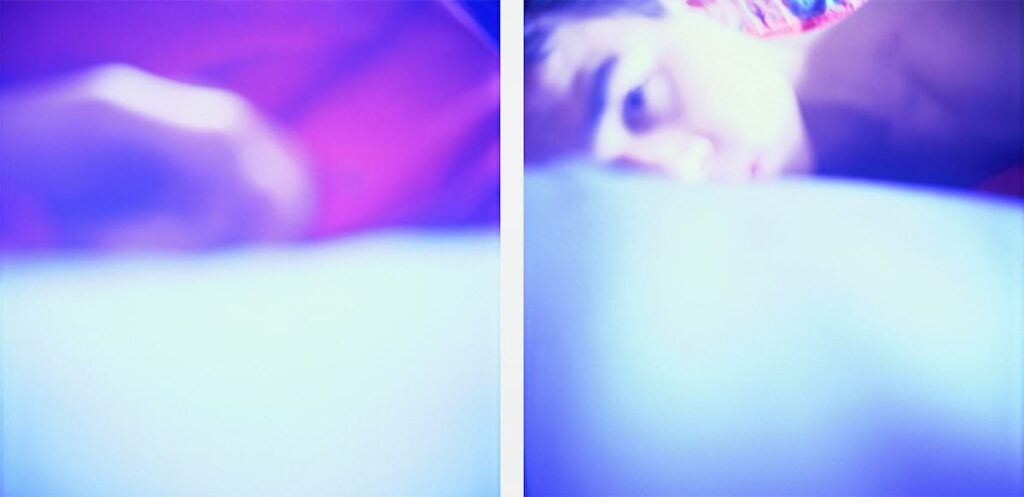
AA – La tua sensibilità si unisce a quella della pellicola, o del CCD (che traduce i fotoni in impulsi elettrici) in relazione alla luce, non solo a quella descritta dalla fisica, ma anche quella di cui scrive Plotino, ma di questo abbiamo già parlato in una conversazione precedente.
Già nelle tue prime fotografie scattate alla fine degli anni Novanta, che potremmo considerare dei selfie ante litteram, i bordi delle cose svaniscono nella luce. In queste immagini (tu non le consideri fotografie) scattate con una fotocamera Lubitel 166B, caricata con pellicole scadute, rivolgi lo sguardo verso di te. È quello che tutto sommato continui a fare ancora oggi perdendoti nel paesaggio così come in te stesso.
GO – Ognuno di noi ha due orizzonti con cui confrontarsi. L’opera per me è il punto di contatto tra questi due orizzonti. Ieri sera mi sono addormentato tardi e per evitare di rimuginare mi sono alzato e sono andato a guardare le immagini che si sono cristallizzate durante l’alba del mercoledì scorso. Ho dormito a Taormina invece che sull’Etna proprio per essere già sul confine tra acqua e terra, tra buio e luce. La mia predisposizione c’era, grazie anche a Maria Angela che mi ha indicato quei luoghi. Un vero regalo. Insomma, ieri sera riguardavo queste immagini e mi sono reso conto che la tensione che si prova guardando nelle immagini prima dell’alba non è presente nelle immagini che la seguono. Dopo è un tripudio, manifesta superiorità, una sorta di orgasmo visivo, ma prima c’è una tensione, ci sono le promesse, le ambizioni, le infinite possibilità di qualcosa che deve ancora avvenire.

AA – La tensione che hai provato guardando le immagini retroilluminate prima dell’alba, l’attesa di una luce promessa nel buio ha radici in un’esperienza percettiva di soglia, restituita dal video della saracinesca che si alza e si abbassa come una palpebra, dalle tue fotografe scattate dai bunker e anche dai tuoi crepuscoli. Al crepuscolo serotino la visione fotopica (diurna) trascorre in quella scotopica (notturna) e viceversa al crepuscolo mattutino. Nella fase intermedia (mesopica) i due sistemi percettivi interagiscono tra loro provocando una singolare tensione, che potrebbe avere un rapporto con le esperienze di fotismo notturno raccontate in Ša‘are sedeq (Le porte della giustizia), attribuito a Rabbi Natan ben Sa‘adyah Har’ar, e ai racconti di Shaykh al-ishrāq, che Henry Corbin ha raccolto nel saggio Corpo spirituale e Terra celeste. Ho l’impressione che la tua opera sia il tentativo di dare forma a questa soglia, dove la tensione è massima, e farne un luogo da abitare con quella parte di noi che si risveglia attraverso la contemplazione di alcune immagini, come quelle esposte allo stand di Continua ad Artissima 2024 che mi hai mostrato ieri (31 ottobre 2024).

GO – Sono strutture temporanee, immagini che prendono corpo come se l’acqua potesse condensarsi rimanendo un fluido, senza trasformarsi in ghiaccio, perché l’immagine continua a vibrare, in una condizione di movimento costante.
AA – Sono opere che invitano alla prensione. Hanno un appeal tattile che porta la fotografia dentro la scultura. Sono maneggevoli e portatili come i dispositivi mobili, di cui hanno la stessa forma e affordance (la caratteristica fisica di un oggetto che suggerisce all’utente le “possibilità di azione”). Per questa analogia con i dispositivi mobili, le tue ultime opere invitano anche a riflettere sulla fotografia divenuta funzione integrata in varie tecnologie, nonché espressione dell’essere sociale in un contesto comunicativo dove l’immagine fotografica è segno di connettività e motore di un processo di tipo ipermediale. Fotografia espansa dunque, non solo per il suo sconfinare nella scultura, ma anche per la riconfigurazione del suo utilizzo nell’ambito postmediale, dove il medium perde la sua specifica caratteristica, dissolvendosi nei sistemi intermediali di comunicazione, controllo e intrattenimento.
La tua opera è un crogiolo in cui la fotografia si fonde con la geometria non euclidea, i santuari del respiro con la New York di Paul Auster, il circini centrum di Vitruvio con l’affordance di James Gibson, l’antropologia delle immagini di Hans Belting con la scritta al neon dell’installazione ambientale site-specific LEA – Lead ExclusiveArea, realizzata per la mostra Metacosmo a Torino (Teatro Ragazzi e Giovani) https://www.galleriacontinua.com/news-detail/metacosmo-1147, che risplende come la luce sprigionata dalle lettere nelle permutazioni della Qabbalah teosofica di Rabbi Natan ben Sa‘adyah Har’ar, una luminosità crepuscolare che «non era come la luce che emana dal sole, ma era come la luce del giorno, che è la luce dell’alba prima che il sole sorga» (Le porte della giustizia, Adelphi, Milano 2001, p. 181). Forse è la stessa luce promessa nel buio di cui mi avevi parlato, la stessa della scritta al neon: un’eclissi di Sole che ti ha fatto pensare al «Sole dentro». Sempre nel Ša‘are sedeq si legge «[…] vidi che essa [la luce] proveniva da me stesso. Dissi tra me: “non ci credo”. Cominciai a girare per tutta la casa, ed ecco, essa [la luce] si muoveva con me» (p. 180). Chissà se il tuo «Sole dentro» ha un rapporto con un dentro che si espande e si rovescia fotograficamente nel fuori attraverso un respiro.

GO – Ancora devo capire cosa ho fatto… Questi lavori che ieri (9 novembre 2024) ho presentato nello spazio del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, sono nati dalla tensione della quale ti dicevo, quella provata guardando dentro i due orizzonti di cui ti parlavo. Ieri durante il tempo trascorso nello spazio credo di aver intuito cosa ho fatto. Ho portato un cielo dentro la sala nera del teatro, la quarta parete non c’era più, e neanche la quinta, quella del soffitto, perché ho portato un cielo all’interno. Un cielo con le sue stelle, che invadono lo spazio e lo riempiono creando un’apertura. Il cielo è il nuovo nostro orizzonte, un orizzonte sul nostro nuovo ignoto, l’immensamente grande che ora iniziamo a guardare e studiare, siamo appena arrivati alle colonne d’Ercole dell’universo. Al tempo stesso, fin dalla prima notte, le stelle, sono state strumento per capire dove siamo, e indicano il cammino. Ogni stella sembra identica all’altra proprio come noi, ma ognuna è infinitamente unica, come siamo noi. Le stelle, gli astri formano dei sistemi, delle costellazioni proprio come quando nella nostra unicità ci avviciniamo agli altri e creiamo un noi.
Mi risulta difficile pensare a questa opera come una fotografia, ma l’immagine nasce da uno scatto, che ho fatto sul Teide, vicino agli osservatori.
In questo organismo creato nella sala del teatro, le campane sono il punto di riferimento. Io sono qui! Sono campane di navi che hanno viaggiato, di navi che hanno fatto naufragio, o che sono state smantellate. È obbligatorio averle a bordo se ci allontaniamo oltre le 12 miglia e nel caso di nebbia si devono suonare per indicare la propria posizione. Vengono chiamate Fari sonori. Un giorno ho iniziato a incidere su di loro quanto mi è stato detto dagli abitanti del District Six, a Cape Town a proposito dei loro desideri e paure, le due energie che quotidianamente si confrontano. Le campane continuano a suonare la loro nota pur avendo cambiato funzione. Ma continuano a dire io sono qui.
Il neon, ovvero il «Sole dentro», come lo avevo chiamato in un messaggio, è effettivamente l’altro orizzonte, quello dentro di noi. Illuminarsi rompendo l’eterno ritorno, lo pensai nel 2012, ed era scritto dalla luce. Anche in quel caso l’opera si era manifestata in immagine, e l’unico corpo giusto per quelle parole era fatto di luce, di neon.
Cover: Giovanni Ozzola, LEA – Lead ExclusiveArea, 2024. Veduta dell’installazione ambientale site-specific realizzata per la mostra Metacosmo a Torino (Teatro Ragazzi e Giovani). Courtesy dell’artista








