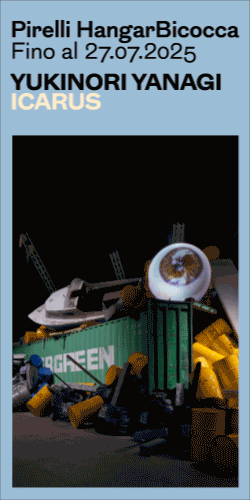La 21° intervista dedicata alla fotografia contemporanea ha per protagonista Vaste Programme, il collettivo composto da Leonardo Magrelli, Alessandro Tini e Giulia Vigna.
Mauro Zanchi / Sara Benaglia: Cosa è emerso in The Long Way Home of Ivan Putnik, Truck Driver?
Vaste Programme: Come in ogni lavoro che ragioni sul ritrovamento di fotografie, che siano vecchi scatti o immagini immateriali presenti su internet, la prima questione che emerge è il fatto fotografico stesso. Uno degli aspetti più interessanti delle immagini infatti è che quando le guardiamo non sono mai inerti, esse reagiscono al contesto in cui si trovano e producono nuovi significati. Accostando una fotografia a un’altra, esse si influenzano a vicenda, e inserendole in una serie succedono altre cose ancora. Nel nostro approccio ci siamo serviti di pratiche già ampiamente in uso, provando però a combinarle tra loro. Da qui nasce l’idea di fondere i processi di adozione, rimessa in circolo e risignificazione delle immagini con quello della vero-fiction, dando vita al diario visivo che traccia la storia del lungo ritorno a casa di Ivan Putnik. Lo strumento del racconto è servito a fare da collante al materiale fotografico e a far affiorare, dallo sfondo della narrazione, ulteriori questioni degne di nota. Nonostante il lavoro nasca dal puro piacere di continuare a meravigliarsi di fronte alle immagini, e non abbia alcun intento di denuncia, sono emerse comunque questioni che si potrebbero definire ambientali e politiche. Gasdotti, porti, miniere, sfruttamento incontrollato delle risorse e spostamento di merci e materiali. Tutte questioni che ci riguardano.
MZ / SB: Archivio fotografico, verofiction, diario di viaggio. Come avete intrecciato la narrazione di un altro sguardo con la vostra poetica?
VP: Durante l’editing dell’immensa mole di fotografie da cui siamo partiti, abbiamo iniziato a domandarci se il fascino di certi paesaggi, o la malinconia suscitata da quelle città, venissero subiti anche da chi scattava la foto. Ci siamo chiesti quali fossero le personali esigenze nel raccontare quei luoghi, se fossero condivise con le nostre e in che misura, ragionando così sulle intenzioni e i fini che si celano dietro una fotografia. Attraverso l’editing, il taglio o la selezione di porzioni di immagine, abbiamo messo il focus sul soggetto che ci interessava guidati dal nostro punctum, intrecciando così il nostro sguardo con quello di un altro. Nel farlo, abbiamo cercato di lasciare comunque che trasparisse il punto di vista di Ivan, che potremmo definire “ingenuo e trasparente” nei riguardi di ciò che si trova davanti, auspicando che i nostri stessi dubbi e ragionamenti si insinuassero nella percezione dello spettatore.
MZ / SB: Nessuna immagine visibile giunge a noi se non attraverso un medium? La fotografia attuale riesce a rendere visibili immagini che sono nel nostro immaginario più recondito? O perlopiù restituiscono ancora (come la fotografia tradizionale) solo porzioni particolari e determinate di mondo?
VP: Ci sembra abbastanza certo che per rendere un’immagine visibile agli altri ci sia sempre bisogno di un medium. Oggi forse la vera difficoltà è quella di decifrare lo scarto tra il medium su cui le immagini vengono concepite, e il mezzo sul quale sono fruite, tramite il quale ci giungono. Di questo se ne potrebbe parlare a lungo.
Per rispondere al resto della domanda, si potrebbe scomodare il sempre illuminante David Campany, che di recente ha scritto che “parte della pretesa della fotografia di appartenere al mondo dell’arte consisteva nell’avere accesso a mondi oltre l’immediato. Laddove i meri fotografi erano confinati alla realtà, gli artisti che lavorano con la fotografia erano in grado di trascenderla. Ma anche così, la realtà è sempre il portale per pensieri e sentimenti più profondi, perché essa è tutto ciò che abbiamo”. Per cui, forse, la migliore risposta è che la fotografia riesce a rendere visibili immagini che sono nel nostro immaginario più recondito attraverso la restituzione di porzioni particolari e determinate di mondo. O anche, per usare le parole di Hans Belting “le immagini mentali sono inscritte in immagini materiali”.




MZ / SB: Nella vostra ricerca nel collettivo (dove tre sguardi individuali mediano tra loro qualcosa per ampliare la possibilità della visione) come trattate i tre ingredienti di Hans Belting, la triade iconologica, ovvero immagine, medium e corpo?
VP: Per Belting “Il corpo fornisce lo sguardo” e, nel nostro caso, la presenza di tre sguardi che si amalgamano rappresenta una linfa incredibilmente vitale. In un certo modo questa cosa si riflette bene in What color are your eyes?, un progetto che ci ha portato a ragionare sull’identità personale in relazione a quella collettiva, e sul tema dell’identificazione, sia in senso intimo che in una più ampia accezione politica. Il titolo infatti rimanda a una domanda ingenua che si faceva spesso da bambini, ma è anche la stessa che ci viene rivolta quando dobbiamo rifare il passaporto o documenti simili.
Tornando a Belting, si potrebbe dire che questo lavoro prenda a soggetto il corpo. Nel farlo, volevamo che l’immagine rispondesse del proprio medium, ed è stato proprio un ragionamento sulla tecnica il tramite per arrivarci. Disarticolando i meccanismi della fotografia a colori e lavorando sulla separazione della tricromia, abbiamo mischiato le lastre come cromosomi in vitro per poi assistere, con nostra sorpresa, alla nascita di queste strane figure, ibride, cangianti e incorporee.
MZ / SB: What colour are your eyes? ci ricorda una pubblicazione di Irene Fenara, in cui la stessa chiedeva a Siri di che colore fossero i suoi occhi. Che tipo di ibridazione c’è in un collettivo?
VP: Nel suo brillante lavoro, Irene Fenara poneva questa domanda volutamente paradossale, per innescare un ragionamento sullo sguardo della macchina. Nel nostro caso invece, la domanda fa riferimento al fatto che il colore degli occhi è una caratteristica fisica prettamente individuale. E dunque, in merito all’ibridazione che si crea in un gruppo, ci siamo chiesti cosa “identifichi l’identità” di un collettivo artistico. Il lavoro What color are your eyes? è servito in parte anche a rispondere a questa domanda; o meglio, a metterci la questione davanti agli occhi, per provare a capirla. La creazione collettiva infatti si è rivelata per noi un processo stupefacente quanto misterioso, in cui le proprie visioni sfumano in modo osmotico le une in quelle dell’altro, spesso senza la possibilità di ripercorrere i processi creativi a ritroso.
MZ / SB: In Game#01 la logica algoritmica da cui dipende la visualizzazione di contenuti nei social è paragonata alle mosse di un giocatore di Mikado. Quanto è rischioso scambiare il capitalismo della sorveglianza per una forma di libertà?
VP: Uno dei meccanismi del capitalismo della sorveglianza è sicuramente quello di venderci l’illusione di essere liberi. In realtà la miriade di “scelte” offerteci dagli algoritmi è modulata sulle nostre abitudini di navigazione, su quello che già sappiamo e vogliamo, rendendo così più difficile incontrare idee al di fuori dei nostri interessi.
Ciò si traduce in quel profluvio di immagini con cui veniamo quotidianamente ingozzati (forse non è un caso che si parli di feed per indicare le pagine in cui ci vengono proposte immagini su misura, già masticate per noi) e fa sì che nei siti d’informazione o nei wall dei nostri social, i contenuti risultino ammassati e difficili da gerarchizzare. In questo scroll perpetuo, le foto del nostro pianeta in fiamme occupano lo stesso spazio dei tutorial di make-up, livellando il valore di queste immagini. Il progetto installativo Game #01 non serviva solo a restituire il caos visivo di internet, ma anche a restituire il senso di ripetitività con cui gli algoritmi ci forniscono immagini nuove per gli stessi contenuti: il Mikado propone conformazioni continuamente diverse ma riarrangiando ogni volta gli stessi bastoncini. Lo scopo del gioco, nel nostro caso, è quello di invitare idealmente lo spettatore ad approcciarsi verso le immagini con la dovuta e meritata attenzione, come farebbe un giocatore mentre pesca il bastoncino, ridando loro il giusto peso, per contrastare la passività con cui ne subiamo il flusso. Concludiamo con un aneddoto. Quattro anni fa, quando ancora non ci conoscevamo, a Giulia è apparsa su Instagram una fotografia di un progetto a cui stavano lavorando Leonardo e Alessandro. Ci diverte ricordare che il nostro primo incontro sia nato grazie ad un algoritmo.


MZ / SB: Ghostbusters (2019-ongoing) è una collezione di imprecisioni umane caricate su Google Map. Qual’è il metodo di ricerca e selezione che applicate? Perché avete scelto proprio questo titolo?
VP: Da un po’ di tempo, abbiamo iniziato a lavorare in modo specifico con le fotografie sferiche che si trovano su Google Maps. Queste immagini non sono scattate dalla Google Car di Street View, bensì da utenti comuni, che poi le caricano sul server geolocalizzandole. Una differenza a nostro avviso sostanziale, poiché tali fotografie non vengono da una fotocamera programmata per scattare ogni dieci metri dal tetto di una macchina, ma sono il risultato della scelta di qualcuno di scattare una fotografia e poi condividerla. Di questo materiale abbiamo fatto uso anche in Ghostbusters, un lavoro nato più per caso e per gioco che con un intento preciso. Esplorando appunto le fotografie sferiche degli utenti di Google Maps, abbiamo incontrato numerose immagini in cui spesso chi viene ritratto rimane vittima del glitch, impigliato nell’errore, e tramutato in sembianze bizzarre da queste imprecisioni. Nell’immaginario di fantasia, i fantasmi sono spesso dotati solo della parte superiore del corpo, essendo ovviamente la più connotata. Abbiamo scelto allora di selezionare principalmente le immagini in cui fosse presente e chiara la porzione alta del corpo, cercandole in tutto il mondo. Se il sinonimo di screenshot è screengrab, noi andavamo in giro su Google maps ad afferrare questi ectoplasmi, a fare letteralmente gli Acchiappafantasmi.
MZ / SB: In Ghostbusters (2019-ongoing) perché attribuite a errore e glitch la precisione umana dell’errore?
VP: Quando un meccanismo si inceppa si rivela, e insieme rivela anche la sua imprecisione, il suo difetto, quasi umano. In sostanza, è sorprendente come spesso, quando la macchina si manifesta, lo faccia commettendo un errore, un fatto che afferisce ben più all’imperfezione umana che alla precisione della macchina. Per questo ci sembrava interessante raccogliere queste immagini, in cui i corpi si presentano smembrati, sfaldati e a volte ricomposti in modo errato, per un errore in parte dovuto al movimento del soggetto, e in parte dovuto al meccanismo con cui le fotocamere a 360° fondono insieme gli scatti per restituire l’immagine sferica. Il glitch si manifesta sul corpo delle persone, come se fossero queste ad inciampare, mentre invece è l’ingranaggio. Tutto ciò in fin dei conti è solo un altro modo per accettare l’errore e il caso all’interno del processo artistico. Non siamo chiaramente i primi, né saremo gli ultimi a farlo, tuttavia ci sembra che Ghostbusters sottolinei, pur in maniera giocosa, una sfumatura interessante del nostro rapporto con le macchine.
Per leggere le altre interviste della rubrica New Photography ☞