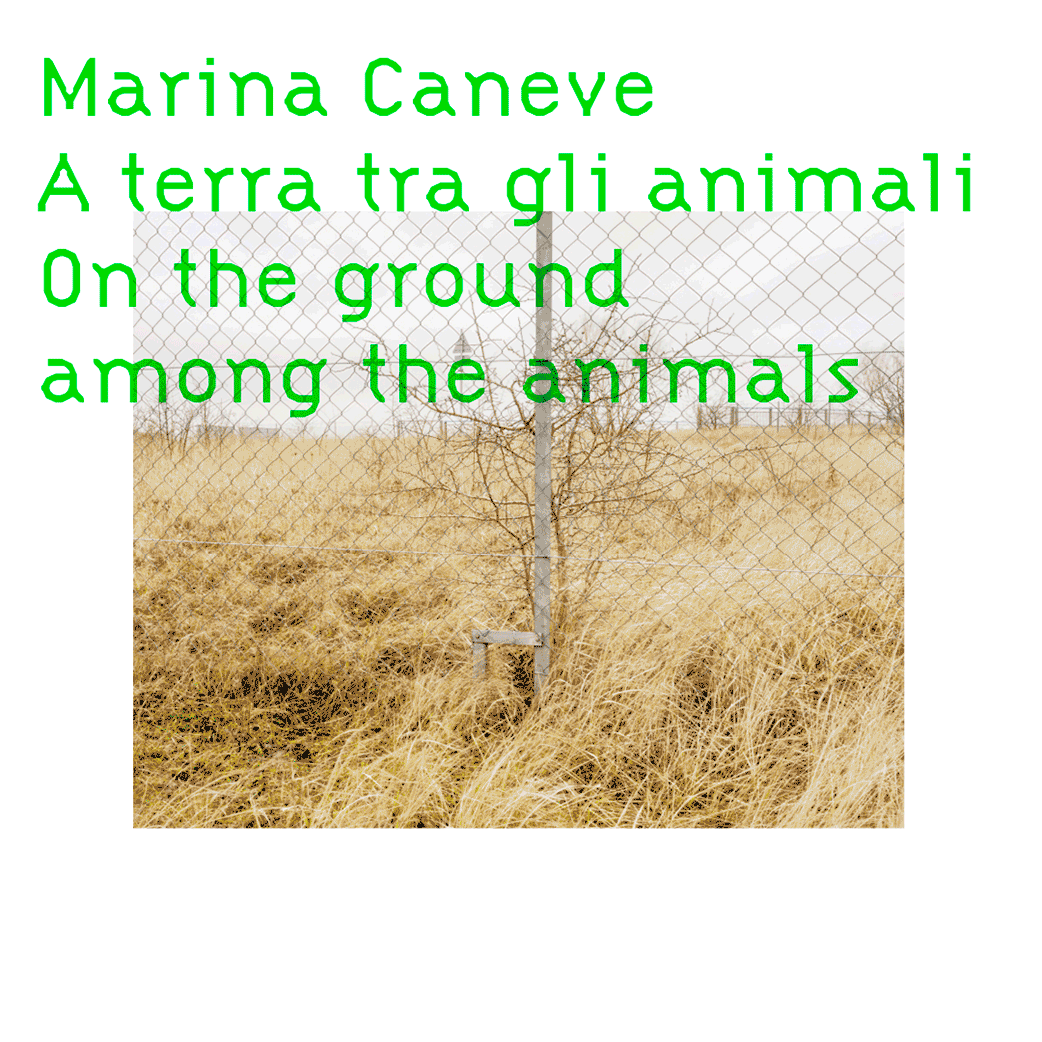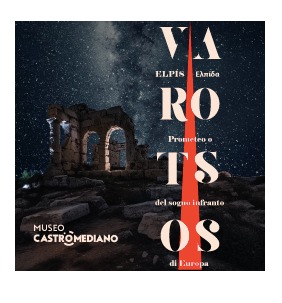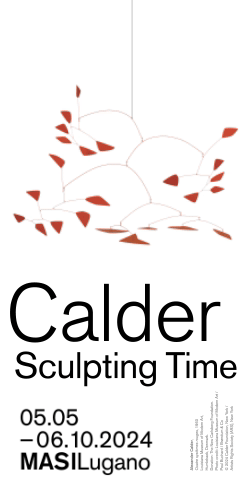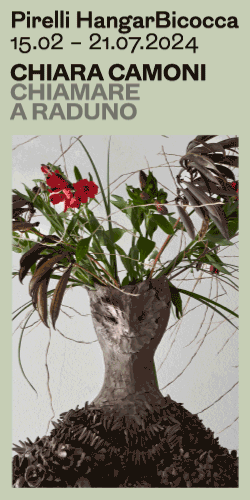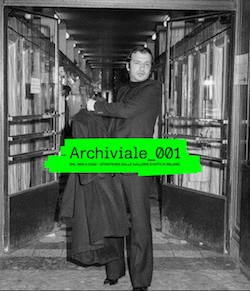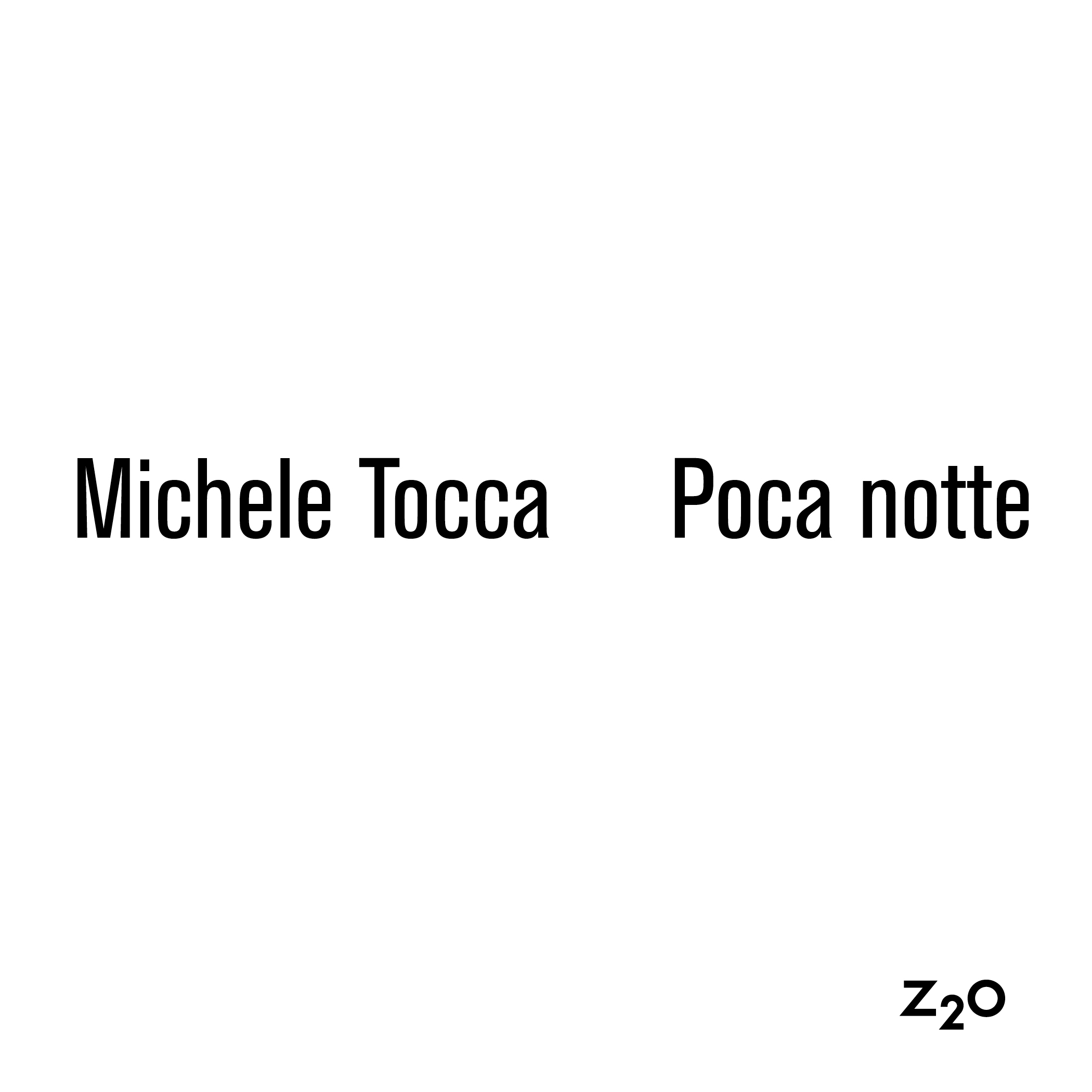Inaugura oggi, giovedì 18 febbraio negli spazi di Lia Rumma, “Forza lavoro”, la mostra personale di Marzia Migliora, accompagnata da un catalogo con testi a cura di Matteo Lucchetti. L’artista, che ha partecipato all’ultima Biennale di Venezia con l’installazione dal titolo “Stilleven”, espone un inedito ciclo di opere ispirato a Palazzo del Lavoro di Torino. A sei anni dall’ultima personale nella sede di Napoli, Migliora sfrutta i tre piani della galleria milanese conservando il nitore, la compostezza e il rigore simbolico che contraddistinguono la sua ricerca. Nell’attesa dell’inaugurazione l’artista ci parla in anteprima del suo progetto:
CM: Hai scelto di concentrarti sul Palazzo del Lavoro di Torino. Nella tua ricerca il rapporto con lo spazio espositivo e la sua storia è molto importante: spesso il luogo dove ti trovi a esporre diventa il protagonista stesso della mostra. E in questo caso?
Marzia Migliora: Il progetto s’incentra sul tema del lavoro, caro anche alla città di Milano. L’edificio stesso di Lia Rumma era in origine una fabbrica di valvole. Ho sempre nutrito interesse per Palazzo del Lavoro, a partire dal suo nome, che consacra l’articolo uno della Costituzione, rendendo quelle parole una presenza reale a disposizione della comunità. Ho scelto quest’opera architettonica come simbolo della situazione italiana d’abbandono e incuria che come ultima ratio privatizza e svende beni storici d’immenso valore.
CM: Non è la prima volta che parli di lavoro, mi viene in mente una mostra che ho visto a Roma nel 2014, “H317 – può provocare una reazione”, con la scritta in anamorfosi LOOKING FOR A JOB.
MM: Quello del lavoro è un tema ricorrente nella mia ricerca. Penso all’opera “From here to Eternit”, sugli omicidi del lavoro, già del 2009. Nel tempo la mancanza di occupazione, il fallimento e i vari risvolti nella società attuale hanno trovato forme molteplici nei miei progetti. Un esempio recente è la talk performance “Un caso” realizzata con l’autrice e biografa Elena Pugliese. Isidoro Danza, titolare a Voghera di un’officina meccanica in via di fallimento, per pagare gli stipendi ai suoi operai rapina in bicicletta nove banche con una pistola giocattolo e una parrucca. Dopo tre anni di carcere, Danza ha raccontato la sua storia dal palco del Teatro Gobetti di Torino, in dialogo con l’antropologo Alberto Salza.
CM: Perché il titolo Forza lavoro?
MM: Forza lavoro è la percentuale della popolazione attiva, che comprende sia le persone occupate sia quelle in cerca di occupazione. Mi interessa porre l’accento su questa energia positiva, su questa forza in potenza e su questo concetto ampiamente teorizzato da Karl Marx.
CM: E il Palazzo del Lavoro di Torino, qual è il suo ruolo all’interno del progetto? Quali aspetti della sua storia o della sua architettura ti hanno affascinato?
MM: Ricercando mi sono imbattuta nei documenti della prima mostra al Palazzo progettato da Nervi, in collaborazione con Giò Ponti, inaugurata nel 1961. In occasione del centenario dell’Unità d’Italia, una mostra internazionale celebrava il lavoro come fattore di progresso per l’umanità, come fondamento dell’avanzamento delle scienze utili al benessere all’uomo. L’Italia, metteva in campo una sorta di “volontà di rischio” pronta a scommettere fiduciosa sul futuro. Esporrò anche una serie di collages con frammenti tratti dalle pagine di Domus del 1961, attraverso le icone e le grafiche pubblicitarie si presentava un immaginario di progresso economico e di futuro possibile.
CM: E poi cos’è successo al Palazzo?
MM: Successivamente al glorioso esordio e a destinazioni temporanee, l’edificio è stato dimenticato in uno stato di totale abbandono in preda a vandalismi e razzie. Quel che resta, sono i residui, cataste di materiali, avanzi, macerie, detriti, polvere e risulta di qualsiasi sorta, beni di consumo ormai consumati. Ho vissuto il Palazzo per una ventina di giorni – ho finito di girare il video il 6 dicembre, il 7 dicembre sono iniziati i lavori per la ristrutturazione che trasformerà Palazzo del Lavoro in un centro commerciale di lusso. Venderlo è stato un errore storico.
CM: Quindi hai catturato gli ultimi giorni di vita del Palazzo come l’hai conosciuto, visto che ora si trasformerà in qualcosa di completamente diverso. Mi è sembrato di capire che in un video ci sarà un violoncellista che suonerà il Requiem … un modo di salutare lo spazio, immagino.
MM: Nel video “Vita Activa” il violoncellista Francesco Dillon, esegue in vari punti del Palazzo del Lavoro un’improvvisazione a partire da un accordo del Requiem in Re minore k626 di Mozart, per poi “suonare” l’architettura e gli oggetti che si trovano al suo interno con un’improvvisazione che suggerisce un cambiamento, una dimensione vitale calata nel presente.
CM: L’architettura del Palazzo ha ispirato l’opera al piano terra, il cui titolo cita una frase di Nervi: “L’ideazione di un sistema resistente è atto creativo”. Di cosa si tratta?
MM: È un lavoro interamente realizzato in mattonelle di carbone. Riproduce una stilizzazione del modulo in scala 1:1 del solaio a nervature isostatiche di Palazzo del Lavoro. Ciò che appare come motivo decorativo in realtà risponde unicamente all’andamento della distribuzione delle linee di forza nel cemento armato.
CM: L’uso del carbone come materiale mi sembra importante all’interno della mostra. Immagino richiami l’incendio che nell’agosto 2015 ha bruciato parte del Palazzo …
MM: Certo, ma richiama anche il problema dell’energia, motore dell’industria. Il fumo che esce dalle ciminiere delle centrali elettriche a carbone, in Europa, uccide più di due persone all’ora e in Italia 500 persone l’anno. Enel, la grande multinazionale elettrica italiana, in termini di sostenibilità è la quinta peggior compagnia a livello europeo. Pensando alle scorie, a quello che rimane nell’aria che respiriamo ho realizzato una serie di monocromi neri sia con i resti di combustione del Palazzo, il residuo simbolico; sia con polveri che provengono dai filtri depolveratori dalla manodopera operaia. Come base per queste opere ho usato i fondi dei cassetti di alcune scrivanie trovate nell’edificio mentre ho usato il resto del legno di questi arredi per realizzare le cornici di una serie di fotografie realizzate con dispositivi stenopeici. Le macchine stesse sono state costruite da oggetti provenienti dal Palazzo. Un po’ come faceva Anna Blume, la protagonista del libro di Paul Auster “Nel paese delle ultime cose”. Una donna che fa la raccoglitrice di oggetti in un paese dove tutto sta scomparendo, vagando per la città con un carrello alla ricerca di frammenti. Uno dei tanti riferimenti letterari “nascosti” nella mostra.