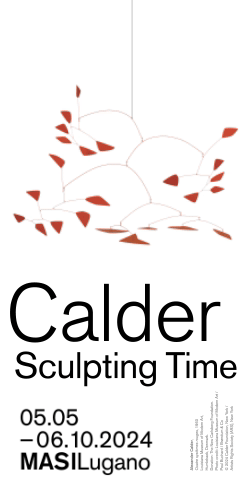[nemus_slider id=”55155″]
–
Per soli due giorni, Venerdì 8 e Sabato 9 Aprile, il Carnelutti Studio Legale Associato ha ospitato Je Ne Sais What?, una mostra collettiva con lavori realizzati da un cast internazionale formato da Aston Ernst, Belle Sunn, Burt Lancaster, Claire Hachette, Clint Eastwood, Johnny Jarrett, Matias Rub e René Le Haut.
In realtà si tratta di uno spin-off della trilogia di Mr Rossi, iniziata nel 2007 con A certain ratio alla Room Gallery e proseguita allo Spazio Minerva con As you enter the exhibition, you consider this a group show by an artist you don’t know by the name of Mr Rossi e conclusasi nel 2011 con Two Times Once alla galleria Limoncello di Londra.
Ritratti che si muovono impercettibilmente, specchi rotti ricomposti, giochi da tavolo sperimentali, volumi di diritto sostituiti da mattoni colorati, fantasmi di fontane, messaggi segreti scritti in un codice formato da sassolini, video amatoriali di fenomeni apparentemente paranormali, monocromi formati dagli spazi vuoti dei quotidiani, ritratti sovrapposti di genitori e figli, la riproduzione in scala delle Alpi riunita su un tavolo, foto in negativo di antichi specchi sbiaditi, una band che suona le sigle dei telegiornali nell’esatto momento in cui questi vanno in onda… I lavori di Je Ne Sais What sono di Sol Calero, Matteo Rubbi, Alek O., Santo Tolone, Renato Leotta, Ryan Gander, Mauro Vignando, Giovanni Giarretta, introdotti da un testo surreale in cui tutti i protagonisti con i nomi fittizi sono inseriti in un racconto che narra di un sogno.
Abbiamo conversato con Matias Rub e Claire Hachette riguardo a Mr Rossi, al “paradosso Ganderiano” e all’importanza del rapporto tra artisti.
ATP: Questa può considerarsi come la quarta parte di una serie di mostre a cui avete lavorato nel corso degli anni?
Matteo Rubbi: In realtà c’è stata una “trilogia di mostre” tra il 2007 e il 2011 in cui abbiamo creato, assieme a Ryan Gander, il personaggio fittizio Mr Rossi, una sorta di “Mr Smith” all’italiana. Mr Rossi è un artista immaginario, e noi facevamo le sue opere, che in realtà poi erano i nostri lavori, ma stavano sotto questo macro-tema di una personale/collettiva con le varie sfaccettature di un lavorare insieme, che noi identificavamo appunto come Mr Rossi
Alek O.: E questo stava molto bene nel titolo della mostra del 2011 dato da Ryan: “As you enter the exhibition, you consider this a group show by an artist you don’t know by the name of Mr Rossi”.
MR: Quindi è tutto svelato, non è che facciamo finta, però tutto sta in questa sorta di paradosso Ganderiano. “A certain ratio”, del 2007, si può considerare come prima tappa di questa collaborazione. Era una mostra in cui abbiamo lavorato anche al restauro dello spazio che ospitava la mostra, la “seconda” Room Gallery.
AO: Quella è stata la prima volta in cui abbiamo lavorato per affinità, fra di noi.
MR: Ci frequentavamo tantissimo, tiravamo fuori idee… quella mostra nasceva da un confronto serrato di artisti, non c’era un curatore. Ognuno lavorava in autonomia, ma c’era sempre uno scambio ed un confronto per creare quella che per noi era la miglior mostra possibile. Non era solo un lavoro sull’opera, ma anche sul come collocarla nello spazio. Era un lavoro sul dispositivo mostra ragionato collettivamente.
ATP: Quindi vi suggerivate a vicenda come installare i lavori.
AO: I suggerimenti sono una cosa che tra di noi avviene in modo naturale, anche a prescindere da una mostra in particolare, tra di noi c’è sempre un dialogo continuo. Anche per una mia personale è probabile che chiami Matteo come primo spettatore. Nel 2007 però è stata la prima volta in cui ci siamo detti “dato che questa cosa succede già, quale sarebbe il risultato se la prendessimo come punto di partenza per un progetto?”. In quel momento, almeno da parte mia, c’era l’esigenza di fare una mostra con gente con cui volevo veramente lavorare, e non fare una collettiva per cui era già stato scelto a priori il lavoro da un curatore. Con il tempo questa cosa si è ripresentata, appunto perchè è continuato il nostro confronto.
MR: Un confronto che è cominciato con “La necessità di un’isola”, che abbiamo fatto appena usciti dal nostro corso di studi, e poi questo bisogno di confronto è rimasto, perchè trovo che i suoi risultati siano sempre un po’ più caldi. Il titolo della mostra “A certain ratio” richiama infatti questa relazione peculiare che si instaura crescendo assieme.
AO: Io avevo presentato un video in cui una vasca emergeva dal Lago di Montorfano.
MR: E noi eravamo tutti nel lago ad aiutarla a farla emergere. Sembrava una specie di balena bianca, che in realtà alla fine era un oggetto quotidiano che all’improvviso spuntava fuori dall’acqua. Un lavoro in pellicola, davvero elegante. “A certain ratio” era una mostra che si giocava su spostamenti minimi. C’era il lavoro che avevo portato al Furla, un muro che tende a cadere e che ha costantemente bisogno di una persona che lo tenga su. Una specie di performance permanente in cui una persona gioca con questa parete.
AO: Era un muro fuori baricentro, di più di quattro metri, pesante, anche pericoloso, ma questa era un po’ la sua bellezza.

ATP: Qual’è la differenza tra il lavorare tra di voi e il lavorare con un curatore? Come si è evoluta nel tempo questa differenza dall’inizio della vostra ricerca ad oggi?
MR: Nel 2007 abbiamo passato l’estate a ristrutturare quello spazio, era un percorso in cui dovevamo arrangiarci e fare tutto noi. Partivamo dal desiderio di voler lavorare con le persone con cui ci sentivamo più in sintonia per realizzare la nostra mostra nel miglior modo possibile. Era un percorso molto intenso, poi siamo cresciuti, abbiamo fatto esperienze diverse, ci siamo divisi…
AO: Anche geograficamente. Matteo per un periodo ha vissuto in Arizona…
MR: Quando sono andato a Parigi al Palais De Tokyo ho coinvolto loro per due pagine di un catalogo, che era un libro d’artista. C’era un testo di Vincenzo Latronico, con immagini di lavori di Santo Tolone e di Alek. Non siamo un gruppo di artisti, ognuno è un individuo, però ogni tanto può capitare che collaboriamo.
AO: All’inizio era una necessità di rendere pubblica un ricerca, o di fare una mostra esattamente come volevamo.
MR: Ed è nata un po’ in questo modo l’idea di chiamare Gander. Ci siamo detti: “Con che artista vorremmo lavorare, e che sicuramente dirà di no?”. E infatti andò proprio così: disse di no, e poi dopo un quarto d’ora disse di si. Come andò esattamente?
AO: Ha detto “Si, assolutamente, il progetto è bellissimo, ma io sono in un anno sabbatico”. E noi abbiamo pensato che fosse una risposta davvero elegante. Dopo dieci minuti ci ha scritto “Ma questo non è un no travestito da si. Io ci sto, ma dovete aspettare che finisca questo anno sabbatico, perchè quest’anno a chiunque mi inviti mando lo stesso video. A voi mi dispiace mandarlo, perchè vorrei davvero lavorare con voi, però dovete aspettare”.
Riallacciandomi alla tua domanda sul lavorare con un curatore, non è che uno non si fida di un curatore, e non abbiamo nulla contro la mostra curata, penso che sia una formula che funziona benissimo, però ogni tanto sento la necessità di un confronto con altri artisti.
ATP: Il rapporto tra artista e artista, e tra artista e curatore è diverso.
AO: In una fase embrionale, ad un curatore non gli passerei certi dubbi, quasi per autodifesa, invece con loro si. Ma non è una cosa che farei con qualunque artista.
MR: Sicuramente tra di noi non c’è questo senso gerarchico che di solito si instaura con un curatore. E’ chiaro che un curatore, nella sua veste classica, ha una sua storia, una sua narrazione, che esprime attraverso delle opere e fa un percorso suo. Mi ricordo che Simon Njami una volta mi disse: “Io voglio chiedere l’opera all’artista e poi non voglio più saperne dell’artista, quell’opera la inserisco in un discorso mio, in un flusso mio”. Lui impersona in un certo senso la chiave classica, e non la critico, perchè se un curatore seguisse tutti i dubbi dell’artista ne esce scemo, deve invece arrivare ad uno statement forte, chiaro, attraverso una serie di artisti di cui condivide il lavoro e il percorso, però in qualche modo il percorso è suo. Nel nostro caso c’è un percorso più sperimentale, ma anche molto orizzontale, mentre nell’altro caso è più verticistico, c’è un curatore che fa un suo discorso. E’ chiaro che il tipo di confronto è molto diverso. Lì il curatore guida la nave, qui siamo su delle zatterine. Il nostro è più un percorso al Thor Heyerdahl, che per dimostrare che i polinesiani vennero dal Perù costruì una nave di balsa e non chiamò marinai specializzati, ma degli amici, con cui si mise alla prova e tentò di rifare quel tragitto via mare. E’ un mettersi alla prova, perchè quando partecipi a tanti progetti segui degli standard, lo standard per la mostra, lo standard per la fiera… Occasioni come queste sono anche dei modi per mettersi in discussione, per avere degli spazi per giocare delle carte che magari non giocheresti altrove. Sono boccate d’aria, sono momenti importanti, e tutti gli artisti hanno un gruppo di amici artisti con il quale si confrontano.
AO: E’ un modo di lavorare che non ha uno statement teorico, è più un lavorare per affinità, per confronto, e ogni tanto c’è anche l’ora di libertà.