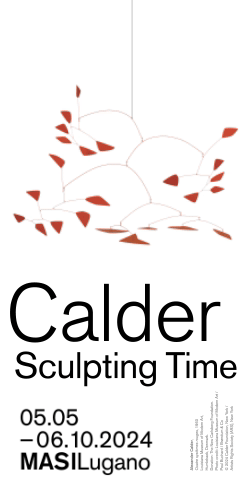“Aspiro a creare qualcosa di bello per offrirlo alle persone. Lavoro molto con sfere e anelli, che per me sono forme di grande bellezza”. Un pensiero semplice ma complicatissimo: creare e condividere bellezza, suscitare stupore come forma di trascendenza o, ancora, instaurare un rapporto di empatia mediante forme elementari, originarie, nate in tempi lontanissimi. Il linguaggio formale di James Lee Byars (Detroit, Michigan, 1932 – Il Cairo, 1997), è circoscritto a forme geometriche archetipe: la sfera il cerchio, la colonna, il parallelepipedo, il quadrato.
In tutte le religioni troviamo testimonianze dell’utilizzo di figure geometriche ricche di significati simbolici. In molte scuole mistiche del passato si insegnava che la geometria è stata usata da Dio per creare l’Universo, in quanto contiene elementi che descrivono fenomeni come la crescita delle piante, le proporzioni del corpo umano, l’orbita dei pianeti, la luce e la struttura dei cristalli. JLB, facendo proprie molte delle sue esperienze, attraversando culture e credenze diverse, ha assimilato nella sua ricerca una sorta di ‘geometria trascendentale’ che ha studiato e utilizzato nella maggior parte delle sue opere, una vasta selezione delle quali è raccolta nell’omonima mostra ospitata fino al 18 febbraio 2014 al Pirelli HangarBicocca a Milano.
Curata da Vicente Todolì, la mostra – organizzata anche in collaborazione con il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid (dove verrà presentata una versione del progetto espositivo dal 25 Aprile al 1 settembre 2024 al Palacio de Velázquez) – è stata strutturata come un percorso non cronologico, che attraversa la carriera dell’artista, dal 1974 al 1997.
Nato a Detroit nel 1932, JLB – un dandy classico nel suo significato più profondo – ha letteralmente costruito la sua vita come una figura leggendaria, studiando dall’arte alla psicologia, dalla filosofia, alla religione. Dalla fine degli anni ’50 ha viaggiato e vissuto in lungo e in largo, in diverse città del Giappone, New York, Berna, Santa Fe, Venezia, il Cairo e la California. Da luoghi e culture differenti e lontane, l’artista ha assimilato attitudini e culture, come elementi del teatro teatro Nô e del buddismo Zen, a cui ha intrecciato l’arte e la filosofia occidentale. In questo suo peregrinare – metaforico ma anche reale – tra differenti patrimoni di conoscenze e saperi, JLB giunge ad un suo personalissimo alfabeto formale. Consapevole della mutevolezza e dell’inconsistenza dell’umana esistenza, l’artista cerca di infondere alle sue opere concetti tanto semplici quanto profondi: l’installazione, la scultura, la performance, il disegno e la parola devono diventare fonti di riflessione mistico-estetica sui concetti di perfezione e ciclicità, ma anche sulla figura umana e le sue trasformazioni.


In molte sue opere, il cardine da cui tutto parte é il corpo dell’artista stesso: in più testi documentativi si ricorda la sua ricercatezza – che a volte diventava una vera e propria mania – nel vestirsi. E poi i suoi gesti stravaganti, il suo aspetto, il suo linguaggio o, anche, il suo bere sfrenato e le frenesie maniacali. Molti curatori lo ricordano come un artista impossibile, irrequieto e indisponente. Nella lunga direzione di Thomas M. Messer al Guggenheim di NYC, era in programma una grande mostra di JLB, saltata perché l’artista pretendeva che l’intero museo, sia all’esterno che all’interno, fosse dipinto di nero opaco, cosa assolutamente irrealizzabile. La stessa mostra in programma fu realizzata invece alla Kunsthalle di Dusseldorf, dove la richiesta di Byars di dipingere il museo – in questo caso di rosso pompeiano – fu accolta. Tra i tanti aneddoti che si citano per dare una forma alla sua rocambolesca esistenza, ci sono anche quelli legati all’azione di bruciare i cataloghi delle sue mostre, perchè, a detta dell’artista, apparivano un po’ troppo come dei libri religiosi. Questi atti, soprattutto quello avvenuto dopo la mostra a Dusseldorf, furono interpretati da alcuni critici come un riferimento ai roghi nazisti, cosa su cui, naturalmente, non si poteva scherzare. Insomma, definirlo ‘odioso’, sarebbe un epiteto tutto sommato onesto. Dicevamo del suo volere incarnare la figura del dandy di ottocentesca memoria – Baudelaire e Wilde su tutti – che però si è inevitabilmente intrecciata con altri stili. Durante le sue visite in Giappone, negli anni ’50 e ’60, Byars resta fortemente colpito dal comportamento dei preti scintoisti. E’ dal loro abbigliamento che alla fine trasse quello che diventò il suo stile: la lunga biancheria intima di seta nera, abiti, camicie e cappelli neri, solitamente a tesa larga; talvolta andava in giro anche con maschere o cappucci che gli coprivano completamente il volto. Amava nascondere gli occhi perchè riteneva che farli vedere fosse un gesto troppo intimo. Ma potremmo citare anche gli abiti con code da diavolo in seta rosa, cappelli da cowboy in velluto rosso, abiti dorati con lunghissime maniche…
Quasi banale sottolineare il fatto che la più grande opera d’arte realizzata da JLB fu proprio sé stesso; un’opera costantemente rimaneggiata, perfezionata, esibita e, inevitabilmente, rifiutata – si racconta che in un noto ristorante di NYC fu messo alla porta perchè non voleva togliersi un grande cappello. Ecco allora che il rapporto con il pubblico era una sacrosanta cartina di tornasole, non solo per la messa in luce della sua persona, ma anche per fare delle verifiche e vivificare le sue opere. Con la sua pratica eclettica, Byars si è rivelato pioniere in diversi ambiti delle arti visive: come scrive la curatrice Brenda Richardson (1942-2022), infatti, “ha inventato lavori di arte concettuale, performativa e installativa prima ancora che esistessero definizioni di quello che stava realizzando”.
Nel lungo percorso offerto dalla mostra all’HangarBicocca, l’inizio e la fine del percorso sembrano racchiudere l’ampia grammatica dell’artistica. La prima opera che ci accoglie è l’imponente The Golden Tower, che domina lo spazio con i suoi oltre 20 metri di altezza e con la lucentezza della foglia d’oro che la ricopre. Ricordo quest’opera installata a ridosso del Canal Grande a Venezia nel 2017. Qui, come allora, la tensione verso il divino, l’addensarsi in una forma così semplice e maestosa di spiritualità, lascia letteralmente a bocca aperta. In stretta relazione con quest’opera, concepita dall’artista nel 1990, altri lavori installati poco lontano nello spazio: The Capital of the Golden Tower (1991), il cerchio di marmo d’orato The Door of Innocence (1986-89) e il pilastro sempre in marmo dorato The Figure in the Question is in the Room (1986).

All’inizio parlavamo di una sua “geometria trascendentale”, un catalogo formale e concettuale costruito nei decenni dall’artista. Una summa della sua opera la troviamo in due installazioni riassemblate per la prima volta in Hangar dal 1983: The Giant Angel with the Human Head (1983) e The Devil and His Gifts (1983) entrambe concepite dell’artista come assemblaggi di lavori precedenti, con l’intento di creare un’opera d’arte totale dedicata alle figure dell’angelo e del diavolo. In due tele rispettivamente nera e rosa, sono dislocate una serie di opere di piccole dimensioni: dalle sfere di diverso materiale ai libri di marmo, dagli abiti alle corde alle pietre arenarie bernesi.
Concepito seguendo una quasi impercettibile simmetria, il percorso in mostra rivela molti elementi che si rispecchiano, come ad esempio le due sfere allestite una di fronte all’altra: The Rose Table of Perfect (1989) e The Tomb of James Lee Byars (1986), la prima formata da 3333 rose di un rosso vivido inizialmente, diventato poi più scuro con il trascorrere del tempo; la seconda, come si evince dal titolo, è stata concepita come la tomba dell’artista, una sfera perfetta di pietra arenaria levigata.
Altri due lavori speculari poco più avanti: The Conscience (1985) e Byars is Elephant (1997). Se nell’opera degli anni ’80 l’artista ha compiuto una drastica sintesi – una piccola sfera dorata dentro una grande teca di vetro appoggiata su una base d’oro – nell’opera più recente, dal titolo che suona un po’ ironico, Byars inscena un grande teatro dove la protagonista è la morte (la sua, verrebbe da pensare) simboleggiata da una grande palla di corda intrecciata, installata al centro di un’ampia tela dorata. Quest’opera è l’ultima che l’artista ha realizzato prima della sua prematura dipartita, avvenuta a Giza; dalla finestra del suo albergo Byars poteva vedere le tre grandi piramidi, a suo parere una delle espressioni più profonde e perfette per narrare il ciclo semplice e complessissimo della vita e della morte.
Speculari anche HEAR TH FI TO IN PH around this chair and it knocks you down, del 1977 e The Chair of Transformation, 1989, composte da due tende – una nera e una rossa – con dentro una sedia-trono vuota, una riflessione o ripensamento del luogo che consacra il potere, mondano o spirituale.
Un’installazione più di altre sembra sintetizzare tutto il vocabolario formale di JLB: la serie di opere in marmo bianco racchiuse in teche dorate. Ognuna conserva un libro: The Circle Book, The Head of Plutarco, The Triangle Book, The Spherical Book, The Cube Book, The Soft Book, The Figure of Question, The Star Book, ecc.
Elementi archetipi concepiti dall’artista come libri, forme semplici in cui ha trovato le forme per le sue opere, derivate e fuse a loro volta con filosofia e geometria. Un libro di pietra lascia, sicuramente più un libro reale, la possibilità di aprire i significati a una molteplicità infinita di interpretazioni e sviluppi, così come queste piccole sculture innalzano la perfezione delle forme geometriche a condensati di espressioni e concetti.
La mostra si chiude con un’installazione, Red Angel of Marseille, composta da mille sfere di vetro rosso, concentrato di magnificenza, splendore, sofisticata bellezza. Dall’essenzialità di The Golden Tower all’esuberanza decorativa di due grandi ali decorate come fossero rami stilizzati in fiori. Ritorna la sfera – completa, eterna, perfetta – il rosso e ora anche la trasparenza del vetro che riflette, si lascia attraversare, ma è fragile e pesante. Nell’equazione tra forma, contenuto e alterità, JMB ci lascia con un nuovo modo di percepire la materialità del mondo, con i suoi dubbi e incongruenze.


James Lee Byars The Chair of Transformation, 1989 Veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2023 The Estate of James Lee Byars e Michael Werner Gallery, New York, Londra e Berlino Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto Agostino Osio 
James Lee Byars Veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milan, 2023 Primo piano: The Rose Table of Perfect, 1989 Secondo piano: The Tomb of James Lee Byars, 1986 The Estate of James Lee Byars, Michael Werner Gallery, New York, Londra e Berlino, e IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milano Foto Agostino Osio