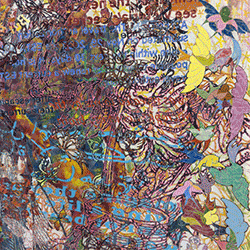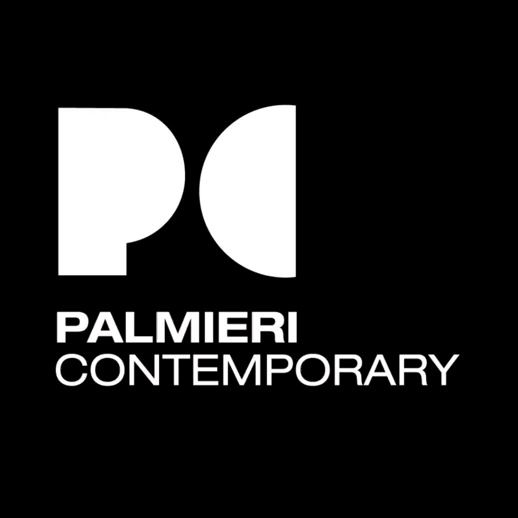Per la seconda edizione di Sconfinamenti – la rassegna biennale che intreccia arte e natura nelle Terre Matildiche (24-25 ottobre 2025) – Ilaria Turba ha sviluppato un progetto partecipato che intreccia fotografia, memoria e comunità. L’artista ha incontrato cittadini, associazioni e famiglie, raccogliendo racconti e immagini d’archivio legate al tema dello stare insieme. Da questo lavoro condiviso sono emersi archivi collettivi trasformati in materia visiva.
Il progetto, dal titolo Nuêter – Costellazioni nelle Terre Matildiche e curato da Daniele De Luigi, si traduce in tre opere permanenti installate nei comuni di Albinea, Canossa e Quattro Castella. Le fotografie raccolte, incise su dischi dorati in ottone – superfici specchianti che evocano antichi dagherrotipi – sono state disposte in forma di costellazione sui muri di luoghi simbolici della socialità. Segni luminosi che intrecciano passato e futuro, memoria e appartenenza.
Il lavoro di Turba non si limita a documentare, ma riattiva legami, restituisce valore alle storie personali e collettive, costruisce un atlante corale capace di orientare lo sguardo.
Quello che segue è un estratto di una conversazione tra Ilaria Turba e Daniele De Luigi nata in relazione al progetto.
Daniele De Luigi: Il progetto Sconfinamenti ha l’obiettivo di portare l’arte contemporanea nei comuni collinari di Albinea, Canossa e Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, per creare nuove prospettive e forme di legame tra il territorio e chi lo vive. La mission progettuale è l’installazione di opere d’arte permanenti in luoghi sempre aperti al pubblico, che possano essere fruite sia dai cittadini, sia da chi attraversa occasionalmente, per escursionismo o turismo, questi territori. Sono stato invitato a curare la seconda edizione e abbiamo pensato di radicare maggiormente il progetto e coinvolgere in processi partecipativi i cittadini, nella costruzione di un percorso collettivo di comunità. Ho subito pensato di invitare te, Ilaria Turba, conoscendo la tua capacità di lavorare con la fotografia – che era stato deciso fosse il medium al centro di questa seconda edizione – sia come produttrice di immagini, sia per la tua capacità di lavorare con le immagini esistenti e in particolare quelle d’archivio. Ti interessano tanto gli archivi del passato che gli “archivi del presente”, potremmo chiamarli, appartenenti agli abitanti di questi luoghi, alle comunità che ci vivono: secondo me tu hai il dono di saper dare loro vita, utilizzandoli come strumenti per attivare il coinvolgimento emotivo, prima di tutto, ma non solo, di queste persone.
È quindi con questa prospettiva che ti abbiamo invitata e il primo passo per te è stato ovviamente visitare questi territori e conoscerli. Come è stato per te questo momento iniziale, come si è svolto, come ti sei relazionata, qual è stata la prima impressione che hai avuto, quali sono state le sensazioni e come si sono evolute rispetto agli obiettivi che ci siamo dati con questo progetto?
Ilaria Turba: Grazie, Daniele, anche per questo bellissimo invito e per questa preziosa occasione di ricerca. Sono arrivata nelle terre matildiche senza esserci mai stata prima; quindi, l’incontro con questi luoghi è stato davvero inedito. Qui c’è un paesaggio che in qualche modo, mi è familiare, perché parte della mia famiglia è originaria dell’Appennino tosco-emiliano, ma dal versante toscano. In questa zona emiliana è interessante osservare come nel giro di pochi chilometri cambia il paesaggio: dalla Pianura Padana, alle prime colline preappenniniche, fino a salire in quota.
L’accoglienza delle comunità che ho incontrato è stata, direi, da subito molto calorosa: c’è stata molta apertura e interesse. Quando arrivo nei territori la prima cosa che faccio è parlare con le persone per capire dove mi trovo. Nel corso dei primi circa quattro mesi di lavoro e ricerca ho incontrato e intervistato quasi cinquanta persone, un numero significativo che mi ha permesso di avviare l’intero processo di creazione e di partecipazione. Rispetto ad altri luoghi in cui ho lavorato, ciò che mi ha colpito qui è la forte aggregazione collettiva che c’è da sempre.


DDL: E rispetto all’incontro specifico con i tre luoghi in cui verranno installate le opere, com’è avvenuta la scelta? quali sentimenti, riflessioni o folgorazioni l’hanno guidata?
IT: Ci sono stati dei veri e propri colpi di fulmine, come spesso accade in questi casi. Uno dei primi è stato con il Centro Sociale Autogestito di Borzano: una vecchia scuola degli anni ’30 trasformata in centro di aggregazione. È un luogo speciale, immerso nelle colline, con una storia affascinante: la scuola era stata voluta da un latifondista del paese, che volle dare accesso all’istruzione ai bambini delle famiglie che lavoravano per lui. Già nella sua storia è un luogo che ha fatto crescere e ha dato nuove opportunità a una piccola collettività. Il secondo colpo di fulmine, meno immediato ma più stratificato, è stato con Villa Tarabini, anche perché spesso soggiornavo nell’hotel vicino alla Villa e quindi l’ho vissuta nei diversi mesi con i cambi di stagione e mi ha sempre incuriosita. È un palazzo signorile in cima a una collina con, da un lato, una vista estesa verso la pianura e dall’altro lato verso i colli. Qui, nel corso del progetto, si sono sovrapposte varie storie, dall’origine nobile a quella di sede di partito e di varie feste, mentre nel sottotetto della villa ho potuto vedere le botti dove ancora si produce un aceto balsamico di grande qualità. Ora è in una fase di trasformazione affinché possa essere riaperta alla comunità. Infine, il luogo più controverso, ma che alla fine mi ha conquistata strada facendo, è la Casa del Mezzadro di Puianello: una casa contadina accanto alla parrocchia. Abbiamo incontrato un uomo, che ora ha più di ottant’anni, che è nato e cresciuto lì, chiamato “Il Friulano” perché la sua famiglia arrivava dal Friuli. È un posto molto particolare, con diverse storie chiaroscurali che si intrecciano tra loro: dalla grotta in tufo dove si nascondevano i partigiani, alle donne che su questo colle si riunivano per condividere conoscenze sulle erbe e che vennero poi incriminate come streghe, per poi essere sede dell’asilo del paese e altre storie. Tutto questo rende il luogo estremamente stratificato anche se a un primo sguardo non si percepisce. Ora la casa è appena stata ristrutturata e diventerà uno spazio aperto ai giovani. In generale, sia la Mucciatella che Villa Tarabini, così come il Centro Sociale di Borzano — che però ha una storia più consolidata — sono luoghi di transizione, il motivo per cui sono nati non è la destinazione d’uso attuale o futura.
DDL: A un certo punto hai chiesto ai partecipanti agli incontri di portare immagini e raccontare storie di questi posti. Questa campagna di raccolta di immagini ha avuto un successo sorprendente, forse anche oltre le aspettative, e ha permesso alle persone di sentirsi parte del processo artistico, le ha fortemente entusiasmate e coinvolte emotivamente.
All’inizio, però, tu non sapevi esattamente cosa avresti fatto con tutte quelle immagini. Questo ci mostra come il processo non sia finalizzato solo alla realizzazione dell’opera, ma sia una parte integrante e fondamentale del tuo lavoro.
IT: Arrivo in un territorio senza sapere mai quale sarà la forma finale di restituzione del processo che metto in atto, proprio perché si costruisce man mano con le persone, con gli incontri e con le dinamiche che si creano naturalmente. L’idea di usare la fotografia era centrale nel progetto. Ho già lavorato in passato raccogliendo archivi fotografici, non solo familiari ma anche di gruppi, associazioni, istituzioni. In questo caso specifico, il tema che ho scelto è lo stare e il fare insieme. In questi territori l’associazionismo è una componente della vita sociale forte e radicato e il volontariato è molto sentito e si tramanda da generazioni. Quando presento il mio lavoro c’è sempre un momento iniziale curioso, in cui le persone non capiscono subito cosa voglio da loro, dopodiché si aprono. In questo progetto ho incontrato persone di tutte le età: dai bambini della scuola primaria di Albinea per arrivare al gruppo di anziani di Puianello, che si ritrova in un centro dove giocano a carte e svolgono varie attività. Mi piace confrontarmi, con persone di età ed esperienze anche molto diverse, che il più delle volte, sono molto lontane dall’arte contemporanea e dalla sua frequentazione. Questo momento per me è sempre una sorta di “cartina tornasole” per capire se la mia pratica è viva, se può avere ancora un senso oggi, nella contemporaneità. È un po’ come per i musicisti di strada, che suonano davanti al pubblico e hanno un ritorno immediato in base all’attenzione che ricevono. Quindi, per me, la partecipazione delle persone è un vero termometro: misura quanto la mia pratica sia viva e quanto sia sentita dalle persone. E devo dire, come dicevi tu, che la risposta è stata ben oltre le nostre aspettative. Io pensavo di raccogliere qualche centinaio di fotografie e alla fine ne abbiamo raccolte 60.000.


DDL: Sì, è veramente un risultato incredibile. E mentre raccoglievi queste immagini e continuavi a osservare il territorio, hai iniziato a elaborare nella tua testa l’idea dell’opera finale: un’opera d’arte permanente, con un suo valore autonomo, ma che contenesse tutti questi livelli di lettura e diventare qualcosa in cui chi aveva partecipato potesse riconoscersi. Come è nata l’idea di quest’opera e, alla fine, in cosa consisterà?
IT: Le prime intuizioni che ho avuto sono arrivate man mano che raccoglievamo le immagini, non tanto per i contenuti delle singole fotografie quanto per il loro insieme. Sentivo che era importante creare qualcosa che andasse oltre al singolo frammento, alla singola fotografia, per costruire un’esperienza più ampia, capace di tenere insieme tra loro una complessità. Inoltre, è stato molto stimolante progettare un’installazione nello spazio pubblico che fosse tridimensionale. Ricordo che le prime idee riguardavano frammenti, pezzi d’immagini che, messi insieme, potessero costruire una sorta di puzzle disseminato nello spazio. Non si trattava di mostrare la singola storia, il singolo contributo, il singolo frammento, ma qualcosa di diverso. Non ricordo esattamente il momento in cui mi è venuta l’idea di creare una costellazione, ma è arrivata dopo un po’ di tempo. Un giorno mi sono detta: perché non creare una costellazione che nasca da un processo collettivo, da un lavoro di gruppo in cui le immagini potessero diventare attivatrici di un’esperienza? Da lì è nata l’idea di organizzare una grande festa. Una volta terminata la raccolta immagini abbiamo richiamato tutte le persone che avevano contribuito donando al progetto le loro fotografie e anche chi non era riuscito a partecipare, amici, parenti, membri delle associazioni locali, e li abbiamo tutti riuniti in una giornata di festa -come ce ne sono tante in Emilia-, all’inizio dell’estate. In quell’occasione, le persone potevano vedere l’intera raccolta delle immagini e prendere parte attivamente alla costruzione dell’opera finale.
DDL: Raccontami un po’ meglio questo gioco con le immagini: a chi era rivolto, in cosa consisteva, come hai messo in condizione di svolgerlo, e qual è stato il risultato.
IT: Il gioco-proposta che ho ideato per Sconfinamenti era aperto a tutti, anche ai bambini. Consisteva nell’utilizzare delle mascherine con cerchi di varie dimensioni, da usare per rinquadrare l’immagine fotografica e così poter scegliere una porzione d’immagine. Più persone potevano selezionare più parti della stessa immagine. Il risultato è stato un insieme di fotografie con tantissimi cerchi disegnati, a volte anche sei o sette. Pensa che, delle 180 immagini a disposizione del pubblico, solo dieci sono rimaste vuote, senza segni né cerchi. Tutte le altre erano piene di tracce tonde. Questo dà la misura del coinvolgimento delle persone, che una volta capita la proposta, si sono immerse nella pratica senza praticamente alcun bisogno di accompagnamento.
DDL: Venendo all’opera finale, queste immagini sono state incise su tondi di ottone di dimensioni variabili, una tecnica molto particolare. Perché hai fatto questa scelta? Che effetto hai voluto ottenere? E che tipo di reazione ti aspetti che le persone avranno davanti all’opera?
IT: L’ottone è un materiale che ho già utilizzato in diverse opere, ed è un metallo che mi piace tantissimo: è povero, semplice, ma con una patina dorata che lo rende prezioso già a prima vista.
Abbiamo ragionato con Daniela Lorenzi di A14 su una serie di tecniche, alcune già usate con altri materiali, per incidere manualmente su una lastra in ottone un’immagine in modo che il soggetto fosse riconoscibile, ma non nei dettagli più precisi. L’effetto finale è quindi quello di una traccia, non di una riproduzione fedele dell’immagine fotografica. La lastra ha parti incise e parti non incise creando un effetto simile al dagherrotipo. Per chi non lo sapesse, il dagherrotipo è un’antica tecnica di stampa degli albori della fotografia stampata su metallo: l’immagine appare positiva o negativa a seconda di come cade la luce o in base all’angolo di visione. Questo crea un effetto molto particolare e cangiante. Queste lastre tonde funzionano anche come piccoli specchi: chi guarda si vede riflesso e sovrapposto all’immagine. Mi piace che queste tracce fotografiche siano cangianti e brillanti e che il pubblico possa essere coinvolto nell’opera con la propria presenza riflessa.
Cover: Immagine preparatoria all’opera pubblica di Ilaria Turba, ph. Camila Schuliaquer