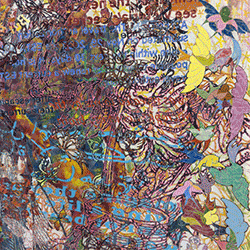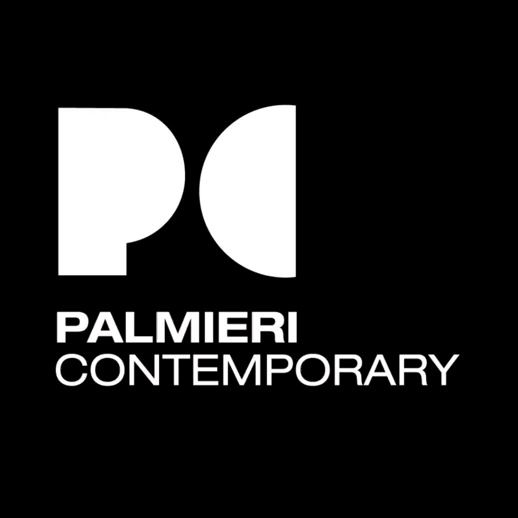Testo di Arianna Maestrale —
Un gesto semplice, quotidiano, antico come il mondo: impastare e modellare il pane. Da questo atto primario, che appartiene a tutte le culture, Ilaria Turba ha tratto la matrice di un progetto che in sei anni è diventato rito collettivo, performance partecipata, opera processuale e, al tempo stesso, simbolo di trasformazione. I pani del desiderio, presentato al MAN di Nuoro lo scorso 18 settembre come tappa conclusiva di un lungo viaggio, restituisce l’eco di un’esperienza che ha generato comunità temporanee, spazi di ascolto e forme effimere che si sono depositate nella memoria dei partecipanti. Come racconta l’artista, «mi interessava capire come un gesto così semplice potesse contenere in sé la possibilità di accogliere le aspirazioni di chi lo compie. Non un pane da mangiare, ma un pane che potesse custodire un desiderio».
Il progetto prende avvio a Marsiglia, nei quartieri nord, in un contesto segnato da fragilità sociali e grande vitalità multiculturale. Qui Turba, come artista associata al teatro nazionale Le ZEF, attiva una serie di laboratori ispirati ai pani tradizionali del mediterraneo, in cui, qui, il gesto del pane si intreccia con le storie delle persone incontrate. Ogni pane-scultura nasce da un desiderio condiviso, modellato e reso forma. Si tratta di sculture di farina e acqua, ma soprattutto di memorie e aspirazioni: forme uniche e irripetibili, e perciò riconoscibili per la forza con cui riescono a condensare vissuti diversi. L’artista sottolinea: «volevo lasciare che le persone sviluppassero il progetto insieme a me. In questo senso il pane è stato un pretesto, un catalizzatore, l’occasione di una creazione condivisa e di uno scambio».



Relazione e partecipazione
Il viaggio dei Pani del desiderio si estende poi in Italia, dal 2022, coinvolgendo città e borghi molto diversi tra loro: Milano, Fontecchio (AQ), Firenze, Castiglione delle Stiviere (MN), Ghesc (VB). Ogni volta il processo si riattiva in dialogo con contesti e comunità differenti, in collaborazione con musei, festival, associazioni locali. La logica non è quella dell’opera che si replica identica, ma di un rituale che si rigenera a ogni incontro. Nei laboratori, che Turba preferisce definire «momenti di vera e propria creazione collettiva» i partecipanti raccontano, ascoltano, immaginano. Ciascun pane diventa così il contenitore simbolico di un frammento di esperienza individuale che si intreccia con altre, fino a comporre un mosaico che nella sua forma si rende condiviso e collettivo. La mostra al MAN non espone semplicemente queste forme, ma prova a restituire il processo, le relazioni, i legami invisibili che li hanno resi possibili; diventando anch’essa una nuova occasione di relazione e interazione con gli spettatori. La dimensione partecipativa infatti non è accessoria, ma sostanziale: senza la presenza e il contributo delle persone, il progetto non avrebbe potuto esistere, in ogni sua tappa.
Il pane non è mai neutro, ha un valore simbolico fortissimo in tutte le culture: evoca nutrimento, condivisione, ma anche festa, sacrificio, speranza. Sappiamo che la Sardegna vanta una vastissima e variegata tradizione dei pani rituali, anche grazie al lavoro di altri artisti e artiste (vedi Maria Lai!) che si sono posti in dialogo con la tradizione. Proprio per questo Turba ha scelto la Sardegna come momento conclusivo del percorso dei suoi pani, come ricongiungimento simbolico con il primo incontro con i pani rituali, avvenuto nell’isola, e per l’empatia con una regione che più di molte altre in Italia ha mantenuto forte e vitale la relazione con la terra e con le tradizioni popolari.
Il percorso espositivo al MAN accompagna il visitatore dentro il viaggio dei pani, rendendo visibile la loro trasformazione: dai pani-scultura di Marsiglia ai più recenti realizzati in Sardegna, fino alla documentazione del rito finale in cui ogni pane è stato carbonizzato dai partecipanti durante una giornata di festa.
Al centro, un grande tavolo diviso in una parte chiara e in una scura: da un lato i pani come segni di memoria, dall’altro gli oggetti usati nel rito collettivo e la polvere nera che ne è derivata. Una polvere di carbone densa e generativa, capace di diventare materia per scrivere nuove parole, di tracciare desideri su stoffa, di aprire spazi di immaginazione.
La tappa di Villaurbana, in Sardegna, dicevamo, ha rappresentato il culmine simbolico del progetto. Qui, in un territorio dalla fortissima tradizione legata ai pani rituali, l’intera collezione dei pani realizzati negli anni è stata affidata al fuoco in un grande rito collettivo. Non una distruzione, ma una trasformazione: «il fuoco – racconta Turba – non segna una fine, ma piuttosto un passaggio. Quelle forme non sono scomparse: sono diventate qualcos’altro, una polvere che porta con sé la memoria dei desideri». È in questo atto che il progetto ha forse trovato la sua sintesi più radicale: i pani si dissolvono, ma la loro essenza resta, si mescola, si rinnova.


L’universalità dei gesti
Ciò che sorprende, ripercorrendo il progetto, è la sua capacità di generare esiti analoghi in contesti profondamente diversi. Le periferie multiculturali di Marsiglia, un piccolo borgo abruzzese, una città come Firenze, un villaggio di pietra nelle Pre-alpi piemontesi: luoghi distanti per storia, tradizione e struttura sociale. Eppure, ogni volta, il gesto del pane ha prodotto forme che sembrano dialogare tra loro, come se esistesse una grammatica comune capace di attraversare differenze geografiche e culturali. Turba stessa, con una certa sorpresa, osserva: «in luoghi lontanissimi tra loro ho visto nascere processi e dinamiche che si assomigliavano, come se i desideri avessero un corpo che si ripete».
È qui che emerge con forza la dimensione simbolica del progetto: il pane, alimento primordiale e condiviso, diventa linguaggio universale, capace di dare forma a ciò che altrimenti resterebbe invisibile. In un tempo segnato da frammentazione e distanza, I pani del desiderio restituisce un’idea di arte come pratica lenta di connessione, in cui l’opera non è mai un oggetto autonomo ma il risultato di una rete di relazioni, di racconti, di gesti che si ripetono e si trasformano.
Infine, possiamo dire che la mostra al MAN non è una conclusione, ma un nuovo inizio. L’esperienza del fuoco e della polvere di carbone non chiude il cerchio, ma lo apre: i desideri, liberati dalle forme materiali, restano come tracce da trasmettere, da ricordare, da reinventare. Così il progetto continua a vivere non solo nei musei e nei cataloghi, ma nelle memorie di chi vi ha partecipato e negli sguardi di chi oggi lo attraversa, così come nella mente dell’artista che forse attiverà un nuovo ciclo, una volta metabolizzato del tutto quanto avvenuto fin ora. L’invito implicito è semplice e radicale: dare forma a un proprio pane del desiderio, e condividerlo. Perché nell’atto di impastare insieme – ieri come oggi – c’è già la possibilità di immaginare un altro modo di stare al mondo.
Cover: Ilaria Turba, Viaggio dei pani del desiderio, Villaurbana 2024, ph. Camila Schuliaquer