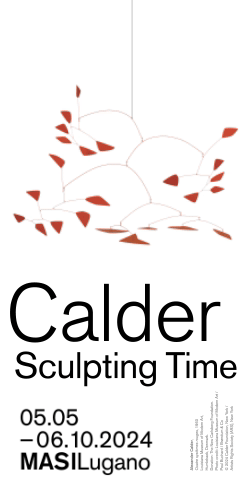Il MACRO dal 2012 ha avviato un programma di residenze d’artista trasformando i quattro spazi al secondo piano dell’ala storica del museo in studi di circa 100 mq per accogliere altrettanti artisti (due italiani e due stranieri) per un periodo di quattro mesi.
Gli artisti selezionati per il periodo da febbraio a maggio 2014 sono stati Guglielmo Castelli (1987, Torino), Nemanja Cvijanovi? (1972, Rijeka, Croazia), Anna Franceschini (1979, Pavia) e André Romão (1984, Lisbona, Portogallo).
In vista della mostra finale che si terrà il 12 giugno, ATPdiary ha chiesto a ciascuno degli artisti di redigere un di diario fotografico commentato, per raccontare le suggestioni raccolte durante il periodo di residenza.
Iniziamo con Guglielmo Castelli.
Guglielmo Castelli per il suo progetto al MACRO é partito dal principio metodologico formulato dal filosofo e frate William of Ockham nel XIV sec. Noto come “Il rasoio di Ockam”, il principio vuole evitare la formulazione di teorie aggiuntive per spiegare un dato fenomeno, se quelle esistenti sono già sufficienti alla dimostrazione del fenomeno stesso. La metafora del rasoio, che elimina quindi le teorie aggiuntive, è servita all’artista per mettere in discussione i parametri di giudizio di valore e per riflettere sulla relatività della formulazione di un pensiero. I personaggi dei lavori di Guglielmo Castelli, restituiti attraverso la liquidità del colore e della pittura, sono per l’appunto figure incategorizzabili che vogliono sfuggire alla loro stessa forma e, quindi, alle leggi preesistenti. Questi personaggi antropomorfizzati su fondi monocromi tentano affannosamente, di compiere gesti, interagendo con oggetti che sono in realtà ostacoli e non supporti a loro stessi.
Le opere realizzate durante la sua residenza – tele di vario formato e una scultura – ci sussurrano quanto il fallimento e la caduta non sono intesi dall’artista come fine, ma, al contrario, come punto di partenza.
*

L’estate qui è già arrivata.
Quando torno a Torino, la mia città e la mia casa, mi sembra tutto ancora da spacchettare. Per formazione prediligo spazi silenziosi e melanconici, per così dire monastici.

Le mattine con il primo sole passate a Trastevere, camminando, mentre le suore dall’ospedale di San Gallicano assorte camminavano veloci e compatte.

Mi sono ritrovato su ponti assolati, su facciate di chiese dove ascensioni e barocche speranze creano vortici inaspettati, in punta di piedi quasi muovendosi per il Chiostro del Bramante lontano da sguardi indiscreti di viaggiatori lontani.
Questa è stata per me Roma, una residenza di stupori continui.

Lo studio è stato scrigno dove riversare tutte le sfaccettate e mutevoli gradazioni di intensa vita che questa città dona in modo quasi casuale, confuso, in “caciara”.

La voracità nel riuscire a sperimentare forme nuove, ad essere all’altezza in quanto pittore di rendere merito ad una tecnicità e ad una poetica sviluppata negli anni mi ha portato ad ampliare le dimensioni delle mie tele, a perdermi in un horror vacui iniziale fino ad arrivare, con strati di colore e campiture piatte a un risultato; considerando il processo parte, forse, più importante del risultato stesso.

I miei colori ospedalieri mi hanno fatto da tramite tra la luce sconfitta della capitale e il mio mondo intimo e barocco.
Così questa residenza è stata un altro ponte tra le intenzioni artistiche con cui sono arrivato e quelle nuove che mi si sono prospettate.
L’idea dell’imprevedibile.

La mia pittura è cambiata, non è più rigida, ma contempla, come le strade di Roma , di potersi perdere e di potersi ritrovare. Mi sono affacciato anche alla scultura, una piccola testa di una creatura che cade, che fallisce, ma si rialza.

Perché Beckett diceva fallisci, fallisci ancora fallisci meglio.
(La rubrica DIARY è curata da Matteo Mottin)