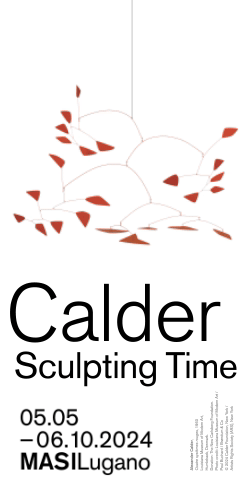Conversazione tra Diego Marcon e Daniela Zangrando ///
Diego Marcon: C’è una cretina ad un tavolo. Ci sono due amiche, di cui una è proprio una cretina. Ha capito che cretina? Così, guardando questa cretina, che mangia portando alla bocca pezzetti di pane con il pollice e l’indice e poi resta a succhiarsi il polpastrello mentre sorride all’amica, mi sono chiesto cosa ne pensa lei. Non so spiegarmi, ma questa cretina forse è senza speranza. Non so come dire – è e ancora è una cretina. Ho pensato di essere un po’ duro e cattivo, e ho pensato che lei non lo è, e così mi sono chiesto se, anche per lei, qualcuno è senza speranza.
Daniela Zangrando: Sì. E non credo sia particolarmente cattivo il pensarlo. Forse sono quei gesti ad essere senza speranza. Quel portare il cibo alla bocca, ad esempio…
DM: Purtroppo penso che anche L. sia diventata una cretina, e temo senza speranza. Peccato. È solo meno bionda di quest’altra, ma anche i suoi gesti sono senza speranza, anche le parole. Chissà cosa le è successo! Sembra che non ci sia nulla, che dentro L. non ci sia nulla. Forse la vita è per alcuni un lento processo di erosione della vita stessa, dell’esperienza della vita stessa; persi in una totale assenza di realtà, poco a poco non restano che gli scheletri di qualche immagine bugiarda.
DZ: Credo di capire cosa intendi per erosione. Sembra che la vita sia già stata, e non sia più in divenire se non in un movimento di invecchiamento e in una strana forma di condiscendenza. Il tutto fermato in qualche noiosa fotografia, utile per portarsi dietro un’immagine che equivalga alle spoglie di un sé catturato in un “prima” non ben definito.
DM: Al ristorante ad un certo punto è entrata una coppia diversa dalle altre sedute ai tavoli. Una coppia di banlieusard – due ragazzi nordafricani. Si riconoscono subito, lo sa. Ho sorriso, pensando “Guarda la cretina”. Ma non si sono scambiati una parola. Entrambi ruminavano tristi, occhi ai piatti, portandosi con più cura possibile il bicchiere alla bocca; anche loro, in quel ristorantino, ad un altro punto morto di un’altra immagine bugiarda.
DZ: Guardo spesso le coppie quando mi trovo per la strada o in qualche locale. Pochissime parlano. Che siano madri e figlie, fidanzati, amici, poco cambia. Sono immagini ancorate a immaginari stanchi.
DM: …
DZ: Lo so, è durissima.
DM: Credo ancora che l’artista rimanga un’idea fortemente rivoluzionaria.
DZ: Si è davvero molto soli in questa idea rivoluzionaria. Anzi, più che molto, profondamente.
DM: Penso alle medie, a quando decidi di iscriverti all’artistico, per un qualche motivo. Magari hai visto un dipinto in un libro di scuola, non ti frega nulla di comunicazione e marketing, né di ragioneria o dello scientifico, e hai questa idea di iscriverti al liceo artistico. È un bellissimo desiderio, ma procedendo, pare che non ci siano molte alternative.
DZ: Sembra di dover ridimensionare quel bellissimo desiderio.
DM: Non rimane che rimodellare la propria immagine di vita su di un’altra, che poggia su di un’atra ancora, oppure girovagare in un percorso tracciato in mezzo alle macerie di un pensiero cui si voleva aderire, ma che non si ritrova in nessun segno. E probabilmente il suicidio, perché non c’è via d’uscita ad un sistema univoco che non lascia alcun margine – se non quello del patologico – ad una differenza autentica. Gli artisti sono scorie.
DZ: Per fortuna, in quanto tali, si può ancora pensare di essere scorie potenzialmente radioattive. Pericolose.
DM: Pericolose sì. Ma non con il nostro lavoro. Penso come esistenze proprio. Come forme di vita, mentre tutte le altre lo sono di morte. Possiamo esserlo come lo è stato quel giovane uomo che a Roma, sceso per strada con una spranga, ha spaccato macchine e teste – indistintamente. Come Kabobo, che al Niguarda ha preso a colpi di machete qualche passante.
—————————————————————————————————————————–
DZ: Posso chiederti una cosa?
DM: Certo.
DZ: In questi giorni ho letto alcuni articoli sull’estetica dei video delle esecuzioni dell’Isis – e sulla relativa campagna mediatica, diffusione sui social, etc. Tu ci hai pensato? Mi interessa un tuo parere.
DM: Ho letto anch’io varie cose. Ma cosa intende di preciso? Vuole sapere cosa ne penso rispetto a tutta la questione o si riferisce a qualcosa in particolare?
DZ: Non so. Non ho ancora un centro. Penso ai video, alle immagini. In un certo senso aspettavo di sentirtene parlare per chiarirmi le idee.
DM: Sembra quello di cui parlavamo poco fa. Di qualcosa che si è staccato e si è trasformato in una pura immagine, scollata da una realtà. È curioso lo sforzo che hanno queste immagini di aderire ad un immaginario, piuttosto che limitarsi a mostrare, in maniera “diretta” – se così si può dire – eventi ed ideologie.
DZ: Penso anche a Dick, il tuo soldato. Anche alla guerra in senso molto più ampio. Ci hai fatto lavorare su degli script per un uomo di guerra. Ed ecco spuntare ancora script. I messaggi all’America.
DM: È interessante come si sta sviluppando la guerra.
DZ: E l’idea della guerra. I messaggi di Bin Laden, quelle inquadrature e modi di gestire le riprese sembrano lontanissimi. Si combatte una guerra caratterizzata da “azioni antiche” e modi di comunicare super contemporanei. Sono riflessioni che continuano a rimbalzare in questi giorni. Non ci sono più i filmati a posizione frontale, riprese a mezzo busto e lunghissimi discorsi in arabo. Ci sono tweet e video con sottotitoli in lingue diverse.
DM: Guardo come si costruiscono i materiali che legittimano delle posizioni, cosa producono. Al di là della retorica della vittima e dell’aggressore, credo veramente che in ultima istanza ognuno di noi viva una condizione di soldato al fronte: prima ancora che fuori o sopra, lo stato di guerra è interno, è alla base dello stesso “Io” di ognuno di noi; i colpi sferrati sono proprio anche le comunicazioni di cui stiamo parlando.
DZ: Sì. E la loro “precisione”.
DM: Oramai la guerra è talmente estesa che l’unico modo possibile per un contrattacco è di tenerlo fuori dai linguaggi. Il che è paradossale e, in qualche modo, la sconfitta inesorabile.
DZ: Una sconfitta di linguaggi.
DM: Sì. E soprattutto della democrazia. E, in termini più prosaici, della sinistra, che ha dato in pasto tutte le resistenze allo… Spettacolo? Impero? Capitalismo? Parole che suonano sempre un po’ ridicole e che uso per capirci. D’altronde, non saprei che altre usarne…
DZ: Un elemento molto “nuovo” è una presa dell’immagine. Uno studio sull’immagine. Sembrano sceneggiature interpretate da attori non professionisti. Si stampigliano in testa per “pulizia”. Per secchezza. L’arancio del condannato. Il nero del giustiziere. L’inquadratura. L’aridità del paesaggio. Nessuna distrazione. Elementi scarnissimi. Conta solo l’immagine.
DM: Pare non esistere più alcun mondo al di fuori dell’immagine – la distanza tra lei ed un reale è oramai talmente ampia da non permettere più alcuna messa a fuoco.Pensialle immagini ad infrarossi. A quelle delle videocamere di sorveglianza. A quelle traballanti dei telefonini. Appartengono tutte a un’unica grande immagine.
DZ: Spiegami meglio.
DM: L’esecuzione di Foley ha un’estetica incredibile da film di finzione, con tanto di disturbi ed altri effetti inseriti in post-produzione, perfino sui font. È il contrario, per esempio, delle immagini che abbiamo visto della guerra in Kosovo, o di quelle dei drone registrate durante i loro attacchi. Ma anche di quelle delle videocamere di sorveglianza, nelle notizie di cronaca di rapine e aggressioni. Diverse anche da quelle raccolte dai cellulari nelle strade di Londra durante le rivolte del 2011, da quelle in streaming delle proteste in Turchia o, ancora, da quelle girate in mezzo ai palestinesi bombardati a Gaza.
DZ: (Seguo)
DM: Ma nessuna immagine è antagonista dell’altra in quanto veicolo di reale. Sono state tutte assorbite e seccate dallo Spettacolo. Banalmente, abbiamo visto film interi girati con i cellulari, con webcam e camere di sorveglianza – non solo di guerra. E poi condivise sui social network, tra gli Youtuber ed i blogger. E via dicendo. Per questo mi chiedevo: ne esiste qualcuna che resiste a quel filmato?
DZ: No, probabilmente no. Sono tutte immagini destinate ad essere fagocitate e perse. Magari puntualizzate prima, ma poi comunque perse. “Assorbite e seccate” – come hai detto tu.
DM: Però dove ci gettano? Intendo, nel nostro quotidiano. Nelle nostre storie d’amore, storie di padri, di madri. Di lavoratori, di artisti, o anche di reietti, di froci e di esistenze al bando.
DZ: (Penso)
Mi viene da dirti che ci relegano. Ad osservatori increduli? Di una scena? Di una sequenza di frame? Delle immagini stesse? Di un film? Sono andata a rileggermi un racconto di Buzzati che non ricordavo bene, ma mi era spuntato alla mente nei giorni scorsi. Inizia dicendo che in un certo paese la pena di morte viene somministrata con grande “delicatezza”. Poi il racconto si avvia. Il signor Troll, condannato a morte e detenuto in carcere, viene portato alla presenza del direttore. Dopo avergli offerto caffè, sigarette e caramelle, quest’ultimo inizia una dissertazione interlocutoria sulla morte. I due si confrontano. Il direttore ad un certo punto propone una sorta di rappresentazione simbolica per chiarire le idee al condannato. Viene chiamata tale Fiorella, ragazza giovane e provocante, parte della messa in scena. Il condannato non dovrà far altro che passare dallo studio alla stanza a fianco. Lì potrà esserci o meno la ragazza – che interpreta grosso modo la vita dopo la morte. In ogni caso, dopo, Troll verrà atteso in ufficio. Solo un’allegoria ben studiata. Una parte. Un immaginario. Il condannato si avvia. Gira la maniglia e apre la porta. In quell’istante da una feritoia comunicante con lo studio, un “tiratore scelto fulmina il signor Troll con un colpo alla nuca.”
La seduzione dell’immagine non ha a che fare con quella “delicatezza”?
DM: Da una finestra aperta su di una strada in mezzo ad una cité di una banlieu parigina, un cellulare filma un gruppo di figure che si scontra con una pattuglia della polizia. Non hanno bandiere né programma, ma dei cappucci neri e una strana febbre. L’immagine è buia. Illuminano i flics qualche lampione, le traiettorie dei gas lacrimogeni lanciati tra le macchine parcheggiate e un cassonetto dell’immondizia che brucia. Le figure nere si muovono agilmente tra le nicchie del bloc, scompaiono dentro ai portoni dei grossi edifici, per poi riapparire sui ballatoi che collegano le diverse torri. Dall’alto, vola una bottiglia, che si infrange sull’asfalto. Un’altra ancora, con accesa una miccia, si schianta su di una volante, che prende fuoco. Una voce – fuori campo – urla “Nique ta mere fils de pute!”. I poliziotti indietreggiano, guardando verso ogni direzione. (Etimologia di banlieu: potere di amministrare un luogo; messa al bando. Etimologia di impero: dominio, ordine e comandamento. Etimologia di patria: terra dei padri; unione dei popoli che hanno un solo linguaggio.)