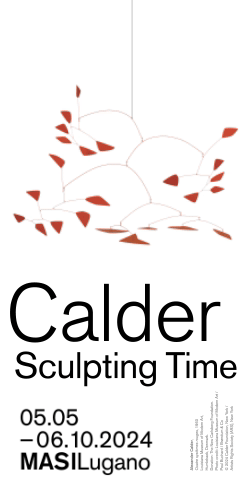Nato nel gennaio del 2019 in quello che una volta era un negozio di oggetti di legno, il Museo Burel di Belluno è grande poco più di una stanza, porta il nome di una delle cime della Schiara ed è diretto da Daniela Zangrando. Diversi è la mostra che segna la riapertura del museo dopo la chiusura degli scorsi mesi e il quarto capitolo di un progetto più ampio intitolato Hai paura dell’uomo nero?con il quale il Burel ha costruito il suo primo anno di programmazione.
Diversi è una mostra corale che raccoglie e focalizza l’attenzione su quattro figure: Jan Fabre, Alberto Tadiello, Mungo Thomson e Gianni Secco. Tre artisti e un collezionista, le cui opere dialogano all’interno dello spazio del museo continuando la riflessione e l’esplorazione del concetto di Altro che- antropologicamente – una figura come l’Om Selvarech (personaggio che popola l’immaginario dei luoghi alpini, ndr) ha la capacità di portare con sé.
Daniela Zangrando ci ha raccontato l’idea e le necessità che l’hanno portata ad aprire una realtà culturale come il Museo Burel, la missione di questo primo anno di attività e la riapertura con la mostra Diversi.
Guendalina Piselli: Inizierei questa conversazione chiedendoti cos’è il Museo Burel di Belluno e come è nato. Ho letto che porta il nome di una montagna….
Daniela Zangrando: È nato per sfida. Nel 2018 è uscito uno studio del CGIA di Mestre sullo spopolamento della Provincia di Belluno, dove sono nata. Penso che di fronte ad una situazione come quella analizzata non ci si possa aspettare che siano solo la politica, il sociale, le aziende, l’educazione e gli altri ingranaggi della società a far qualcosa.
Mi son detta che se davvero credevo in un’arte con una sua precisa funzione sociale e non era solo una frase slogan che avevo studiato, rubato e poi blaterato a vanvera con fare esotico per far colpo, l’arte e la cultura potevano e dovevano diventare la mia arma. Così ho tirato fuori dal cassetto un’idea che avevo da sempre: aprire un Museo.
Per capire perché porta il nome di una montagna, devi venire a Belluno. Le montagne, qui, ci sono sempre. Anche nelle giornate in cui le nuvole si abbassano così tanto da nasconderle alla vista conservano il loro potere, la loro incombenza, una certa pressione. Non sono così vicine come magari puoi immaginare. La città non è appena sotto a cime vertiginose. Non ti basta allungare la mano per toccar le rocce. Ma sono lì. È una consapevolezza da cui è inutile tentare di prescindere.
Per il Museo avrei potuto scegliere un acronimo che in qualche modo tirasse in ballo le parole “arte”, “museo”, “contemporanea”. Invece ho pensato al Burel, una montagna che se ne sta incastonata nel “gruppo complesso, accidentato, rupestre e impervio” della Schiara. (cit. Antonio Berti, 1928).
Questo nome, Burel, per me è come una freccia a due punte. Una è direzionata verso Belluno e la sua comunità. Dice ai bellunesi: voi conoscete bene le fatiche che ha comportato la salita ad una cima del genere! E sapete anche che quella parete è stata vinta solo negli anni Sessanta del secolo scorso. Tardi, è verissimo, ma gli alpinisti hanno trovato un accesso, una linea da seguire anche dove sembrava impossibile. Quindi, alla realtà dei fatti, non c’era niente di infattibile. Per scorgere una linea, una lettura, basta disfarsi di mille pregiudizi e permettersi la seduzione di qualcosa di bello. Con l’arte dovete fare lo stesso sforzo iniziale, scrollandovi di dosso l’idea che sia incomprensibile, irraggiungibile, astrusa, senza senso, che non ne valga la pena! Una traccia comune di accesso vedrete che la possiamo trovare.
L’altra punta va invece in direzione dell’arte, e forse anche del suo sistema. Il Burel è una montagna estremamente severa. E mi intima e intima a quello che si fa in questo Museo di avere un approccio altrettanto severo. Penso in concreto significhi guardare all’arte con un senso etico. Con rigore. Serietà. Con fede. Con coraggio. Costanza. E passione. Sono parole e concetti che ritengo di dovermi imporre. Non sono per nulla scontati.
Credo di averti spiegato in sintesi perché si chiama Burel, e perché è il Museo d’Arte Contemporanea di Belluno e della sua Provincia.
G.P.: Sono rimasta molto colpita quando ho scoperto che Belluno è l’unico capoluogo di provincia in Italia il cui territorio comunale sia in un Parco nazionale. Immagino che questo aspetto influenzi profondamente il legame con il territorio. Come si pone il Museo in questo contesto?
D.Z.: Sì, Belluno si trova all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Ovviamente si tratta di un dato interessante, che peraltro meriterebbe un approfondimento. Tra le varie cose, l’Ente Parco ha sicuramente il merito di aver studiato e schedato le particolarità di quest’area, analizzandone flora, fauna, geologia, biotipi, insediamenti antichi, attività tradizionali, di aver strutturato itinerari, e costruito progetti che vanno dallo sfalcio dei prati e dalla reintroduzione della marmotta all’educazione ambientale. È un lavoro corposo.
D’altro canto però, qui come altrove in Italia, le parole d’ordine sono quelle della valorizzazione – che nel caso del Bellunese spesso si accompagna all’aggettivo “turistica” – e della salvaguardia.
Come fanno notare Pierluigi Sacco e Christian Caliandro in un libro di qualche anno fa (Italia Reloaded. Ripartire con la cultura, 2011), spesso il “concetto di salvaguardia traduce molto bene una visione inerte e sclerotizzata”. Si tende a salvaguardare cose che se ne stanno e se ne devono stare lì, ferme, senza che nessuno le tocchi, le sposti, le modifichi.
E Belluno non si sottrae a questa logica. È così. Nostalgica di tempi di splendore e grandezza ormai lontani, chiusa in un immobilismo che preserva la situazione così com’è. È una città che si guarda allo specchio e si pavoneggia, senza accorgersi di vestire abiti fuori moda e senza voler capire che tutta quella tradizione e quella cultura passata solo coalizzandosi con il contemporaneo e con il pensiero innovativo possono innescare una visione nuova, un’identità forte, radicata nell’oggi, nell’ora, e non costruita su idee cristallizzate e anacronistiche.
Viene naturale sognare un’accelerazione diversa: nel mio caso, il Museo.
Non pensare comunque che io non ami questi luoghi o le persone che ci vivono. O che nelle mie parole ci sia eccessiva amarezza. Sono solo dati di fatto. Chiudo citandoti due casi molto diversi tra di loro, ma con un comune sentore, in cui mi riconosco. Ho risfogliato da poco alcuni scritti giovanili di Pier Paolo Pasolini sul Friuli. C’è un racconto che si intitola “Il disprezzo della provincia”, dove il disprezzo, che serpeggia deciso tra modi satirici e graffianti, si mescola in modo indissolubile con un’enorme tenerezza.
E poi ti faccio il nome di Kent Haruf, scrittore americano di cui la casa editrice NNE ha appena completato la traduzione italiana integrale degli scritti. In tutti i suoi romanzi, lo scenario, e tutto sommato anche l’attore protagonista, è la città di Holt. Anche a Holt, come a Belluno, sembra non accadere nulla di nulla. Ma se si va appena sotto la patina, si scopre un brulichio di desideri, di vite, di rabbia, di possibilità.


G.P.: DIVERSI è il quarto capitolo del ciclo Hai paura dell’uomo nero?. Prima di addentrarci in questo ultimo capitolo, ci racconti il progetto?
D.Z.: L’idea del Museo è quella di andare, anno per anno, mostra per mostra, evento per evento, a considerare elementi, figure, personaggi, contesti che siano subito riconoscibili per la comunità del territorio. Credo sia importante mettere radici in un bacino comune, per potersene allontanare, per porlo anche in discussione, per elaborare senso, per far digerire e conoscere il nuovo e nello stesso tempo per capire meglio se stessi.
Quest’anno è toccato all’Om Selvarech, l’uomo selvatico, personaggio che popola l’immaginario dei luoghi alpini assumendo generalmente le vesti di eroe culturale. È un essere molto complesso, con un proprio codice iconografico e linguistico che cambia a seconda dell’area di provenienza.
Nella rappresentazione locale, ad esempio, è un uomo verde, perché ha il corpo ricoperto di licopodio, una pianta dalle foglioline aghiformi e fibrose, e conduce la propria esistenza occultato nella selva, nei boschi, nelle grotte, in luoghi rocciosi e isolati da cui ogni tanto si separa per scendere a valle ed insegnare ai pastori i segreti – che per svariati motivi non riuscirà mai a confidare interamente – della caseificazione. Magari si crede di vederlo camminando al tramonto al limitare dei paesi, ingannati dall’ombra proiettata da un albero su un tronco vicino. O forse è proprio lui. Non se ne sa molto altro, ma si è certi che abbia doti magiche.
Potresti giustamente obiettare che l’arte contemporanea di derive antropologiche ne ha viste fin troppe e che, con il dovuto rispetto, non le può interessar di meno dell’Om Selvarech che se ne sta in provincia di Belluno.
E ti darei assolutamente ragione. Se non per il fatto che questo non è per me un tema a cui forzare gli artisti. È solo un quadro concettuale, una sorta di perimetro dentro al quale muoversi, un punto di partenza. Una premessa. Mi piace molto la sua possibilità di portare e rimandare immediatamente a snodi di pensiero diversi, legati al contemporaneo.
Qualcosa di questa presenza del Selvatico rende inquieti. Non si lascia capire a fondo. Fa anche un po’ paura. Ha in sé tutto il potere dell’Altro, e questo me l’hanno fatto soprattutto scoprire gli artisti. Abbiamo paura di quest’altro? Chi è? È l’io stesso ad essere altro, come ha suggerito nella sua personale al Museo Luca De Leva andando a recuperare la famosa frase “Je est un autre” di Arthur Rimbaud con tutta la sua svalutazione dello statuto privilegiato di un “io” e la sua conseguente frantumazione? O l’alterità sta in quel continuo slittamento graffiante di piani tra uomo di Neanderthal e uomo Contemporaneo che ha proposto Nathaniel Mellors? O ancora nella forza giudicante e nello stesso tempo salvifica di un’esistenza ritratta e fattasi pura voce, come ha indicato Francesco Fonassi?
E tu? Hai paura dell’uomo nero? Di te stessa, della tua maschera, del tuo pensiero, dell’altro da te, dello straniero, del malato, dello strano, del folle, della tua immagine riflessa, di quello che non corrisponde a ciò che dovrebbe essere?
G.P.: Come si inserisce quest’ultima mostra nel ciclo e come si pone rispetto ai tre atti precedenti?
D.Z.: DIVERSI è una mostra corale. Ci sono i lavori esposti, ma anche tutte le mostre precedenti, i confronti con gli artisti, gli eventi realizzati a febbraio, la possibilità di parlare e di visitare lo studio caleidoscopico di un antropologo, di interagire con i visitatori, di passare molto tempo da sola al Museo con le opere, di seguire il crescere delle parole e delle forme di pensiero della ragazza dei Licei Renier che segue il progetto del Museo e mi aiuta con l’accoglienza e le visite, gli scambi di e-mail e le chat notturne, i lavori scartati, tutti i mascheroni e gli occhi che mi hanno ossessionato, i libri letti, le perplessità e le lamentele di chi continua a dire di non capire, … ci sono davvero tutti dentro. D’altro canto penso sia così per ogni mostra. È un processo di caricamento. Ad un certo punto miriadi di formiche mentali trovano ordine e chiarezza. E la mostra è bel che fatta.
DIVERSI è la chiusura di un anno di lavoro. E in qualche modo già apre al prossimo.


G.P.: La mostra ospita le opere di tre artisti (Jan Fabre, Alberto Tadiello, Mungo Thomson) e di un collezionista (Gianni Secco). In che modo i loro lavori dialogano costruendo la mostra e indagando il concetto di diversità?
D.Z.: Quando racconto la mostra dico che la prima stanza ha qualcosa di sospeso, ma nello stesso tempo di cupo e di oppressivo. Entri e ti senti osservato. Ci sono una miriade di volti diversi, di altri, che non ti danno tregua. Di maschere. Di larve. E se la larva porta questo nome proprio perché maschera dell’insetto perfetto, credo non ci sia termine migliore per descrivere il pullulare sulle pareti della sala. Sul lato sinistro, le maschere provenienti dalla collezione di Gianni Secco. Sono maschere svuotate del volto, dimentiche di qualsiasi perfezione; corpi privati di personalità, senza anima. La loro forza, quella del sentimento, sia esso disperazione o pentimento, furore o sottomissione, compassione o goliardia, qui è solo muta indifferenza. Sostenere i loro sguardi fissi e incorporei è davvero difficile. Dall’altra parete rispondono le bocche spalancate, gli occhi allucinati, le narici dilatate del lavoro di Alberto Tadiello. Niente si salva. Qualche tratto bianco, qualche taglio di luce, ma il resto è totale nerezza, virale spavento, grida. Lo spiritello diabolico di Jan Fabre, seduto sopra al suo cervello, intento forse a studiare come rendersi invisibile per meglio ferire, aleggia. È piccolo. Puntuale. Sorride, mi hanno fatto notare i bambini. Ma ho ragione di temere che, il suo, sia sorriso di scherno, o di provocazione.
Larvale, nella seconda stanza, anche il volto di Bob Anderson, nel video di Mungo Thomson. Poco più di un fantasma. Tutto quindi si ferma qui? È una sorta di resa? No, direi di no. Credo che il lavoro di Thomson rigiri la mostra. Dia una ventata di ossigeno. Forse ha addirittura una chiave di riscatto. Uno spadaccino, anziano, si sistema con grande compostezza, e, per tutte le ore di apertura della mostra, continua a passare la spada, a lanciarla dritta a chi gli sta di fronte. A chi guarda il lavoro. Quella che vuole mettere in mano di chi è lì, credo sia una possibilità. Leggerissima, appena accennata, quasi evanescente. Magari qualcuno la coglierà, la farà sua. E rigirandosi a guardare maschere e volti prima di uscire, ripenserà ad una delle cose più affascinanti che mi ha raccontato Gianni Secco. Parlandomi del Selvatico, mi ha detto che tutte quelle maschere, quei volti, altro non sono che personaggi mitici tesi a riscattare un passato per un futuro migliore, a cui tutti – loro che inscenano trasferimenti di energie e poteri e chi ci crede – contribuiscono. Questo pensiero ha una grande forza di rigenerazione. Che è la stessa che penso abbiano le opere, per sua natura, l’arte.
La mia però è solo una possibile lettura. Preferirei di gran lunga conoscere quella degli altri.
G.P.: DIVERSI segna anche la riapertura del Museo dopo la chiusura imposta dalle norme per il contenimento del COVID-19. Come avete affrontato questo periodo di chiusura? Che significato assume una riapertura per il Museo?
D.Z.: Questa chiusura è stata importante. Per studiare. Per pensare con agio. Per mettere a soqquadro tutto. Un cambiamento di abitudini, libertà, estetica, vita come quello a cui stiamo assistendo, non può lasciare l’arte e il contemporaneo indifferenti. E non può nemmeno essere ignorato. Eppure, qualche settimana fa, durante una telefonata con Luca De Leva, ci siamo detti e ripetuti che forse non siamo pronti per restituire tutto questo in un sistema di pensiero articolato e coerente. Le idee ci sono, ma vanno lasciate sedimentare.
L’inaugurazione di DIVERSI è stato un momento particolare, speciale. Conseguentemente alla normativa vigente, le persone sono entrate al Museo una alla volta, o in gruppetti sparuti. Mi è parsa subito una potenzialità. E posso dirti che è stato molto intenso veder entrare ogni singola persona. Normalmente le inaugurazioni del Museo Burel vedono tavoli di rinfresco davanti alla porta di ingresso, capannelli di persone in attesa di entrare – lo spazio, come sai, è molto piccolo – e intente a chiacchierare e discutere, discorsi inaugurali. Dopo la prima parte dell’opening e di visita alla mostra, ci si trasferisce in uno dei locali delle vicinanze, dove i dj del Museo danno vita a delle serate musicali dalle sonorità elettroniche. L’inaugurazione a quel punto diventa una festa. Per parlarsi bisogna star vicini e urlare le eventuali domande o curiosità alle orecchie di artisti e visitatori che si son fatti ballerini, e l’atmosfera cambia completamente. Tutte le inaugurazioni fatte fin qui sono state innesco di nuove reti, di complicità inaspettate, di conoscenze e sodalizi, e considero questo aspetto di aggregazione sociale rilevante.
Con DIVERSI invece l’accento principale si è spostato sul rapporto intimo, a tu per tu, tra visitatore e mostra, o meglio, tra il visitatore e l’opera che aveva di fronte. Non c’è stata alcuna reale privazione. Solo la massima concentrazione sull’arte e su chi aveva scelto di venire a incontrarla.
Non abbiamo rinunciato nemmeno al consueto dj-set, che è stato trasmesso in diretta su una piattaforma online. Magari qualcuno avrà pure ballato, nella propria cucina, con le luci abbassate e il computer aperto sul tavolo, con ancora negli occhi gli sguardi delle maschere, dei fantasmi, del diavolo, dello spadaccino. Non sarebbe bellissimo?