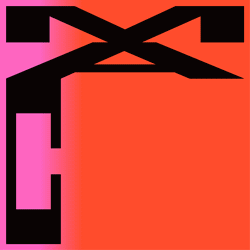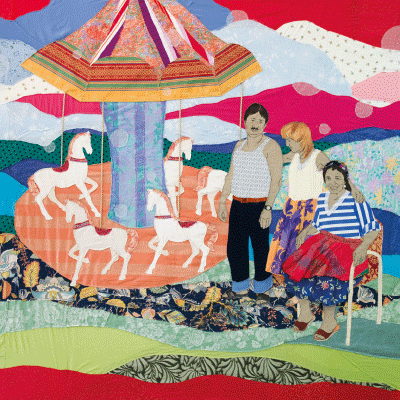Come si muove un progetto artistico che rifiuta di fissarsi in un solo linguaggio, in un solo spazio, in una sola voce? Come si attraversano i confini della scena, della musica, e della città, senza disperdere la complessità, ma anzi amplificandola?
CORPS CITOYEN è un organismo vivo, un dispositivo in movimento che pratica l’arte come strumento di attivazione politica e desiderio collettivo. A partire da Barrani, performance-concerto diventata anche disco, fino ai processi educativi, urbani e comunitari di Milano Mediterranea, la loro traiettoria è un continuo spostamento: tra paesi, lingue, formati, corpi.
In questa conversazione, Anna Serlenga e Rabii Brahim ci guidano in un pensiero che tiene insieme cura, militanza e creazione, disinnescando stereotipi sulla partecipazione, decostruendo le istituzioni culturali e interrogando il futuro attraverso un’estetica decoloniale, plurilingue e radicalmente generosa. Il 30 giugno arriva anche Riders, performance fruibile su ruote, costruita con chi la città la vive pedalando, consegnando, resistendo.
Lavorare dentro una piattaforma artistica proteiforme significa attraversare più linguaggi e spostarsi tra codici pubblici e intensità, dalla musica alla performance, passando per il teatro, l’arte partecipativa. Penso a Barrani, una produzione teatrale che ha già tournée internazionale e uno spin off, un disco. Come si attraversano queste soglie senza perdere densità? Cosa resta? Cosa muta quando una narrazione pensata per la scena si espande nello spazio sonoro, si sposta tra corpi, città, geografie, pur continuando a interrogare chi guarda, chi ascolta? Chi partecipa?
Anna Serlenga: CORPS CITOYEN è stato pensato fin dall’inizio come un dispositivo mutevole. Abbiamo sempre lavorato su due livelli: da un lato, adottare una postura politica, affrontando questioni urgenti legate al mondo e alla società che abitiamo, e lo facciamo attraverso la performance; dall’altro, già nei primi anni in Tunisia, è stato evidente che per operare in modo decoloniale servisse uscire dagli spazi chiusi della scena.
Era necessario stare per strada, attraversare territori complessi, coinvolgere le comunità e attivare veri processi partecipati. Anche i processi hanno cambiato forma e formati a seconda delle collaborazioni e delle epoche, diciamo, in cui sono nati. Abbiamo lavorato spesso con lo strumento audio, collaborato con professionisti di arti visive, con il mezzo video, e ancora con la danza, con il corpo, riscrivendo sempre lo spazio urbano e pubblico.
Barrani nasce come una performance-concerto dove abbiamo sperimentato il sonoro come un campo di echi, riverberi e parola dove è diventato quasi scontato, ed è bello immaginarlo anche in un formato disco, proprio per restituire alla composizione musicale una sua autonomia, un suo corpo, a sé. E in quella traduzione chiaramente abbiamo scoperto delle cose nuove, ma abbiamo anche riscoperto il multilinguismo che già è presente nella performance, ma che si è amplificato nel disco. Abbiamo cercato di tradurre e moltiplicare gli effetti attraverso un lavoro anche che è passato da Auditorium 900, quindi da una a uno studio di registrazione molto atipico con una tecnica anche antica in qualche modo.
Quindi cambiano i dispositivi, cambiano i formati, ma chiaramente in questo lavoro di traduzione come sappiamo, qualcosa sempre si aggiunge. Qualcosa invece è intraducibile e si perde e ci è interessato soprattutto in Barrani, ma in generale anche lavorare in tutte quelle zone di intraducibilità, quindi tutto ciò che non è possibile tradurre ma che quindi forse va anche ripensato dentro altre lingue o in altri formati.
Forse si può dire che la nostra geografia, così specifica, influisce profondamente sul modo in cui lavoriamo. Siamo un collettivo nato a Tunisi, con un’anima doppia che si muove tra le due sponde del Mediterraneo, il Nord e il Sud Italia, la Tunisia, e questo progetto è anche un omaggio a quello che definiamo uno spazio terzo: uno spazio liminale, uno spazio di mezzo. Uno spazio che è anche un tempo, sospeso tra passato, presente e futuro; e al tempo stesso, tra luoghi che sono culture, patrimoni, archivi viventi. In qualche modo, vogliamo celebrare proprio la possibilità di ibridare tutti questi elementi, di farli dialogare, trasformarsi, contaminarsi.
Che cosa significa per voi fare cittadinanza attraverso l’arte, quali forme scegliete, quali strumenti, che cosa vi guida nel rapporto con i territori che attraversate?
Rabii Brahim: Lo strumento è la pratica stessa, dunque l’arte. Ma anche aprire spazi di pratica artistica accessibili a chiunque. Condividerla, farla insieme. Pensarla e progettarla collettivamente, per creare luoghi dove qualcosa possa nascere o prendere forma: un’espressione artistica, culturale, condivisa. Un’espressione senza confini, multiculturale, multilingue, libera.
Anna Serlenga: Per quanto riguarda gli strumenti, ne utilizziamo diversi. Da un lato ci sono i progetti partecipati, in cui coinvolgiamo attivamente le persone che abitano un territorio, in questo caso quello specifico del quartiere Giambellino-Lorenteggio. Spesso sono adolescenti o soggetti che solitamente non si misurano con l’arte in prima persona, da protagonisti. Accompagniamo queste persone in un processo di presa di parola che trova forma all’interno di Milano Mediterranea, che possiamo definire “dispositivo curatoriale”. Milano Mediterranea è nato per un territorio specifico nella città di Milano, ma che attualmente grazie ad un progetto europeo titolato “Neighborhood Committee of Care”, sta accompagnando nella sua sperimentazione altri territori e realtà culturali indipendenti. Alla fine è una sorta di attivatore territoriale che fa della partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine, il suo cuore. Per Milano Mediterranea abbiamo fondato un Comitato di Quartiere che seleziona le proposte artistiche ricevute tramite call. Parallelamente, sosteniamo attivamente una comunità di artisti e artiste razzializzati in Italia attraverso una call dedicata, come forma di affirmative action. Il tutto avviene in un quartiere periferico, dove gli interventi artistici sono pensati per essere accessibili e creare occasioni di incontro, scambio e negoziazione collettiva. Crediamo che tanto i progetti partecipativi quanto quelli curatoriali siano strumenti fondamentali di cittadinanza attiva.


Nel vostro lavoro si sente forte una tensione tra pedagogia, attivismo e arte. Come convivono? Si scontrano questi tre piani dei nostri progetti, pedagogia, attivismo e arte.
Anna Serlenga: Questi tre piani spesso si intersecano in effetti. Citerei due esempi di progetti che hanno un forte taglio educativo e pedagogico, molto diversi tra loro. Il primo è stata l’esperienza fatta con Trap Community Opera dove abbiamo coinvolto un gruppo di giovani tra i 15 e i 20 anni, nella scrittura, ideazione, poi nella creazione musicale e nella sua performatività, attraverso la danza di un’opera musicale Trap – che chiaramente, coinvolgendo una comunità specifica, cioè dei giovani di un quartiere popolare di Milano come San Siro, aveva anche un forte target direi politico, di diritto alla città.Tutta l’opera si è articolata tra il racconto di un quartiere periferico che potrebbe essere appunto San Siro o Giambellino e l’idea di simbolica di andarsi a riprendere il centro della città, mettendo al centro della narrazione le voci di questa generazione che tra l’altro vive un momento di forte stigmatizzazione di stampo classista e razzista a Milano dentro la retorica dei “maranza”.
Il progetto è stato fatto all’interno di un percorso pedagogico “tradizionale”, in collaborazione con l’Istituto professionale Galilei-Luxembourg di Milano: una scuola professionale dove tendenzialmente, le persone iscritte hanno come prospettiva di terminare li il ciclo degli studi ed andare a lavorare. E come spesso diciamo, per noi è importante il fatto che l’arte sia uno spazio di prefigurazione del sé e quindi uno spazio di prefigurazione di altri scenari per se stessi che non siano quelli dati, quelli che la società prescrive per certi corpi e certe storie, e mi riferisco chiaramente a persone che vivono esperienze di razzializzazione, di stigmatizzazione di classe. E questa dimensione di possibilità che l’arte offre di prefigurarsi un’altro sè credo che sia l’ottimo incrocio tra la pedagogia, l’attivismo e appunto l’arte che ritrovo anche nel secondo percorso che vorrei citare.
Penso a PTM!Pass the mic – Decolonizing education through arts, un progetto di ricerca che avevo condotto con l’Università Iuav di Venezia grazie ad un grant di Creative Europe in collaborazione con Centrale Fies, Onassis Foundation ad Atene e l’associazione Ebano a Lisbona, dove il presupposto era lo stesso: entrare nelle scuole superiori, dove si apre la forbice tra chi avrà la possibilità di proseguire gli studi nella formazione superiore e chi invece entrerà direttamente dentro il mondo professionale e provare proprio lì, attraverso la l’arte, quindi le arti contemporanee e in modo particolare le arti performative, dove però appunto artisti e artisti della comunità razzializzata si sono confrontate con classi di queste scuole. L’idea era proprio la stessa, cioè provare a ragionare e riflettere intorno a un nuovo spazio di prefigurazione per il sé.
E l’ultimo esempio che citerei invece è Scuola decoloniale, che è un formato che abbiamo ideato durante Twiza Festival nel 2023, dove invece abbiamo invitato artisti ed artisti che praticano e riflettono intorno alla decolonialità, a condividere le proprie pratiche con diversi tipi di pubblici – dai bambini, lavoro che è stato condotto da Archive Milano, fino appunto a un pubblico adulto. Anche qui ritrovo questa necessità di uscire dai formati canonici della della pedagogia e ripensare la pedagogia come parte di una pratica che partecipa al cambiamento tanto quanto l’arte.
Qual è il vostro posizionamento politico rispetto alle istituzioni culturali tradizionali e come scegliete se e quando attivare una relazione
Anna Serlenga: Direi che siamo per l’hackeraggio: hackerare degli spazi istituzionali e provare ad abitarli a nostra maniera, dove chiaramente cerchiamo di dialogare con istituzioni che siano porose e che siano al contempo disponibili a mettersi in discussione. Penso per esempio alla relazione che abbiamo avuto nel triennio 22-24 con BASE Milano, dove siamo stati artisti associati ed è stata una relazione di mutuo scambio, dove di fatto a fronte di un sostegno produttivo, però noi abbiamo anche costruito e portato temi, e pratiche di decostruzione. Penso per esempio a un capacity building, che stiamo ultimando e mettendo in forma, che nasceva appunto da una proposta di Linda di Pietro, la direttrice artistica, di ragionare sull’accessibilità dei centri culturali e dove noi abbiamo portato una pratica che parte proprio dal ripensamento anche della struttura interna dei team, di come vengono articolate le scelte rispetto a c’è e chi manca all’interno delle squadre; a come vengono articolate le scelte di programmazione e di accoglienza dei pubblici. Penso anche al rapporto molto positivo che abbiamo avuto con Hangar Bicocca lo scorso anno, dove siamo abbiamo curarto una giornata del Festival Re-Mapped dedicato alla scena indipendente milanese riuscendo a portare un lavoro dedicato alla resistenza palestinese dell’artista Soukaina Abrour, insieme al collettivo di sarte attiviste milanese Serpica Naro in un momento molto difficile e teso rispetto a questa questione, soprattutto dentro ai grandi centri culturali.
Rabii Brahim: Partendo sempre dal presupposto che le istituzioni culturali sono un spazio e un diritto alle cittqdinbe, ai cittadini e alla cittadinanza tutta, purtroppo quando prendono importanza o volume o grandezza spesso i cittadini non hanno più accessi, noi cerchiamo di riaprire le porte di queste istituzioni.


Che ruolo ha il linguaggio nei vostri processi in un contesto plurilingua e diasporico? Come si costruisce la lingua dell’incontro e nel caso, se è davvero questa la via?
Anna Serlenga: Io penso che rispetto alla lingua ed ai linguaggi noi abbiamo molto sperimentato sia con Milano Mediterranea che nella nostra pratica performativa, quindi, con Barrani; l’esperienza di Milano Mediterranea è stata molto interessante, perché ci siamo chieste come poter raggiungere dei pubblici che normalmente non sono partecipi né nel disegnare la proposta culturale, né nel fruirla e quindi una delle strategie che abbiamo adottato in questi anni è stata quella della multilinguismo, cercando appunto di tradurre la nostra comunicazione nelle lingue maggiormente parlate all’interno del quartiere, che vanno appunto dall’indi, al filippino, alla lingua/e della comunità sinti allo spagnolo, all’arabo, all’italiano e l’inglese. Chiaramente questi sono spesso tentativi non sempre riusciti, però devo dire che in questi anni ci hanno dato modo, per esempio, di allargare il bacino d’utenza del nostro comitato di quartiere, che da essere al primo anno completamente “bianco” è diventato un comitato di quartiere che finalmente è misto, direi, che quindi ci assomiglia molto di più e che appunto nasce dal desiderio di disinnescare la dinamica di potere non solo nella scelta della comunità artistica, ma anche di quella, appunto, di chi la disegna, di chi la pensa dall’altro lato.
All’interno invece della nostra ricerca performativa in Barrani è stato molto forte il fatto di di stare anche nel discomfort che genera l’incomprensione, l’incomprensibilità. In Barrani noi usiamo appunto l’italiano, l’arabo tunisino e l’arabo classico e la performance è pensata in queste tre lingue, per cui chiaramente all’interno del pubblico ci sarà qualcuno che può fruire tutta la performance, ci sarà qualcuno che ne fruirà metà, ci sarà qualcuno che non ne fruirà nulla. E abbiamo molto riflettuto intorno alla possibilità di mettere dei sottotitoli. Abbiamo scelto alla fine di avere una piccola pubblicazione che contiene i testi tradotti in tripla lingua, ma che di fatto si può fruire durante o dopo il lavoro, perché ci piaceva anche che ci fosse questa possibilità di stare dentro quella zona di comprensione che non è immediatamente razionale e linguistica, ma che passa da altri codici espressivi, ad esempio quello del corpo, della voce, dell’intensità di un’emozione.
Cos’è oggi Milano mediterranea? Magari anche che forma ha preso rispetto all’idea iniziale?
Rabii Brahim: Milano Mediterranea oggi per me è un è un dispositivo, un contenitore, uno spazio di condivisione, una porta aperta. Prima che nascesse questo progetto, io come artista tunisino arrivato a Milano con tutte le proposte che ho ricevuto, non ho sentito me stesso accolto dentro uno spazio dove poter essere me stesso e dove potermi esprimere pienamente come artista: da qui nasce la necessità di creare questo questo spazio. Oggi questo spazio ce l’abbiamo, ce l’abbiamo perché l’abbiamo creato, anche perché non ci piaceva quella modalità di “dare spazio” attraverso quel rapporto di potere che ti mette dentro un’attitudine coloniale, un’attitudine paternale, patriarcale che rifiutiamo; abbiamo voluto libertà per noi stessi e per artisti e artiste che ci assomigliano, con cui condividiamo delle condizioni e delle idee, dei bisogni. E oggi sono contento anche che l’attitudine stessa, l’idea stessa di Milano Mediterranea di andare a rivendicare, creare spazi del genere si sia moltiplicata nella città di Milano!
Anna Serlenga: Sì, infatti io direi, forse aggiungerei che anche con l’ultimo progetto europeo che abbiamo fatto finanziato di European Cultural Foundation, che abbiamo chiamato Neighborhood Committes of Care, dove abbiamo portato la pratica di Milano Mediterranea come una pratica che che si può anche adattare ad altri contesti – in questo caso a Berlino con Tatwerk Performmative Forschoung, e a Budapest con Sandwich Bar e il Festival PLACCC. Penso che Milano Mediterranea stia diventando anche un dispositivo curatoriale che può accompagnare anche altri luoghi e che è al contempo radicato nel suo quartiere , quanto nomade tra il Sud del Mediterraneo e il mondo. Io la trovo una forma anche di generosità, non affezionarsi e non chiudersi in una qualcosa che si è trovato, ma di provare a rimetterlo in discussione anche nella relazione con altre situazioni culturali indipendenti come noi.
Come lavorate concretamente nei quartieri? Cosa attivate con chi e in che tempi?
Anna Serlenga: Noi abbiamo negli anni costruito un comitato di quartiere che è un gruppo di cittadine e cittadini, lavoratori, lavoratrici e studenti, persone che abitano e amano il quartiere, con i quali ogni anno scegliamo le proposte da realizzare all’interno del quartiere, dopo aver lanciato un open call che appunto è rivolta solo a artiste ed artisti delle comunità delle diaspore già residenti in Italia. Ogni anno quindi abbiamo almeno una, se non due o tre residenze artistiche che però hanno come Focus la relazione con il quartiere e con gli abitanti e la processualità. Sono progettualità che si devono costruire all’interno delle residenze e non accettiamo quindi progetti chiusi ma invece processi aperti. E lavoriamo in relazione a spazi che non sono nostri, perché non abbiamo uno spazio, quindi in relazione a spazi del quartiere che vanno dal Mercato Lorenteggio, dove abbiamo un ufficio, al fioraio, al parco pubblico, al Barber Z6, al ristorante o allo schischabar. E questa è un po’ la modalità collaborativa che abbiamo sperimentato, sia per una questione di sostenibilità ma anche di nuovo per uscire nei luoghi della quotidianità, essere porosi alla relazione con dei pubblici imprevisti.
Il vostro modello di governance è misto intersezionale? Come si bilancia la curatela tra artisti e cittadini e istituzioni?
Rabii Brahim: Forse potremmo dire che abbiamo una modalità che è aperta ma controllata, direi cioè guidata, per cui appunto ci sembrava importante come curator3 aprire la dimensione di potere che sta all’interno della della direzione artistica. E squadernarla e condividerla con anche cittadini e artisti che in qualche modo coinvolgiamo all’interno dei processi decisionali che sono quelli anche di programmazione di produzione culturale. Chiaramente abbiamo anche degli spazi in cui noi teniamo ad avere un’ autorialità ad esempio, penso al Festival Twiza dove chiaramente abbiamo una parte di direzione artistica autonoma, ma dove confluiscono di fatto poi produzioni delle residenze artistiche e i discorsi che gravitano all’interno degli ambiti di produzione. Rispetto alle istituzioni, chiaramente siamo in un dialogo diverso a seconda della delle Istituzioni di riferimento, ma spesso ad esempio attiviamo coproduzioni. Penso a Base Milano, penso a Moleskine Foundation.



Quali Byas vi trovate ad affrontare più spesso? Possono essere culturali, istituzionali e artistici. O le guerre del linguaggio da dove arrivano, come li attraversate?
Anna Serlenga: Allora io penso che la prima cosa, il primo bias che ci troviamo ad affrontare è spesso quello del sociale, nel senso che spesso ci troviamo a dover assolvere ad un ruolo sociale, quando in realtà il nostro strumento principale resta lo strumento di creazione artistica; per noi è fondamentale che sia pensato dentro la società, per la società, per il cambiamento sociale e politico del nostro paese, del nostro contesto di riferimento. Ma rivendichiamo anche il nostro essere artisti e curatori e curatrici e il fatto che esistono dei processi autonomi dove l’arte è politica di per sé, nel suo esistere. E il fatto di provare a costruire degli spazi di interazione e di co-costruzione di senso con la realtà sicuramente è importante per noi, ma non deve essere confuso invece con un assistenzialismo o con una forma di cosmesi di alcune istituzioni pubbliche nel proporre dei progetti artistici come delle soluzioni a dei problemi che in realtà sono problemi strutturali e che non vogliamo risolvere noi. Ma che anzi forse su cui è importante anche mettere degli spazi di visibilità proprio dei buchi, nelle fratture e non nel creare invece tappi.
Come si tiene vivo il senso di co-creazione? Come si distingue un processo realmente partecipato da uno performativamente inclusivo? Diventa maquillage e allora sicuramente per noi ha a che vedere da un lato con cercare di non essere estrattivi mai e quindi di non lavorare a proposito di o su una storia, ma di farlo con i diretti o le dirette interessate e di negoziare anche quella forma di partecipazione. Penso ad esempio al lavoro che stiamo portando avanti in questo momento con Riders, che è una performance appunto in bicicletta che vuole coinvolgere la comunità dei riders milanesi. E appunto, prendere in qualche modo il loro punto di vista sulla città, sul lavoro e sui limiti che la che la città della produzione ha nelle vite di noi tutti, ma appunto, vogliamo che siano i rider stessi ad avere voce in questo lavoro comune. E quindi, ad esempio, intanto le persone che lavoreranno con noi e per noi sono retribuite come lo siamo noi e sono quindi fanno un lavoro da performer. Secondo i contenuti, la presa di parola è una presa di parola che parte dalle loro interviste, ma che negoziamo e che discutiamo insieme. E sono partecipanti attivi, in prima linea. Non racconteremo le loro storie, ma saranno loro stessi a incarnare le loro storie in qualche modo, e questo ci sembra che sia un modo di dare un segnale anche molto preciso rispetto alla presa di spazio e anche al fatto che è un lavoro e non è estrarre valore e poi prenderlo e tradurlo in un’opera su cui noi per esempio facciamo dei soldi o che circuitiamo no? Questo mi sembra importante come postura decoloniale. L’altro pezzo ha a che vedere appunto con l’essere molto consapevoli dei sistemi che ci circondano. Per cui, ad esempio, rispetto al lavoro territoriale, è chiaro che quando c’è un interesse pubblico che per esempio, spinge e che amplifica dei processi di gentrificazione, dobbiamo essere consapevoli che quel rischio di partecipare a un progetto cosmetico esiste.
Cose quando vedremo a Milano a breve? In che modo l’apparizione pubblica sarà anche un’azione di advocacy? Ma con riders cosa vedremo a Milano a breve e in che modo questa apparizione pubblica sarà anche un’azione di advocacy?
Rabii Brahim: La prossima tappa nostra sarà il progetto Riders che stiamo realizzando adesso con la comunità dei riders grazie ad un contributo di Action Aid in partenariato con So. De. Social Delivery, Meraki associazione culturale e Sai che puoi?. E sarà nella città di Milano una performance itinerante dove il pubblico sarà coinvolto con le bici, farà i percorsi che di solito fanno i riders. Ascolterà delle storie, magari guarderà e vivrà gli spazi attraversati con un’altro occhio, con un’altra visione.
Cerchiamo di far esperire allo spettatore un’esperienza che appunto è come il lavoro dei rider, è collettiva ma individuale, per cui ciascuno fruirà di questo lavoro con il proprio telefono e con la propria bicicletta. E incarnando una “soggettiva” che è quella di dei rider stessi, in tre percorsi che si snodano all’interno della città di Milano e che vogliono in qualche modo raccontare sia le forme di libertà che questo lavoro offre, ma anche le costrizioni. E che vogliono essere appunto osservate non come elementi paternalistici, ma come delle domande che interrogano anche la nostra esperienza di cittadini e cittadine che fruiscono di questa città, che ci lavorano dentro e che ci abitano, quindi in qualche modo prendere un punto di vista privilegiato, che vuole anche essere un punto di vista che reclama un diritto alla città e un diritto al lavoro.
Come lavorate alla costruzione di immaginari futuri non eurocentrici? Esistono genealogie, alleanze o pratiche che vi fanno da riferimento da controcanto da bussola? E come lavorate alla costruzione di immaginari futuri non eurocentrici? Esistono genealogie, alleanze o pratiche che vi fanno da riferimento da controcanto da bussola?
Direi che a livello italiano in questo momento siamo molto felici di essere parte di una comunità di pratiche, perché quando siamo tornati a Milano nel 2018 questa comunità di pratica ancora non esisteva, o almeno noi non la vedevamo forse. E in questi anni ha molto evoluto questo dibattito intorno a quello che può essere una pratica culturale, artistica decoloniale. E oggi siamo parte di una costellazione. Ad esempio a Milano penso ad Archive, penso a Blackness Fest, penso a Divercity, Darna, penso a Giovani Palestinesi che stanno portando avanti in modo molto serio e molto preciso e posizionato una serie di discorsi che sono al contempo culturali e politici a livello italiano. Si sono generate tante pratiche anche a livello nazionale: per esempio la fellowship Agitu Idea che promuove Centrale Fies, con cui spesso, appunto, il bacino artistico di riferimento non è molto lontano. Penso in qualche modo a degli sforzi che stanno facendo alcuni Festival italiani come Short Theatre; c’è una sperimentazione che si sta muovendo e di cui ci sentiamo fieramente parte e e che sicuramente è una modalità, cioè sapere di fare ognuno un pezzettino, ma di contribuire a un discorso comune. Un modo di collaborare alla costruzione del cambiamento; poi ci sarà probabilmente un momento in cui non avremo più bisogno di mettere l’accento su questa dimensione, ma in cui sarà, spero, la normalità.
Rabii Brahim: Anche per evitare un po’ la la scappare da la il pericolo dell’effetto moda e branding.
Anna Serlenga: Sì, chiaramente che abbiamo visto un po’ esplodere in tanti Festival europei in questo momento nelle programmazioni dove magari l’artista razzializzata o razzializzato diventano un po’ il token di facciata senza spostare di 1 mm le proprie pratiche strutturali. Però appunto in questi anni possiamo dire di aver visto cambiare anche alcune istituzioni e in maniera sincera. Speriamo che possano essere sempre di più e che si possa costruire insieme qualcosa di grande e che finalmente insomma porti un cambiamento e in questo momento sicuramente un pensiero va alla alla lotta per la liberazione della Palestina, che non può che essere una priorità rispetto a un discorso decoloniale in Europa e che speriamo possa portare a alla fine del regime di occupazione.
Rabii Brahim: Perché crediamo che non possiamo fare un discorso di coloniale quando dall’altro lato cerchiamo di legittimare un colonialismo con tutti i suoi aspetti.