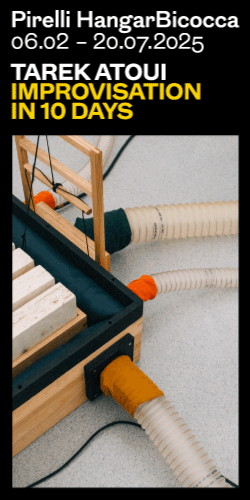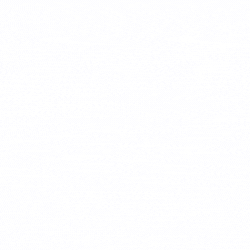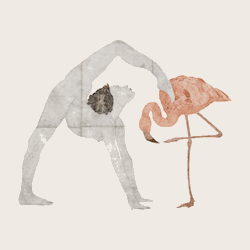A quanto sembra, è in corso un vero e proprio assalto alla diligenza della pittura: curatori che si ricredono, artisti che cambiano medium, galleristi e collezionisti in corsa per accaparrarsi nuovi talenti. Non ci sarebbe niente di male, se tutto questo non avvenisse in una sorta di terrain vague creatosi in decenni di oblio critico. Questo analfabetismo di ritorno, cui hanno concorso riviste musei e accademie, ha creato alla lunga un ambiente sterile in cui si è quasi estinta la connoisseurship, cioè quella sensibilità colta che può svilupparsi solo per mezzo di un’appassionata frequentazione del proprio oggetto d’interesse (i dipinti in questo caso). Senza questa sensibilità – la buona volontà, l’attrezzatura intellettuale e gli aggiornamenti sul dibattito contemporaneo risultano di scarsa efficacia quando si tratta di distinguere tra un buon quadro e uno cattivo, tra un remake ironico e un involontario epigonismo, tra una pittura colta apparentemente grezza e una pittura banale apparentemente raffinata. Senza questa sensibilità, per capirci, le migliaia di nature morte che vediamo in giro, da Chardin alla pizzeria sotto casa, non saranno altro che stupide nature morte.
Qualche tentativo serio per riconsiderare la pittura attuale è stato fatto (all’estero naturalmente): qualche grande mostra, come Painting 2.0: Expression In the Information Age (2016) e alcuni libri ambiziosi, come The love of painting. Genealogy of a Success Medium (2019) di Isabelle Graw (2016). In generale però, mi pare sia molto raro trovare testi recenti di una certa ampiezza e ambizione intellettuale che siano anche in grado di entrare nello specifico pittorico delle singole opere. E così sono rimasto doppiamente colpito quando, qualche mese fa, ho letto il saggio di Hans Theys sull’opera di Walter Swennen[1]. Il testo, lungo e articolato, ha vari pregi tra cui appunto la capacità e il coraggio di (ri)affrontare questioni generali senza smettere di rapportarsi alla forma materiale dei singoli dipinti.
Devo aggiungere che Swennen è un artista eccezionale. Ho visto per la prima volta dei suoi quadri una decina d’anni fa grazie alla gallerista londinese Domo Baal e sono rimasto subito affascinato da quelle tele apparentemente grezze, apparentemente astratte, apparentemente stupide. Sapevo che aveva già superato i sessant’anni e che in Belgio era un pittore rispettato, ancorché schivo e senza particolare successo commerciale. Quando ho cercato di documentarmi, ho scoperto che in circolazione non si trovava che un assurdo catalogo con una quantità esagerata di riproduzioni, talmente piccole da essere quasi illeggibili. Nel frattempo, per fortuna, le cose sono molto cambiate e ora Swennen lavora con grandi gallerie ed espone in importanti musei. Due anni fa, alla Triennale di Milano c’è stata, a cura di Edoardo Bonaspetti, la sua prima mostra in un’istituzione pubblica italiana. Il titolo suonava come una piccola profezia: La pittura farà da sé.
In breve, ho pensato che mi sarebbe piaciuto far circolare questo saggio in Italia. E, con l’aiuto di Giuditta Gentile, ho cominciato a tradurlo. Quelli che seguono sono solo i primi quattro “capitoli”, cioè poco più di un decimo del testo. Qui il discorso è ancora piuttosto generale, laddove nei successivi l’autore entra nel merito di categorie specifiche della rappresentazione e analizza dettagliatamente alcuni quadri. Il lettore potrà trovare il saggio nella sua interezza, tra un paio di mesi, nella “digital library” del sito KABUL Magazine – un interessante esperimento di archivio online di testi tradotti in italiano.
Luca Bertolo, Seravezza, dicembre
2019
[1] Il saggio fa parte di un ambizioso progetto editoriale curato da Theys, dedicato a Swennen, costituito da tre bellissimi libri pubblicati nel 2016 in occasione della sua mostra Hic Haec Hoc, alla galleria Xavier Hufkens di Bruxelles.

Hans Theys
Ne Quid Nimis
Alcune parole sull’opera di Walter Swennen
Traduzione di Luca Bertolo e Giuditta Gentile
Il primato del testo (Franz Kafka)
Quando mi occupavo dei romanzi e dei racconti di Franz Kafka, verso la metà degli anni ‘80, mi colpì il fatto che tutti i tentativi di interpretare le sue opere parevano non accorgersi che esse non si lasciano mai ricondurre a un solo significato o conclusione, e sembrano sempre parlare di un mondo inconoscibile e di testi impenetrabili. Al contempo la forma del testo s’impone come necessaria. In questo senso, si può considerare l’opera di Kafka come la continuazione del Talmud e del Midrash. Nell’infinita esegesi ebraica della Bibbia, la nostra interazione con un mondo inconoscibile e un dio intangibile viene raddoppiata da testi incoerenti, contraddittori, simbolici e imperscrutabili. Testi che non per questo vengono messi in questione, ma al contrario trattati con cura e amore.
Il mio studio dei testi di Kafka mi lasciò l’impressione che l’autore non avesse voluto esprimere più di quanto essi stessi dicano letteralmente, che è già sufficiente. Tutto è lì, in bianco e nero. Non c’è bisogno che qualcun’altro proponga spiegazioni o interpretazioni. Quando incontrai per la prima volta Walter Swennen nell’ottobre 1988 capii che vale la stessa cosa per i quadri. Se hanno qualcosa da “dire”, quel qualcosa andrà inteso in senso materiale e non nel senso di un codice da decifrare. I dipinti di Swennen articolano la loro forma. Il loro ragionamento si esprime nel modo in cui sono costruiti, anche quando contengono immagini o parole.
Il primato della texture (Viktor Šklovskij)
Il modo con cui Swennen ha considerato il primato della texture si è evoluto molto a partire dai tardi anni ‘80. In quel periodo, egli si era interessato a un’antologia di testi di Viktor Šklovskij, pubblicata in Francia nel 1973 col titolo Le marche du cheval. Secondo Šklovskij, un’opera d’arte non fornisce una traduzione del linguaggio intimo dell’artista in uno che possa essere compreso dallo spettatore. «In arte», scrive l’autore, «nuove forme appaiono per prendere il posto di quelle vecchie, le quali hanno perso il loro valore artistico.» Ma cosa costituisce questo valore artistico? Per spiegarlo egli cita Broder Christiansen, il quale, nel suo libro La filosofia dell’arte, scrisse: «Quando percepiamo qualcosa come una deviazione dall’usuale, dal normale, o da un certo canone guida, sentiamo dentro di noi un’emozione di natura speciale […] Perché la liricità della poesia di un paese straniero non ci si rivela mai pienamente, anche quando ne abbiamo appreso la lingua? Sentiamo il suo gioco sonoro; avvertiamo il susseguirsi delle rime e ne percepiamo il ritmo. Comprendiamo il significato delle singole parole; padroneggiamo l’immaginario, le figure retoriche e il contenuto. Potremmo anche intuire tutte le forme sensibili, tutti gli oggetti. Cosa manca dunque? La risposta è: le percezioni differenziali. La sottile deviazione dall’usuale nella scelta delle espressioni, nella combinazione delle parole, nella fine inversione della sintassi – tutto questo può solamente essere compreso appieno da qualcuno che vive tra gli elementi naturali di quel linguaggio, da qualcuno che, grazie alla sua consapevolezza della norma, sia immediatamente colpito, o meglio, irritato da ogni deviazione da essa.»
Inoltre: «Per trasformare un oggetto in un fatto d’arte, è per prima cosa necessario ritirarlo dal dominio della vita. Dobbiamo isolare una cosa dalla massa di associazioni in cui essa è invischiata. È necessario rigirare l’oggetto come si rigira un ceppo nel fuoco.»
Se questo ragionamento fosse applicato a un dipinto, allora tutti i cosidetti riferimenti (a idee o a oggetti fisici) potrebbero essere considerati come mero materiale da usarsi per comporre un dipinto. Ed è precisamente quello che fece Šklovskij. «I dipinti non sono affatto finestre su un altro mondo – sono oggetti», egli scrisse, e «l’artista si appiglia alla rappresentazione, al mondo, non al fine di ricreare il mondo, ma piuttosto per avere a disposizione del materiale complesso e soddisfacente da utilizzare nella sua arte.» Cézanne faceva eco a queste parole. I suoi dipinti erano tentativi di dare forma, attraverso il colore, agli effetti spaziali e ottici del mondo percepito (“le motif”). Per lui, il dipingere non riguardava l’oggetto percepito, e nemmeno il suo proprio modo di vedere (la sua specifica “optique”, pur fondamentale), riguardava piuttosto la maniera in cui egli trasformava le sue esperienze in colore, il suo proprio modo di fare le cose, che egli descriveva come il suo carattere, o la sua “petite sensibilité”.
«Un quadro non rappresenta niente. A tutta prima, non ha bisogno di rappresentare nient’altro che colori», disse Cézanne a Gasquet. Šklovskij scrisse che «il mondo esterno non esiste. Le cose sostituite dalle parole non esistono e non vengono percepite […]. Il mondo esterno è fuori dall’arte. È percepito come una serie di indizi […] privi di sostanza materiale e texture.» «Per un pittore, il colore è l’unica verità», affermò Cézanne. E aggiunse: «Detesto tutte questi racconti, queste analisi psicologiche, e tutte queste stupidaggini intellettuali su di loro (i colori). È tutto nel dipinto! Per Dio! I pittori non sono degli imbecilli! Eppure devi vederlo tu con i tuoi occhi – con i tuoi occhi – capisci?!»
«Tutto lo sforzo del poeta o del pittore», dice Šklovskij, «è finalizzato innanzitutto a creare qualcosa di unitario e tangibile, un oggetto con una sua texture […] Buono e cattivo in arte sono una questione di texture. […] La texture è la principale caratteristica distintiva di quel mondo specifico di oggetti appositamente costruiti, la totalità del quale siamo soliti chiamare arte.»
[…]


L’esistenza estetica e artistica del dipinto
Attorno alla metà degli anni ‘90, Swennen scoprì un riferimento all’opera L’être et l’essence di Etienne Gilson all’interno del libro di Deleuze su Spinoza. Oltre a questo, scoprì anche il trattato di Gilson Pittura e realtà, basato su un ciclo di conferenze, ed il relativo libro che seguì qualche anno dopo col medesimo titolo. In questo scritto, Gilson distingue tra tre forme di esistenza di un’ opera d’arte: quella puramente fisica, quella estetica e quella artistica. In quanto oggetto fisico, un’opera d’arte non è dissimile da qualsiasi altro oggetto. In quanto oggetto estetico, essa dipende dalla relazione dello spettatore con essa. Un visitatore di una galleria, un corriere, un assicuratore, un pittore o un filosofo hanno ognuno il proprio modo individuale di guardare a un dipinto. In quanto oggetto estetico, un’opera d’arte presenta se stessa allo spettatore come un “modus”, una rappresentazione, che ognuno vede in modo diverso. Poichè queste rappresentazioni sono infinite, Gilson considera il punto di vista estetico un approccio essenzialmente inefficace. La modalità estetica di esistenza di un’opera d’arte è di natura fenomenologica, poichè non ci dice nulla dell’oggetto in sè, ma solo di come esso ci appare (e di come questa apparenza sia determinata dalle nostre capacità e aspettative).
Per definire un’opera d’arte (come qualcosa di distinto da ogni altro oggetto) senza utilizzare criteri estetici, Gilson la descrive come un oggetto creato da un artista nel contesto della sua attività artistica. Questa forma artistica di esistenza è, quindi, determinata ontologicamente, a partire dalle sue cause. Secondo Swennen, la distinzione delineata da Gilson implica che il valore artistico di un’opera d’arte non dipenda dallo sguardo dello spettatore. Essa afferma l’autonomia dell’artista e libera l’opera d’arte dall’aspettativa che essa debba esprimere o significare qualcosa.
Inoltre, la distinzione fatta da Gilson è naturalmente e inestricabilmente legata a una profonda attenzione verso l’esistenza materiale di un’opera d’arte. Il ricorso ad un approccio estetico all’opera d’arte comporta, tra le altre conseguenze, che le persone identificheranno inevitabilmente riproduzioni o immagini con l’oggetto vero e proprio, rendendo l’originale impercettibile agli occhi e riducendo il valore dell’esperienza diretta. Un prominente storico dell’arte, infatti, ha recentemente definito i dipinti di Swennen, in tutta innocenza, come “immagini finali”. Non solo i dipinti sono spesso percepiti come “immagini”, ma si suppone pure che lo scopo del pittore sia quello di produrre immagini. Gilson avvertì dei pericoli della riproduzione già nel 1957. Egli richiamò l’attenzione sulla follia di ridurre dipinti ad immagini, e sulla tendenza ad assorbire tutto il mondo dell’arte nei libri. Egli chiamò questa tendenza la “dittatura della letteratura”. «Una parola stampata è pur sempre una parola » egli scrisse, «ma un dipinto stampato non è un dipinto.» Per di più, «per entrare a far parte di un libro, un dipinto deve disfarsi della propria materialità.»
[…]
Dipingere qualsiasi cosa
Quando compì quarant’anni, Swennen decise di non considerarsi più un poeta bensì un pittore. La differenza, disse a Bart De Baere, sta nel fatto che la poesia si occupa fondamentalmente di nostalgia, ovvero del passato e di ciò che è transitorio. La pittura, continuava, parla del futuro. Credo che si debba prendere quest’affermazione in senso letterale, e cioè che per Swennen un dipinto è un oggetto che va fatto nascere attraverso delle azioni. Non pre-esiste.
Nell’ottobre del 1986 Swennen scrisse una lettera in cui si legge: «[…] riuscire a dipingere una cosa qualsiasi [“n’importe quoi”], ecco l’ideale. Chiunque non abbia fatto l’esperienza di dire una cosa qualsiasi potrà interpretare la mia affermazione come una battuta. Eppure è il mio ideale, la difficoltà estrema. […] La chiave: la premeditazione è sempre un’aggravante.»
[…]
L’idea di dipingere una cosa qualsiasi deriva dallo psicanalista Jacques Lacan, che rimpiazzò la regola di base del metodo freudiano, e cioè che i pazienti condividano con il loro analista “qualunque cosa pensino”, con l’invito a “dire qualunque cosa, senza paura di dire stupidaggini”. Tale esortazione si basava su un punto fondamentale, e cioè che il disagio del paziente è inconoscibile e inimmaginabile. Capiamo che tale disagio è intimamente legato al linguaggio, dato che siamo esseri parlanti, eppure questa è anche la ragione per cui il linguaggio ci delude se viene usato coscientemente come strumento di ricerca finalizzato. L’analista e il paziente spiegano le vele verso un mare di storie intrecciate e senza direzione, tra parole che si spostano e si capovolgono, finché qualcosa succede. Dal momento che l’uso cosciente del linguaggio da parte del paziente risulta insufficiente, si considerano le parole come suoni che possono avere significati alternativi. Esse diventano dei gusci vuoti, che possono condurre a nuove esperienze o intuizioni attraverso associazioni o connessioni inedite.
Swennen prova a fare quadri che restano “inimmaginabili” fino al momento in cui esistono materialmente. Egli impiega materiali, strumenti, tecniche, colori, forme, ingrandimenti di disegni, parole e lettere, sforzandosi il più possibile di tenere tutte queste cose lontane da un “significato”, utilizzandole come forme vuote, come puri significanti. Per esempio, le lettere hanno delle belle forme, del tutto indipendenti dal suono che rappresentano o dal significato che associamo a questo suono. Un triangolo può essere letto come una bandiera, un tetto o un cappello. Un cappello a cilindro può essere letto come una T a testa in giù. […]
Montagne de Miel, 30 Giugno 2016