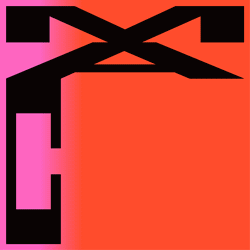Sara Benaglia / Mauro Zanchi: Secondo Mapplethorpe “la fotografia è un modo più sbrigativo per fare una scultura”. Cosa ne pensi?
Alice Pedroletti: Mapplethorpe ha incentrato tutta la sua ricerca sulla realizzazione della forma perfetta. Il suo occhio era estremamente classico, nulla veniva lasciato al caso. Le sue fotografie rappresentano un dialogo tra due media da sempre in una relazione molto stretta. Condivido quindi la sua affermazione legata al suo lavoro, non a caso accostato a quello di scultori come Michelangelo o Rodin. Mapplethorpe usava il soggetto come bozzetto, per trasformarlo in scultura tramite l’immagine. Rodin, inizialmente, usa la fotografia per documentare il risultato finale e successivamente per analizzare e comprendere il suo stesso processo di creazione, arrivando a disegnare sulle fotografie per poi ritoccare le sculture, trasformando l’immagine in una successiva e altra opera da archiviare e catalogare. Io mi sento più vicina al suo senso di movimento ricercato nelle cose inanimate, all’errore nel processo creativo – così presente nella fotografia contemporanea. La reciprocità e l’autonomia tra le parti diventano base per una ricerca di dialogo materico, oltre che di significato. La mia fotografia è quindi un processo lento: la vivo come uno strumento con cui proietto all’esterno un’immagine mentale molto precisa, che costruisco anche in anni. Quando capisco cosa vedo sono poi istintiva e a volte veloce nell’agire, ma mai sbrigativa.
SB/MZ: Architetto (2018) è un lavoro composto da una fotografia in bianco e nero e due sculture, ognuna delle quali è “residuo di qualcosa che esisteva, o idea per qualsiasi cosa in corso”. Che rapporto c’è tra fotografia, architettura e installazione?
AP: C’è un rapporto atemporale, narrativo e circolare. L’immagine in bianco e nero, tratta da una serie di otto fotografie, mostra la scala di una soglia a cui manca la porta. In realtà manca proprio la casa, che non è chiaro se fosse presente prima. Si vedono alcuni materiali da costruzione, ma la narrazione è parziale. È un lavoro realizzato scattando sulla strada verso il Delta del Mississippi, a sud di New Orleans, a distanza di cinque anni dall’uragano Katrina. Mi interessava capire cosa fosse rimasto delle comunità che vi abitavano. Il risultato sono dei ritratti alle loro case in cui la scala, così come le altre rovine, sono un residuo che si trasforma prima in monumento, poi in paesaggio, infine in simbolo. La scultura di detriti appartiene, invece, alla ristrutturazione della mia casa-studio. Racconta una fine e un inizio, ma parla anche di un rapporto ambiguo e conflittuale con lo spazio, che non ha un reale confine vita-lavoro. La scultura appesa rappresenta la relazione tra la metratura (misurazione) della parete ormai distrutta del mio studio e quella intatta di moltissime altre case su cui la tapezzeria potrebbe essere applicata. La carta da parati è la parte dell’opera con una funzione specifica, quella dell’interazione tra il collezionista, lo spazio e l’artista. Questa possibilità installativa determina un cambio di significato nel lavoro. Una volta srotolato e applicato si configura in modo personale, interferendo con la mia proposta, innescando uno scambio di ruoli. Da lì il titolo. “Architetto”: sostantivo e verbo, mestiere e azione, inganno. Cosa è o diventa opera? L’applicazione? Il porta rotolo che resta come scheletro? L’insieme?
SB/MZ: Come immagini un libro nella complessità che hai analizzato nell’opera Consistency (2017-2019)? Che relazione si instaura tra fotografia e “linguaggio delle parole” in questo lavoro?
AP: Parto da una citazione tratta da The New Art of Making Books (1975) di Ulises Carrión di cui mi interessa proprio l’analisi sottrattiva di cosa è un libro. In Consistency ho smontato le Lezioni Americane, rendendole una mappa concettuale a parete, approcciando i testi con la metodologia con cui Italo Calvino archiviava gli argomenti di cui scrivere: per parole. Significati sintetici di immagini più ampie, mentali e reali. Le parole sono composte da lettere e la relazione che ho creato è tra la forma della singola lettera e gli oggetti con cui interagiamo nel quotidiano: sculture narrative tridimensionali. Mi sono quindi costruita un alfabeto e l’ho identificato come instabile, perché l’opera si modifica fisicamente e cambiando gli oggetti ne cambia anche la narrazione. Ho sviluppato la ricerca mentre ero in residenza nei Paesei Bassi, a Enschede, una città non molto grande verso il confine con la Germania, dove il riciclo è un fattore culturale effettivo. Ciò che ho usato sono oggetti scartati che la comunità mette a disposizione in un’operazione circolare di riutilizzo. Ho immaginato che fossero come le lettere che ritornano in un testo: sono sempre le stesse che combinate diversamente creano altre parole e nuovi significati. Durante l’opening le persone si sono riconosciute negli oggetti ormai dimenticati e l’opera è diventata quindi una narrazione collettiva. La relazione tra fotografia e linguaggio è anche ingannevole: alcune immagini sembrano dei disegni, dei trompe l’oeil o delle nature morte. Tutto il lavoro è stato in realtà scattato con un iPhone, perché mi sono focalizzata sull’immediatezza dell’appunto, come la scrittura su taccuino. Più che un’opera quindi, è una ricerca aperta in cui i lavori sono esercizi che metto in atto per studiare la mia stessa pratica.



SB/MZ: C’è una connessione diretta fra misurazione e fotografia in Metro (2001-2019). Come si articola questa relazione?
AP: Uso il metro come unità di misura fisica ed emotiva. La metafora è tra l’individuo e il singolo metro, la comunità e i chilometri con cui misuriamo i territori che abitiamo o percorriamo. Metro è quindi anche la misurazione informale della mia performance in cui cammino per ore scattando fotografie, senza una direzione prestabilita. Azione di cui le immagini sono l’unica testimonianza. Metro è un lavoro narrativo, strutturato come un libro, in cui ogni capitolo ha una tematica e una lunghezza sequenziale diversa. L’insieme delle immagini restituisce un archivio temporale della permanenza nell’ambiente stabilendo la lunghezza dell’opera. Racconta le tracce dell’agire e dell’abitare che l’essere umano lascia dietro di sé: a volte incidente, a volte azione di un’antropizzazione violenta. Scarti in cui ricerco le ragioni della separazione dalla nostra più profonda origine: quella animale, istintuale, naturale.
SB/MZ: In Metro arrotoli fotografie (o immagini) fino a formare delle strutture verticali, che paiono creare una connessione tra la terra e lo Zenit. Che cosa rappresenta per te questo rapporto tra qualcosa che pare totemico e qualcos’altro che è prelevato dalla realtà, dal paesaggio, attraverso uno scatto fotografico?
AP: Ho voluto dare fisicità all’immagine attraverso una scultura-fotografia, ma non ho pensato queste strutture verticali come ad oggetti totemici. Piuttosto ho fatto riferimento alla misurazione, al linguaggio e all’idea di opera-archivio. Ricercavo qualcosa di fisico che mi riportasse al concetto di matrice: le strisce ricordano le pellicole srotolate, i negativi, che per me sono le matrici delle immagini, come i calchi o il materiale grezzo in scultura. Quando ho esposto i metri in modo lineare, seguendo l’orizzonte dello sguardo e il perimetro dello spazio, ricercavo una fruizione attiva dell’opera. Il limite del muro come struttura portante, però, rischiava di riportare l’installazione a una bidimensionalità che non mi interessa. Da qualche anno sviluppo i Metri nello spazio in verticale, per rendere l’esperienza di chi guarda ancora più fisica. Arrotolandosi, le immagini si frammentano, si fondono, si astraggono, e l’osservazione richiede maggiore attenzione. La verticalità è anche un modo per guardare ciò che scatto in una prospettiva diversa.
SB/MZ: Che cosa è la visione, anche in relazione a Din Din (2019)? Che cosa si innesca in questo lavoro?
AP: Il Deutsche Institut für Normung (DIN), fondato nel 1917, è l’Istituto tedesco per la standardizzazione. Nella ricerca che sto portando avanti mi interessano il formato A4 e la norma DIN 4172, che costituisce la base per le dimensioni dei mattoni, standard riferito all’unità internazionale di lunghezza 1 m. Gran parte di quello che facciamo oggi è vincolato da tale standard. Nel mio lavoro, in particolare, per me standard è ogni strumento che ci pilota nella decifrazione di quello che percepiamo, non solo come aspetto pratico o codice condiviso. In DIN DIN parto quindi da una misura considerandola invece idea per qualcosa che non è dimostrabile. Ragiono su cosa sia standard nell’inconscio visivo dell’artista e del pubblico a cui si rivolge. Il lavoro coinvolge l’immaginario dell’Arte povera con una serie di fotografie in bianco e nero di formato A4 che estarpolate dal loro contesto sembrano essere esattamente quello che in realtà non sono: opere o documenti di azioni performative. L’associazione visiva in riferimento a quel periodo storico è talmente forte che si sollevano dei legittimi dubbi sulla veridicità di quello che vediamo, o che abbiamo visto e ricordiamo. Le immagini appartengono in realtà a un manuale per costruire un giardino ideale e nulla hanno a che vedere con l’Arte Povera. È un inganno che mette in luce la fragilità di un archivio, ma anche la sua potenzialità come strumento di lavoro, narrativo e di apprendimento. In questo senso la mia pratica è legata all’archiviazione: per ogni progetto raccolgo immagini, materiali di ricerca e oggetti che confluiscono in un luogo specifico. Genero contenitori informali e liberi, che variano nelle dimensioni perché potenzialmente sempre aperti. Non sono vincolati a norme scientifiche o di gestione esterna; funzionano come capsule temporali. Nel caso di archivi esistenti a volte c’è una rielaborazione formale, come in questo caso, altre volte fisica e che innesca il legame con la scultura che è al centro di molti miei lavori, come è stato per il mio stesso archivio in pellicola che ha dato origine a Frigido. Vita di un archivio (2013-2019). Le sculture in DIN DIN, come in molti altri miei lavori, sono quindi il legame con la materia e con il presente: appartengono al mio gesto quotidiano perché soggette a diversi interventi, anche a distanza di anni.
SB/MZ: Qual è il potenziale o il limite politico della fotografia?
AP: Vi voglio citare Paolo Pellegrin, che in un’intervista a Repubblica di qualche anno fa disse che il suo interesse è diretto verso “una fotografia aperta, in cui io sono in mezzo a quel che vedo, mi faccio domande, e ogni risposta sposta l’orizzonte su altre domande”. Il potenziale della fotografia di reportage sta nel dare un volto a momenti che difficilmente riusciremmo a immaginare. Le immagini possono quindi aiutarci a ricostruire, sia nell’immediato che in là nel tempo, una frammentazione storica, come quella di un archivio, che è al contempo fragile perchè potenzialmente manipolabile. Nella libertà dell’interpretazione esiste però una volontà: quella di chi fotografa, dell’artista. È lei/lui che sceglie il significato e significante della narrazione attraverso un preciso scatto, determinando, o suggerendo, cosa vedere per poter poi guardare. Questo gesto può essere politico oppure no, come quello di un archivista che potrebbe trovarsi a scegliere cosa conservare o cosa buttare. La dichiarazione di Pellegrin per me vale per ogni immagine, indipendentemente dal contesto in cui viene realizzata; fare arte è in sé gesto politico, se sei artista. Quello che cambia è il livello di coinvolgimento, le specifiche tematiche, l’etica del tuo agire.



SB/MZ: Che cosa è Atrii? Come cambiano la tua visione e il tuo lavoro nel coinvolgimento di altri artisti?
AP: Atrii è un’utopia possibile, una forma di resistenza attiva a modelli di fruizione dell’arte. È attiva perché non ci poniamo in competizione o sostituzione, piuttosto in collaborazione e dialogo. Siamo un collettivo, un’associazione culturale e un marchio a tutela dei progetti degli artisti; ci occupiamo di indagare il concetto e significato di atrio, inteso come luogo relazionale ed espositivo, libero dai vincoli tipici dei musei o delle gallerie. Il progetto deriva dalla mia pratica e si apre agli altri come momento di relazione, dialogo e sperimentazione. Il cuore di tutto è il nostro Archivio Aperto, che dal 2016 è ospitato presso la Cittadella degli Archivi di Milano. Vi inseriamo le idee e i progetti che gli artisti vogliono condividere e mettere a disposizione, affinché siano consultati e attivati: siamo un Archivio per il futuro, il primo ad essere inserito in una struttura municipale. Il mio lavoro, che qui comprende aspetti più curatoriali, non cambia realmente, ma si integra e contamina con quello degli artisti invitati e viceversa. Quello che faccio con Atrii è, inoltre, sostenere la sperimentazione attraverso un processo di autoformazione collaborativa.
SB/MZ: Ci interessa la tua indagine in Metrica (2017). In particolare, vorremmo che ci introducessi al tuo rapporto con il tempo e il suo trascorrere, attraverso cose presenti in assenza: iridescenze, lievi bagliori, ombre, presenze insostanziali.
AP: 5500K (metrica 1-19) è al contempo una raccolta e un archivio personale di immagini di grattacieli, in un momento di transizione da uno stato fisico e strutturale a uno immaginifico. Approccio l’architettura come fosse scultura: cambia la scala di grandezza, ma la relazione con l’idea di oggetto (o l’oggetto stesso) resta invariata. I riflessi sono cose immateriali, che si manifestano in quel modo solo per pochissimi istanti al giorno, innescando una comunicazione tra diversi (f)attori in un dialogo molto preciso e veloce; io mi inserisco in questo dialogo inseguendone i frammenti. Il tempo è quindi quello dell’attesa, della ricerca che avviene camminando più o meno calsualmente, ma anche quello del rischio: mi piace spingere la pratica verso una costante tensione, come quella dello sbagliare orario o luogo. Anche in questo caso la dimensione verticale installativa mi limita, ma riporta gli oggetti dall’asfalto su cui si riflettono, nella loro posizione originale: quella verticale dell’edificio, senza mai svelarlo realmente.
SB/MZ: In cosa consiste Study for a Sculpture (2016) e che rapporto instaura con il medium fotografico?
AP: Il lavoro nasce a Shanghai come storyboard di un video. Racconta come la città si manifesti in modo organico, lasciando cadere nel fiume le luci che ogni sera la dipingono attraverso un breve spettacolo. Questa fluidità di colori nel nero dell’acqua ha determinato la scelta dei materiali per i prototipi: la carta. Le sculture si ispirano alle architetture di Pudong, il distretto finanziario della città, e una delle principali attrazioni turistiche: un insieme di strutture rigide e inanimate, dalle forme surreali, governate da un fiume che di giorno ne fagocita i riflessi. Da una parte ci sono quindi i mockup – le sculture -, e dall’altra ci sono le immagini-documento di un processo ancora in atto, perché il video è in attesa di essere realizzato. Come in molti miei lavori, e in questo in particolar modo, l’opera esiste nella sua assenza, nello spazio tra gli elementi che la compongono. Immagine e scultura sono matrice l’una dell’altra e lavorano in contemporanea sostenendosi a vicenda. Sono oggetti da interpretare liberamente: sembrano piante, animali, cellule microscopiche, ma anche mobili o dettagli di tessuti. Mi sono servita della fotografia e del disegno per archiviarne le forme, i materiali e tutte le funzioni possibili, perché immaginabili.