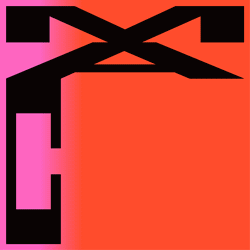Il dodicesimo focus sulla nuova scena fotografica è dedicato ad Alessandro Sambini (Rovigo, 1982, vive e lavora a Milano).
Mauro Zanchi, Sara Benaglia: In Grand Tour (2017-2018), come in altri tuoi progetti, coinvolgi all’interno del tuo lavoro persone che hanno una relazione quotidiana con l’arte. In questo caso la pittura è analizzata in quanto forma documentale, un compito che ci aspetteremmo, piuttosto, dalla fotografia. Lo scarto è rappresentato in Pieve di Cadore dall’inserimento di una struttura antibalistica da te ricreata in 3D, in un parallelo temporale tra tale struttura e le rovine inserite in quadri di Canaletto e Bellotto. Che cosa accade quando un medesimo paesaggio viene dipinto da più occhi?
Alessandro Sambini: Quando lo stesso paesaggio viene rappresentato da più occhi la cosa più evidente è la differenza di approccio alla tecnica figurativa, ma ciò che mi interessava è che ogni punto di vista contribuiva a convalidare una lettura di un luogo, come una forma di mutua controprova. Di che luogo parlo? Il tentativo del progetto Grand Tour è quello di rappresentare un paesaggio/luogo ibrido: l’arte contemporanea in forma di capriccio. Sia nel caso di Pieve di Cadore che nel caso di Palermo, infatti, al centro dell’“inquadratura” c’è sempre un luogo legato al mondo dell’arte: in entrambi i casi una grande inaugurazione. La mia “rovina” esogena, a differenza delle colonne romane di Canaletto, che le prelevava da luoghi di questo mondo (o a Friedrich che riassumeva catene montuose realmente esistenti, solamente un po’ più distanti tra loro, in Wanderer Above The Sea Of Fog), è rappresentata nel primo caso (Pieve) dalla struttura anti-balistica e nel secondo caso (Palermo) dal furgone. È un tentativo di fondere due paesaggi tra loro molto distanti: il territorio in cui viviamo, fatto di terra e aria, e quello mediato, fatto di pixel, con cui ci confrontiamo ogni giorno. Il furgone, infatti, non è un furgone casuale: è lo stesso Hertz usato durante un attacco terroristico a Londra qualche anno fa e che si schiantò a lato della strada. Ho deciso, partendo dalle immagini che ho trovato su Google, di posizionarlo nello stesso modo, davanti alla sede temporanea di Viasaterna a Palermo, cercando di creare quell’idea di “capriccio contemporaneo”, di cui parlavo sopra. Per quanto riguarda la struttura anti-balistica (stampata in 3D con l’utilizzo della sabbia), che è stata il motore di tutto il progetto, volevo ragionare sul potere della documentazione visiva di un luogo, partendo da una riflessione sui Gargoyles di Notre Dame che, a differenza di quanto pensavo, non sono altro che una delle ultime appendici architettoniche aggiunte alla cattedrale alla fine dell’800.
MZ / SB: In White Hat – Black Hat (2018) hai chiesto a 23 studenti di esprimere le loro sensazioni in merito alla relazione tra umani e robot, tra uomo e macchina. In questa interrogazione “sulla natura di queste macchine”, perché utilizzi in modo indifferenziato i termini “robot” (lavoratori forzati dall’aspetto più o meno antropomorfizzato) e “macchina”?
AS: Attraverso l’esperienza di White Hat – Black Hat cerco di responsabilizzare una categoria specifica di specialisti dell’arte (gli studenti di un’accademia d’arte italiana) sull’importanza di una lettura attenta di quanto a livello globale si stia sviluppando, seppur silenziosamente, attorno a noi. “Le macchine”, “gli algoritmi”, “i robot”, rappresentano dei landmark nel chiacchiericcio globale odierno, ma spesso sono concetti-ombrello, vuoti o poco conosciuti. Sia per una reale impossibilità di contatto con questi mondi (dov’è il robot più vicino a te in questo momento?), sia per una generale difficoltà tecnica legata alla natura stessa di questi soggetti. Ma se da una parte abbiamo programmatori che si occupano di scrivere righe di codice incuranti (giustamente?) delle ricadute socio-culturali, dall’altra c’è un mondo dell’arte che credo possa intervenire instradando una serie di riflessioni sul tema che trovo generative. L’errore robot-macchina, triviale, rientra a mio parere ancora nell’attuale rarefazione dei confini tra i vari termini.


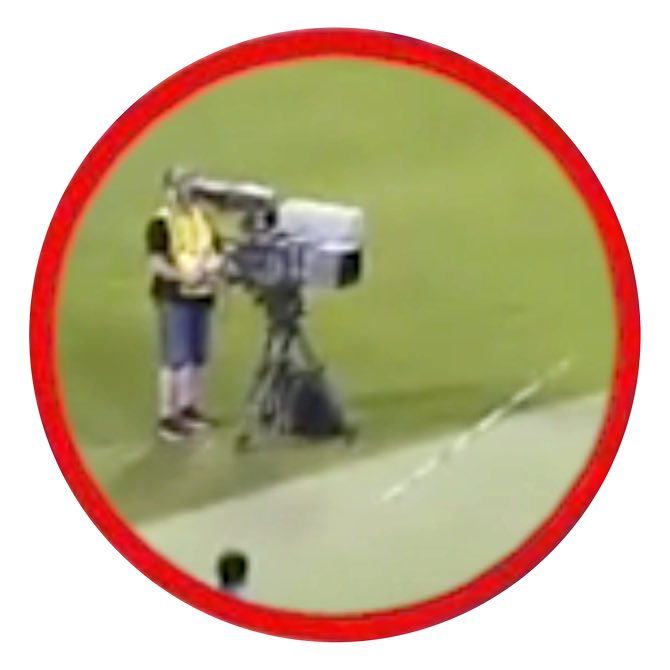
MZ / SB: In Spelling book (2018) fai riferimento a Caltech 256 Image Dataset, una banca dati – costituita da 30.607 immagini suddivise in 257 categorie di oggetti – utilizzata per insegnare ai modelli a riconoscere le immagini. La suddivisione in categorie è la base processuale su cui il lavoro di apprendimento si fonda. Che ruolo ha la categorizzazione nell’apprendimento umano e quali ricadute ha questo sull’immagine?
AS: Ho provato a lavorare su questo tema, mettendomi alla stregua delle macchine e cercando di suddividere quanto vedevo in categorie, esattamente come fa un qualsiasi algoritmo di riconoscimento visivo. Posso solo dire che trovo sia un’esperienza lisergica. Mi sentivo ottuso nel farlo, stolto, chiuso e poco aperto a quello che l’umano invece riesce a fare, cioè ad avere elasticità e non confinare le sue decisioni alle categorie che ha di fronte. Cosa che al momento, per esempio, viene molto facile a un qualsiasi computer o alle intelligenze artificiali: non esistendo realmente il concetto di categoria (sovra-lettura umana a quello che stiamo propinando alla macchina) non esiste nemmeno il concetto di buono, cattivo, non esiste nessuna valorizzazione anche completamente soggettiva e “scorretta”. La categorizzazione umana è, invece, fondamentale per chi, come me, ha bisogno di dare un ordine al visibile: serve a sapere sempre dove si è, a quale infrastruttura sociale si appartiene, al territorio, in senso lato, a cui appartiene ciò che osserviamo e ciò che decidiamo di testimoniare attraverso, per esempio, una fotografia che possiamo scattare. Avendo sempre chiaro il luogo di destinazione e il modo in cui verrà mostrata. Ecco credo che nell’uomo questo sistema di categorizzazione permetta di calibrare bene un intervento espressivo, dal rutto al bar al quadro al Moma e viceversa.
MZ / SB: Evento e immagine si confrontano in Enfasi (2018). La fotografia ha da sempre avuto il ruolo di certificare un accadimento. Che tipo di messa in posa eseguono i cerchi rossi da te selezionati? E quale è stato il confine della tua area di indagine?
AS: L’unica cosa che certificano i cerchi rossi è una serie di eventi concentrici. Un photo editor, all’interno di una foto (o nuvola di pixel) precedentemente scelta da un funzionario della polizia postale, ha deciso – per incrementare l’effetto “esca” di una notizia – di selezionare quello che per lui era il punctum. È l’effetto di un’attenta triangolazione tecnico-concettuale, che lo ha portato a circondare una porzione di pseudo-informazione che io ho semplicemente croppato e isolato dal resto, incuriosito dall’effetto che queste nuove immagini (di cui, per altro, non ero autore) potevano dare nel tempo. Una delle prime domande, per esempio, che mi sono venute in testa da spettatore: cosa c’era oltre il frame rotondo? Cosa ha deciso di non mostrare il fotografo? Chi è il fotografo? Tra me che espongo dei cerchi rossi 60 x 60 sotto plexiglass, il photo editor triangolatore, il funzionario di polizia che per primo ha selezionato un frame da una videocamera di sorveglianza: di che ecosistema fotografico stiamo parlando e in che modo si contrappone a quello classico?
MZ / SB: Nella mostra “People At An Exhibition” (2016) l’uso di un robot programmato per filmare le persone che entravano in questo “passaggio obbligato” verso il resto della mostra, per eseguire un riconoscimento facciale, per smettere di registrare e per caricare il video su Youtube apre a un problema di privacy. Il robot era programmato anche per interagire con gli utenti? E, se no, chi aveva la delega di eseguire questo compito? Che impatto ha avuto sul progetto in generale?
AS: I materiali (testi, foto e video) che abbiamo pubblicato online fin dagli inizi sono diventati materiale per i dataset che stanno nutrendo le “intelligenze artificiali” di tutto il mondo, questo senza che nessuno lo sapesse o ne venisse informato (Kate Crawford e Trevor Paglen, per il blog Unthinking Photography). Anche senza questa informazione, relativamente recente, rimane il fatto che i selfie e le immagini di noi stessi quando le pubblichiamo non siano proprio consegnati ad addetti di Fort Knox. La mostra stessa partiva da questa constatazione: non siamo per niente gelosi delle nostre immagini. È sufficiente questa generalizzazione? A livello legale no, ma a livello concettuale per me lo era. Ciononostante ho deciso, per rimuovere qualsiasi dubbio, di posizionare un televisore prima della sala del robot. Il televisore riportava un video tutorial che spiegava come all’interno della stanza successiva la propria immagine personale sarebbe diventata di dominio pubblico e che, se questo non fosse stato gradito, si doveva indossare una maschera rossa, a disposizione prima di entrare. Il robot era programmato per interagire con gli utenti nella misura in cui li guardava dritto negli occhi. Durante il periodo passato all’interno della stanza e dando per assodato che fossero consenzienti (ogni valutazione robotica, ricordiamolo, sono righe di codice scritte da persone vere) decideva di mandarlo immediatamente online sul canalePeople At an Exhibition ospitato da Youtube. L’impatto sul progetto è che a livello visivo, sul canale, si possono rilevare due specie: i “facciati” e i “mascherati”. I “facciati” sono molto espressivi, mentre i “mascherati” sembrano essere spesso attoniti.

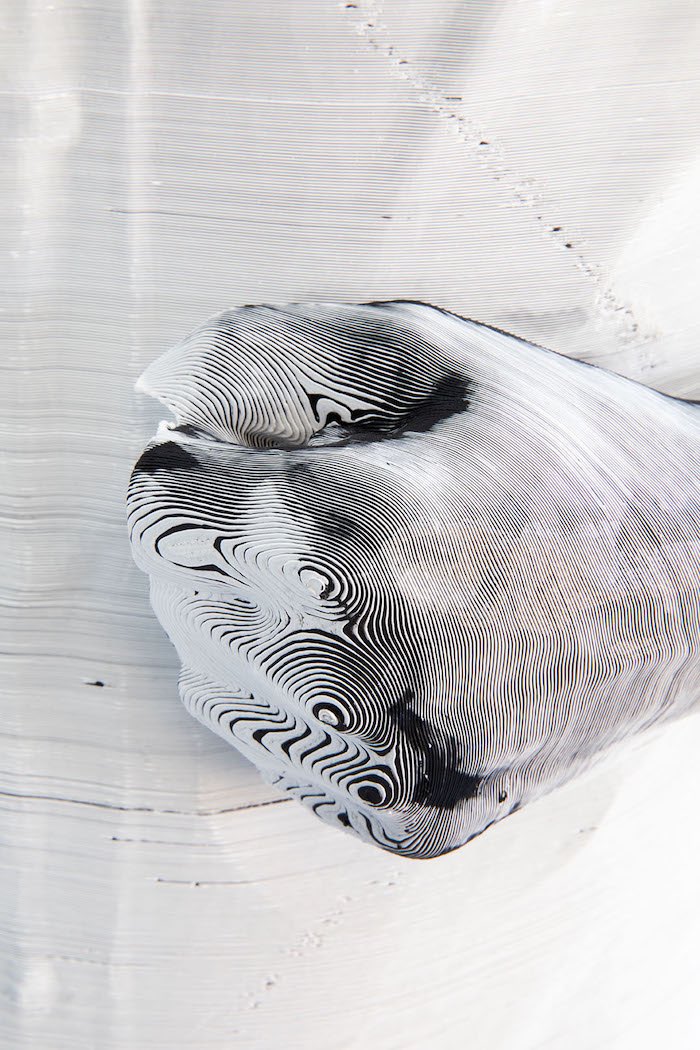
MZ / SB: Come possiamo andare oltre la mera visione retinica stigmatizzata da Duchamp? Quali sviluppi e modalità nuove immagini per una evoluzione del medium fotografico?
AS: Credo che nella fotografia l’abbiamo abbondantemente superata. A mio parere lo dimostra, per esempio, la serie di meme sulla suddivisione dei biscotti Oreo (Oreo separation memes, 2013-2019), che hanno scarnificato qualsiasi struttura semantica. Sono opere completamente disastrose a livello visivo (epic fails), che diventano alfabeti e codice morse. Sono immagini operative, che allontanano completamente lo spettatore dal godimento estetico e lo lasciano a quello scatenato dall’attivazione della materia grigia. Credo sia un passaggio importante, alla stregua di un altro meme: Enslaved Moisture (2019). Sembrano dei rebus, ma sono opere completamente concettuali, a differenza di quelli che si trovano sulla Settimana Enigmistica, fatti di lettere e disegni, nei quali bisogna dare un nome a una cosa o a un’azione e interporre con arguzia delle lettere, che appaiono in primo piano e fuori scala. Un’operazione quasi puramente alfabetica. Nel secondo caso si tratta di un’operazione che avviene all’ interno dell’insieme risultante dall’intersezione tra consumismo, resilienza e il carattere distruttivo dell’uomo descritto da Benjamin; quest’ultimo è una forza intrinseca all’uomo, che lo porta a individuare nuove strade (e nuove narrazioni), partendo da ciò che ha davanti, attraverso un’operazione di taglio. Nuove riconfigurazioni del mondo, come dice Rancière (2009), partendo dal mondo che ci viene offerto o il fotografo come editor (Zylinska, 2017). Di sicuro, un fotografo che ha abbondantemente archiviato e consolidato la capacità tecnica di produrre una nuova immagine da zero, che ha rinunciato a una relazione stretta con il reale e che in qualità di consumatore sa riutilizzare quelle già prodotte per offrire visioni alternative e grimaldelli visivi in grado di suggerire una sovversione degli attuali immaginari (crypto)apocalittici. Al netto di questo, io immagino una suddivisone della fotografia (esclusa quella prodotta dalle macchine) in due principali aree di azione: resistenza politica e macro di gladioli.
MZ / SB: Quale via sinestetica potrebbe espandere il medium fotografico?
AS: Credo che da questo punto di vista sia già stato esplorato molto. Partendo da Avatar e visione 3D, passando per la realtà aumentata, la realtà virtuale di Carne Y Arena di Iñáritu e arrivando a nuovi devices, che permettono di sentire i colpi subiti durante le partite ai videogiochi. Con una traiettoria del tutto trasversale e generativa trovo interessante l’Image Fulgurator di Julius Von Bismark (2008), che riusciva a inserire elementi esogeni nelle fotografie di altre persone. In realtà, più che l’esperienza sinestetica relativa alle immagini che ci troviamo davanti (pensando anche all’installazione Blue Line di John Baldessari esposta a Fondazione Prada qualche anno fa), mi interessa pensare a un’espansione dal punto di vista delle sensazioni che può provare la persona fotografata. Mi interesserebbe sviluppare un sistema che permetta alla persona fotografata di sapere e “sentire” di essere stata “scattata”. Che tipo di esperienza sinestetica sarebbe averne coscienza?




New Photography è una nuova rubrica di approfondimenti dedicata alla fotografia contemporanea: una serie di interviste di Mauro Zanchi e Sara Benaglia realizzate nel contesto di ricerca riferito allaMetafotografia e alla New Photography, iniziata nel 2018 – approfondita con una mostra presso BACO_BaseArteContemporaneaOdierna (Baco Arte Contemporanea) e una pubblicazione edita da Skinnerboox nell’ottobre 2019 – e tuttora in divenire con ulteriori approfondimenti nelle pagine online di questo sito.
New Photography è un progetto che in una prima fase coinvolge l’avanguardia fotografica contemporanea italiana e in seguito la Nuova Fotografia internazionale. Si pone il quesito di quale sia la natura dell’immagine alla luce di un cambio di paradigma visuale combinato con i cambiamenti sociali e tecnologici che lo hanno accompagnato. Gli algoritmi di correzione dell’immagine, il deep web, l’apertura al non visuale, la codificazione con stringhe di numeri, l’archivio, le corruzioni e gli sviluppi dell’inconscio tecnologico, l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza e dello scanner invece di un obiettivo sono solo alcuni dei metodi e delle modalità di ricerca adottati dagli artisti coinvolti.