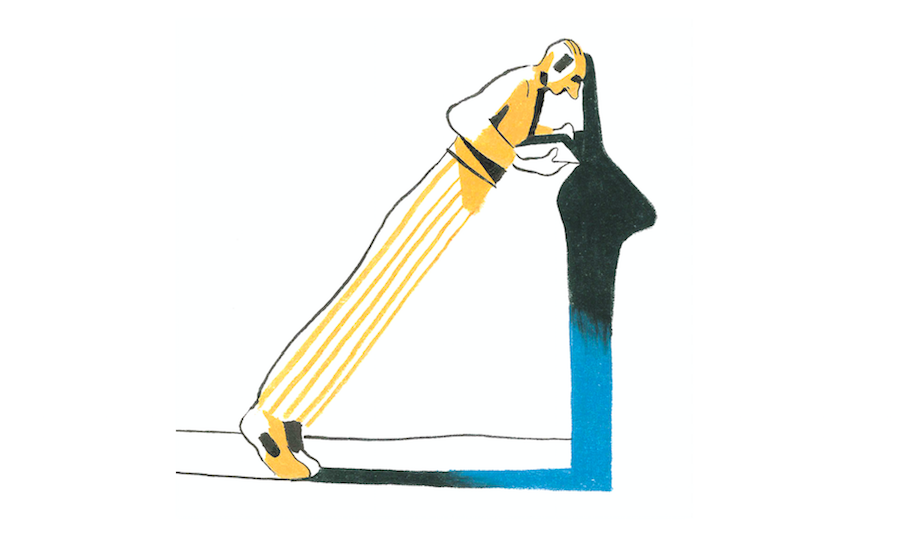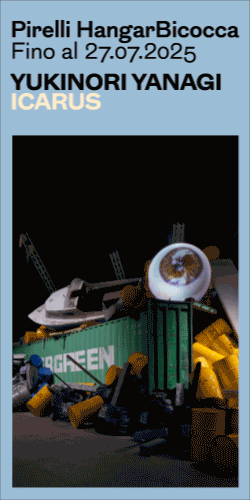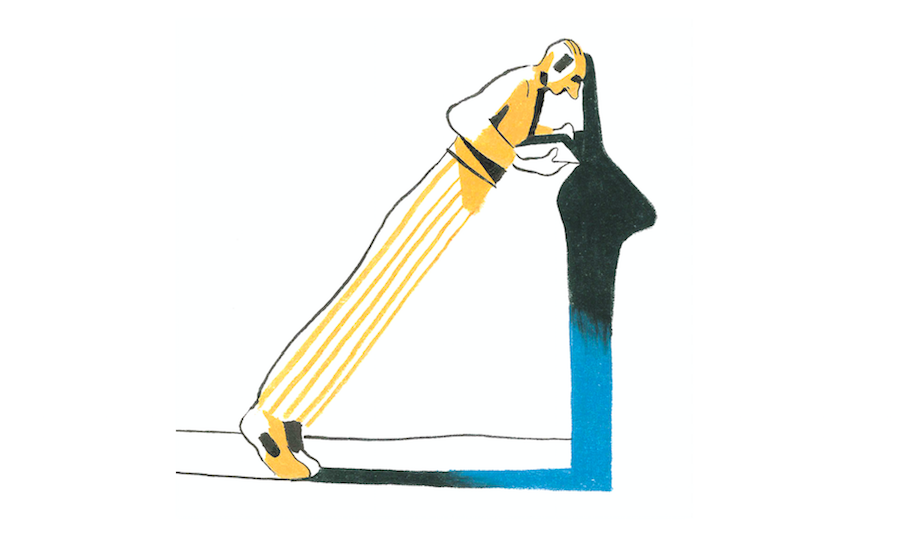
E’ da pochi mesi in libreria un libro che consiglierei a coloro che si occupano di arte contemporanea, a tutti i livelli e con diverse mansioni. “Uccidi l’unicorno” è il titolo con cui Gabriele Sassone condensa la sua esperienza di insegnante e scrittore – aggiungerei anche papà, è lo capirete leggendo il libro – dedito allo studio della storia dell’arte, ma anche alla ricerca delle tante sue possibili narrazioni.
Il libro racconta di un insegnante d’arte che, a tarda sera, riceve una telefonata dove gli viene comunicato che l’ospite d’onore del convegno che ha organizzato il suo istituto ha perso il volo, e spetterà a lui sostituirlo la mattina dopo. In una nottata, dunque, dovrò preparare un intervento ‘sostitutivo’ e fare da tappabuchi. Tutti i suoi ragionamenti partono dalla domanda: come spiegare di fronte a tanti studiosi che cosa differenzia l’artista da una persona comune nell’epoca dei social media?
La sua riflessione si dipana lungo un viaggio diacronico nella storia dell’arte, passata e contemporanea, ma anche sulla sua giovinezza, sulle esperienze e ricordi della sua vita e racconti sul suo essere genitore. Accanto alle vicende di Van Gogh, Pollock, Duchamp, Beuys, ma anche poeti come Luigi Di Ruscio e scrittori come Federigo Tozzi – autori che il protagonista seleziona per fare la lista di slides da proiettare alla conferenza – si affiancano le esperienze di amici artisti che si arrabattano nel complicato e misterioso circuito dell’arte contemporanea.
Svelando quelli che si possono definire i “lati oscuri del sistema del sistema dell’arte e del lavoro culturale”, Sassone esordisce nell’altrettanto complesso mondo delle letteratura. Un’esordio sicuramente promettente.
Seguono alcune domande a Gabriele Sassone —
Elena Bordignon: Una domanda prima di inoltraci nel tuo libro da poco uscito per il Saggiatore: chi è o cos’è l’unicorno che inviti a uccidere? E perché lo vorresti uccidere, se non sveliamo troppo? (lo riveli in modo bizzarro a pagina 71, tra un rituale rock e una corsa in macchina. Notevole.)
Gabriele Sassone: L’unicorno è una presenza simbolica. Appare al protagonista in piena notte, mentre si trova a scrivere l’intervento per un convegno in programma la mattina seguente. Un ospite importante ha perso il volo e lui dovrà rimpiazzarlo. Così, in uno stato di allucinazione causato dalla mancanza di sonno, avviene lo scontro con questa creatura leggendaria. Che significa molte cose: giovinezza, immaginazione, cura di sé, leggerezza, gioco, ozio e tanti altri valori che, pur di entrare nel mondo del lavoro e dell’età adulta, il protagonista ha sacrificato. Questo significa uccidere l’unicorno: compiere un atto crudele verso se stessi.
EB: Tutto parte dalla tua esperienza personale: sensazioni, emozioni, anche intimità. Tutte dimensioni che ti aiutano a raccontare una vicenda esemplare: preparare una disquisizione per un convegno che si terrà il giorno seguente sul tema: “L’arte ai tempi dei social media”. Una sorta di pretesto per uno scavo interiore, ritmato da episodi significativi della vita di noti artisti, ma anche da cadute di tazze, di caffettiere, di inciampi nel filo dell’alimentatore. Qual è la scoperta più significativa che hai fatto in questa esperienza letteraria?
GS: Scrivere è stata l’occasione per fare il punto della situazione. Per capire che cosa significhi occuparsi di cultura – e in particolare di arte contemporanea – oggi, a fronte di una precarietà continua e ingiustificata, di una contrazione irreversibile del tempo, di una burocrazia che non lascia scampo, della solitudine provocata dall’inseguire i propri progetti; e poi scrivere è stata l’occasione per capire che cosa significhi diventare genitore, registrare e condividere con gli altri non solo gli aspetti della vita professionale ma anche di quella privata. Misurarsi sempre e comunque con gli indici di gradimento.
Ma, soprattutto, scrivere questo romanzo è stata l’occasione per studiare moltissimo, in particolare le vicende di alcuni grandi artisti che, in fin dei conti, soffrivano le nostre stesse pene. Tu avresti mai detto che il sogno più grande di van Gogh sarebbe stato ricevere una paga fissa, da operaio?
EB: La Paura è il sentimento che racconti fin da subito per chiarire che parlare in pubblico, proprio non è nelle tue corde. Ma è un sentimento che trama anche molte altre vicende che racconti (“La mia paura è anche la paura di un duro come Pollock”).
Descrivi con un’immagine questa dimensione di disagio, avere “le ombre allacciate alla gola”. Mi spieghi cosa significa questa espressione e perchè la utilizzi?
GS: Come avrai capito mi piacciono le metafore. “Avere le ombre allacciate alla gola” significa respirare a fatica. Io sono asmatico, quindi è una sensazione che conosco bene, ma l’affanno di cui parlo va oltre una crisi respiratoria. È l’affanno prodotto da questo tipo di vita consacrata al lavoro. Qualcosa di simile a una disintegrazione che nasce dall’interno, dall’ansia, anzi dalla paura di non farcela. Il sistema della cultura in Italia è così competitivo perché si gioca su una concorrenza al ribasso, su un’offerta enorme di competenze che il sistema non riesce ad assorbire. A un certo punto descrivo il Cane interrato nella rena, dipinto da Goya nel 1820: un animale che lotta per tenere la testa fuori dalle sabbie mobili, mentre sprofonda nell’indifferenza generale. I suoi occhi fanno impressione. Ecco, avrebbero potuto essere i tuoi di qualche anno fa, ho pensato, appena ti sei laureato.
EB: La materia di cui ti occupi nella vita è la storia dell’arte, come si racconta o viene raccontata. Al di là dell’arte contemporanea, racconti della tua ossessione su come vivono, campano e creano gli artisti. Mi sveli la fonte di questa ossessione? Cosa ti attrae delle vita degli artisti?
GS: Degli artisti mi ossessiona l’imprevedibilità. Per me, laureato in storia dell’arte, è stato davvero buffo scoprire che quel poco che sapevo sul modo di vivere di un artista lo avevo imparato dai manuali, sotto forma di semplificazione. E questa immagine approssimativa dell’artista me la sono impressa nella mente, talvolta mistificandola, finché ho iniziato a frequentare artisti viventi. Allora tutto è cambiato. Ho capito che fare l’artista è un mestiere e non solo una vocazione.
“Creativo” è un termine che rende fantasmagorico un lavoro composto, per lo più, da attività compilative, comunicative e manageriali. Questo non significa sminuire la figura dell’artista, piuttosto ridefinire la sua posizione in un sistema produttivo che impone delle regole derivate dal mercato. Io ho voluto raccontare il loro tentativo di fuga da queste costrizioni: come vive un artista? Come si mantiene davvero? Quali capricci e abitudini determinano la sua vita? Dove lavora? Che esperienza fa?
Sono tante le vicende che s’intrecciano a quelle del protagonista: Uccidi l’unicorno non è un’inchiesta o un saggio di sociologia, ma è un’opera narrativa, un bestiario personale che si basa sul dolore e sull’esaltazione.

EB: Il libro è scandito dal ritmo delle slide (le immagini che mostrerai nella presentazione per il convegno). Ti soffermi sui grandi nomi del ‘900, inizi con Duchamp, ma citi anche poeti come Luigi Di Ruscio (che diventa nel tempo anche un tuo ‘santo protettore’ come lo scrittore Federigo Tozzi), ma anche amici artisti viventi a cui cambi il nome (es. Palmiro, chi è?). Senza badare all’importanza che – doverosa – dovresti dedicare ai grandi, la sparpagli in modo democratico a molte figure importante per la tua formazione. Si può dire che l’arte è stata utilizzata nel libro per dare sfogo a molte delle esperienze esistenziali che avevi l’urgenza di raccontare? L’arte ti ha ispirato?
GS: Io lavoro da dieci anni alla NABA di Milano, nel Dipartimento di Arti Visive e Studi Curatoriali, e lì, grazie al contatto con studenti e docenti, ho capito che l’arte non è soltanto un punto d’arrivo, una meta da raggiungere. Anzi, spesso può diventare uno strumento che consente il percorso inverso, e cioè di esplorare il mondo ed esplorare se stessi, talvolta andando alla deriva. In questo senso la ricerca accademica trova una messa in pratica. Quindi, per rispondere alla tua domanda, ti dico che la parola più importante nella mia pratica letteraria è “ricerca”, la cui etimologia contiene il termine latino “circum”, e cioè muoversi attorno a qualcosa. Il movimento circolare mi pare un modo efficace di visualizzare il percorso che porta ad avvicinarsi a qualcosa senza mai raggiungerlo. Grazie a questa impossibilità intravedo il senso dello scrivere.
EB: Un aspetto mi ha incuriosito. Scrivi: “… non mi interessa soltanto proporre un confronto di tipo storico o estetico. Io ambisco ad un obiettivo più prestigioso: cogliere il punto di vista dei dominati, di chi sta in basso alla catena alimentare, e cioè il punto di vista mio e di questi artisti emergenti, tipo Palmiro, i miei compagni di viaggio…” Quasi proclamata, questa dichiarazione sembra rivolta agli ‘oppressi dell’arte’, ai disagiati o esclusi. Insomma, con chi ce l’hai?
GS: Il sistema dell’arte, nel quale circola una quantità di denaro inimmaginabile, si basa sul lavoro sottopagato o addirittura gratuito di migliaia di persone. Mancano tutele adeguate, purtroppo è così e bisogna prenderne atto. Le regole sono chiare dall’inizio. Eppure è ancora attuale la convinzione che l’arte sia mossa soltanto dalla bellezza, dall’emozione, dalla poeticità e via dicendo, insomma da quei valori che la sciolgono dai vincoli con l’economia e il potere. In questo modo l’arte si riduce ad attività ricreativa – e infatti è sparita dai radar al primo manifestarsi della pandemia. Dunque, per concludere il discorso sul lavoro culturale ti dico che le esperienze raccontate nel romanzo rivolgono una domanda: ne vale davvero la pena? Io ho trovato le mie motivazioni per dire di sì.
EB: Uno degli aspetti che emergono più rilevanti del libro, a mio parere, è come sei riuscito a tessere le esperienze di grandi artisti passati con situazioni strettamente legate all’oggi. Le difficoltà degli artisti nel “sopravvivere” (e parlo di sopravvivenza sia metaforica che reale), ma anche sollevi domande fondamentali per tutti coloro che si occupano e lavorano nel sistema culturale: “cosa significa organizzare un evento culturale mentre attorno a noi la vita si stravolge? Che cosa significa fare esperienza di una mostra attraverso lo schermo?”
Ti chiedo quali altre domande vuoi o vorresti che il tuo libro ponesse agli operatori dell’arte. O forse la tua intenzione è un’altra?
GS: Hai ragione. Fra le altre cose, l’arte serve a porsi delle domande. Io ne pongo alcune alla luce di esperienze, in particolare quelle tipiche dei primi anni della carriera, con lo scopo di ragionare non tanto sull’arte bensì sull’essere umano. Credo che un’opera letteraria sia un corpo organico, in continua mutazione, che cambia al cambiare dell’autore e della situazione. Quando ho pensato e scritto il libro non c’era la pandemia. Rileggendolo mi sono accorto che alcune domande sono sempre attuali, altre probabilmente le aggiungerei. Per esempio: la chiusura di musei e gallerie è servita a sentire la mancanza dell’arte o di noi in mezzo all’arte?
EB: “La persona comune diventa un artista quando uccide la propria giovinezza”. “La persona comune diventa un artista quando matura il proprio sguardo”. “La persona comune diventa un artista quando coincide con le sue opere”…
Sono certa che molti artisti potrebbero convincerti del contrario, su quasi tutto. Cosa o chi ti ha condotto ad affermare queste frasi?
GS: Queste sono le affermazioni con cui il protagonista costruisce il suo intervento al convegno. Sono contento che tu dica così perché le ho scritte con ironia. Per essere contraddetto. “La persona comune diventa un artista quando uccide la propria giovinezza” vuol dire tutto e niente. Purtroppo non so che cosa serva per diventare un artista. Se lo sapessi, avrei scritto un manuale. Però io tendo a diffidare dei manuali perché, come spiegavo prima, riducono la complessità di un fenomeno a pura formula. Anche quando accadono esperienze simili, ognuno ha un modo diverso di viverle e di considerarle. John Dewey, uno degli autori che cito nel libro, sostiene che l’esperienza è sempre unica. Sono d’accordo. Le formule nascono per essere applicate. Io, all’opposto, ho scritto un libro inapplicabile, senza risposte. Non m’interessa consolare nessuno, casomai il contrario.
EB: Quasi perverso, non ci fai sapere come andrà il convegno. Immagino sia andato bene o è stato un disastro? L’importante, credo, è che non ti sia tagliato la lingua…
Il convegno è una botola che si spalanca sull’abisso. La situazione è tratta da un fatto reale, ma nel romanzo serve a creare quella tensione che obbliga il protagonista a fare delle scelte. Per esempio a tagliarsi la lingua. O meglio a domandarsi, per assurdo, se “essere contemporaneo nell’epoca della comunicazione” significhi privarsi per sempre della parola. La scrittura d’arte tende a essere troppo astratta, a universalizzare i concetti, a sfruttare un codice che però genera distanza. Nasconde il significato. Impone uno standard ai suoi pubblici. Le categorie e i codici sono elementi reazionari per eccellenza. Io sono un lettore abbastanza attento; perciò, prima di scrivere, mi sono interrogato su questi aspetti e ho deciso di esplorare altre possibilità. Di contaminare i registri.
Nel mio caso la scrittura è anche il contenuto.
Ps: Comunque, per essere sinceri fino in fondo, una volta ho provato a tagliarmi la lingua, ci si può riuscire in diciotto passaggi, ma poi mi è mancato il coraggio.
Gabriele Sassone
Uccidi l’unicorno
Il Saggiatore
ISBN 9788842826651
pagine: 224
€ 19,00