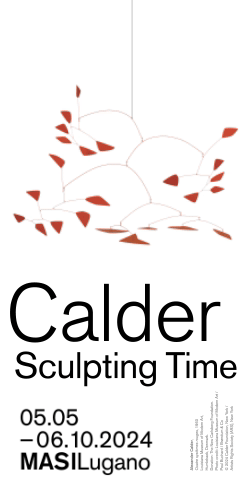In Alto Adige, terra da sempre interessata dal fenomeno dell’immigrazione per motivi economici, la mostra estiva di Kunst Meran Merano Arte guarda da una nuova prospettiva il tema dei processi di integrazione e ibridazione culturale dei migranti, una volta radicatisi nei contesti di arrivo. La collettiva Vielheit [Molteplicità]. Storie dalla società post-migrante (fino al 24 settembre), a cura di Jörn Schafaff, si interessa dell’interscambio culturale prodotto dalla pluralità di etnie e provenienze che connatura e arricchisce ogni aggregazione sociale del mondo contemporaneo. Il termine “post-migrante”, poi adottato dalla sociologia, venne introdotto nel dibattito culturale tedesco nel 2008 da Shermin Langhoff, fondatrice e direttrice artistica di un teatro nel quartiere berlinese di Kreuzberg presso cui diede spazio a storie di immigrati di seconda o terza generazione, figli e nipoti di chi si era originariamente trasferito in Occidente lasciando i propri paesi di origine. L’accostamento di questo termine con “Vielheit”, un’espressione che in italiano può essere tradotta con “molteplicità”, conferisce una chiara impostazione teorica alla collettiva meranese, a favore di una inedita rivalutazione della complessità e al contempo della ricchezza cangiante dei fenomeni di integrazione sociale. Se infatti i media discutono – per quanto spesso in termini impropri – il fenomeno dell’immigrazione, al contrario tralasciano del tutto di parlare del processo conseguente di adattamento degli immigrati e dei loro discendenti al tessuto sociale di destinazione. Nel dibattito pubblico viene meno anche una corretta comprensione delle difficoltà di convivenza tra diverse sfere culturali, oltre che del rischio endemico di oppressioni e discriminazioni subite dai post-migranti. Come ha evidenziato il curatore in sede di visita per la stampa, la stessa tendenza si registra nel mondo dell’arte: “‘Vielheit’ in un certo senso appare come un termine matematico, indicante un gran numero di entità indipendenti che però appaiono collegate in un insieme più grande. È anche l’opposto di ‘Einheit’, ‘unità’, e questo dice molto riguardo alla società contemporanea. Riteniamo che, se molto è stato fatto nel mondo dell’arte per gettare nuova luce sulla migrazione come fenomeno di spostamento di individui e comunità da un paese all’altro per motivi politici ed economici, non è stata dedicata altrettanta attenzione a ciò che accade quando le persone arrivano a destinazione e si stabiliscono, interagendo con le comunità locali. Cosa significa per loro arrivare in un contesto così diverso da quello di origine? Quali sono le tecniche culturali che gli immigrati sviluppano per provare ad integrarsi? Un modo per avere delle risposte è dare la parola ai diretti interessati”.


Cioè ai tredici artisti invitati, che in alcuni casi elaborano le loro esperienze personali legate alla migrazione (quasi tutti al momento vivono in paesi diversi rispetto a quelli in cui sono nati), ma anche a persone comuni, interpellate dagli artisti stessi in alcune delle opere audiovisive esposte in mostra. Proprio una di queste apre il percorso espositivo, posizionandosi tra una rampa e l’altra della scala che conduce al primo piano. Si tratta di Inventur Metzstraße 11 (1975) del regista di origini iugoslave Želimir Žilnik (Serbia, 1942), trasferitosi nella Germania Ovest negli anni Settanta. Lì si interessò alle storie dei cosiddetti Gastarbeiter, i “lavoratori ospiti” trasferitisi in Germania da nazioni come la Turchia, la Grecia e l’Italia. Nel filmato documentario esposto in mostra, Žilnik coinvolge i residenti in un condominio di Monaco di Baviera, tutti immigrati per motivi di lavoro, invitandoli a scendere uno a uno le scale del palazzo fino al pianerottolo dove era posizionata la cinepresa per parlare a turno delle loro vite, delle difficoltà ad integrarsi e delle speranze riposte nel futuro. Il visitatore sale la scala di Kunst Meran e vede in un certo senso venirgli incontro dai piani superiori, afferenti ad un altro tempo e un altro spazio, persone comuni con cui misurare il proprio vissuto. Arrivati al primo piano, si è accolti da un grande vaso di fiori bianchi posizionato su un piedistallo. Bouquet IX (2012) di Willem de Rooij (Paesi Bassi, 1969) è una rappresentazione esemplare della Vielheit: l’apparente unitarietà dell’insieme trasmessa dall’uniformità cromatica nasconde il fatto che nel vaso convivono le più disparate varietà floreali, dal giglio al gladiolo, dalla gerbera al garofano, dal crisantemo alla bocca di leone, la maggior parte delle quali, peraltro, vanta origini extraeuropee. L’osservazione attenta del bouquet consente di rendersi conto di quanto le differenze tra un fiore e l’altro contribuiscano alla bellezza dell’insieme. Ma l’opera riflette anche sull’associazione discriminatoria tra la pelle bianca e i concetti di candore e di purezza: considerato che il bouquet richiede una cura costante per tutta la durata dell’allestimento – i fiori necessitano di essere innaffiati più volte al giorno e di essere sostituiti quando appassiscono – è reso manifesto quanto sia faticoso mantenere un’immagine artificiale di purezza in un mondo globalizzato sempre più incline al meticciamento. I fiori bianchi risaltano visivamente sulla parete di fondo dell’ambiente, accesa da due colorati “paesaggi linguistici” di Barbara Gamper (Gran Bretagna-Italia, 1981), che sono l’esito di un progetto portato avanti dall’artista con gli alunni delle scuole di Merano, basato su un questionario e delle interviste relativi all’impatto del multilinguismo nella loro vita quotidiana (Linguistic landscapes (how do we come together in our differences?), 2023).

La stanza successiva è occupata da un’installazione audiovisiva dell’artista Rirkrit Tiravanija (Thailandia, 1961), Untitled 2023 (neighbours) (2023), una piattaforma rialzata su cui sono allestiti degli schermi. Il lavoro è stato prodotto appositamente per la mostra su ispirazione di un’opera precedente, che rifletteva sulla sua condizione di studente thailandese emigrato in Canada e sulle sue difficoltà ad accettare un contesto così radicalmente diverso da quello da cui proveniva. A Merano lo stesso tema viene richiamato dal fatto che la piattaforma ha la stessa estensione e conformazione del monolocale in cui l’artista andò ad abitare una volta giunto in Canada. Gli schermi trasmettono interviste effettuate da Tiravanija ad alcuni residenti meranesi di varia provenienza, che parlano di come è cambiata la loro vita dai primi tempi in città rispetto alla situazione attuale, ma anche del cibo che risveglia in ognuno di loro i ricordi dei rispettivi luoghi di origine. I diretti interessati nei primi giorni di mostra hanno organizzato un pranzo in cui hanno preparato i piatti a cui fanno riferimento nelle interviste. Sulle pareti della stanza sono appese due sculture di Haegue Yang (Corea del Sud, 1971), composte da due lavandini da cucina messi in verticale e parzialmente coperti da tapparelle. I lavandini sono identici a quelli presenti in due case in cui l’artista ha abitato, una a Seoul e una a Berlino. Se sul piano formale questi assemblage richiamano la pittura astratta, la natura stessa degli oggetti e le differenze reciproche fanno riflettere su quanto il contesto sociale e culturale influenza anche l’intimità della propria vita domestica. Riverbera con questo tema la successiva opera video The Song (2022) di Bani Abidi (Pakistan, 1971), il primo lavoro con cui l’artista indaga la propria condizione di emigrata a Berlino. La sua vicenda personale è trasfigurata nella storia di un uomo anziano che si trasferisce da una metropoli del sud globale nella capitale tedesca, città nella quale ha difficoltà ad ambientarsi per le diverse abitudini ma anche e soprattutto per il silenzio che pervade la sua casa, così diverso dai rumori di fondo della sua terra di origine. Per riempire il vuoto sonoro che lo circonda, l’anziano inventa alcuni strumenti musicali improvvisati utilizzando oggetti di uso quotidiano – ad esempio un sacchetto fissato ad un ventilatore, oppure delle bottigliette di plastica accartocciate e fatte muovere dal motore di uno spazzolino elettrico. È significativo che l’attore sia egli stesso un immigrato di origini siriane e che gli “strumenti” siano stati inventati da un giapponese ora residente a Londra, il sound artist Rie Nakajima.

Nell’ultima sala del primo piano sono esposti due dipinti di grandi dimensioni di Nadira Husain (India-Francia, 1980), che mettono in scena sul piano tecnico, stilistico e iconografico il portato culturale ibrido dell’artista, figlia di padre indiano e di madre francese. Al centro di An Elephant in Front of the Window, Kulfi (2022) è rappresentata una stanza della casa della nonna dell’artista a Hyderabad, a cui si sovrappongono in trasparenza delle sagome di elefanti che a loro volta contengono al loro interno delle figure femminili che lottano, in uno stile che ricorda le miniature di epoca moghul (XVI secolo). In Somewhere Between Love and Fighting, Argent (2020) i motivi ricorrenti degli elefanti e delle donne in lotta – che se sovrapposti alludono a questioni di empowerment femminista, dato che gli elefanti sono simboli indiani tradizionali del potere – sono accostati ad elementi della cultura fumettistica franco-belga (il pretzel ricorrente sembra richiamare nei colori la coda del personaggio Marsupilami, disegnato da André Franquin). Salendo al secondo piano ci si trova davanti ad un grande arazzo dorato e istoriato che occupa un’intera parete, ad opera di Pradip Das (India, 1980). Golden Wall II (2022) è stato prodotto dall’artista come parte di un’installazione preparata per il Durga Puja, una festa annuale in onore della dea Purga celebrata soprattutto negli stati indiani a prevalenza hindu, tra cui il Bengala occidentale e la sua capitale Calcutta, città in cui Pradip Das risiede. Essendo Calcutta da decenni la meta di ingenti migrazioni dal Bengala orientale, ora Bangladesh, l’artista ha voluto introdurre nell’iconografia tradizionale della festa nuovi spunti di riflessione sulla condizione dei migranti bangladesi. Per questo motivo ha invitato più di trenta donne provenienti da oltre confine a ricamare una sorta di ritratto collettivo della memoria del proprio paese e delle loro attuali condizioni di vita, dando loro gli strumenti per emanciparsi da una condizione di estrema povertà e per portare le proprie storie all’attenzione di milioni di persone. La stanza successiva è dedicata all’indagine fotografica condotta da Nicolò Degiorgis (Bolzano, 1985) tra il 2009 e il 2013 riguardo ai luoghi di culto musulmani nell’Italia del Nord, spesso ricavati all’interno di edifici commerciali, a causa dell’impossibilità di disporre di moschee vere e proprie. Questo accorto lavoro di ricerca è confluito nel 2014 nel libro fotografico Hidden Islam. Islamic Makeshift Places of Worship in North East Italy, 2009 – 2013. Sfogliando il volume si vede una sequenza di palazzi anonimi che nulla tradiscono delle funzioni religiose che si svolgono al loro interno; solo soffermandosi su ogni pagina si può procedere ad aprirle a ribaltino per rivelare fotografie dei musulmani in preghiera nei rispettivi luoghi. Il lavoro fotografico, che denuncia l’emarginazione sistemica a cui queste comunità vanno incontro, è accompagnato in mostra da una parete di documenti raccolti da Degiorgis nel corso delle sue ricerche in relazione ad una specifica moschea situata a Treviso, protagonista di forti polemiche e di articoli di giornali locali che esprimono punti di vista esplicitamente discriminatori.


Una simile attenzione verso realtà urbane invisibili la mostra Ecaterina Stefanescu (Romania) in una serie di modelli che riproducono minuziosamente un supermercato berlinese specializzato in prodotti rumeni e gli appartamenti in cui vivono rispettivamente la cassiera e un cliente abituale (Rooms, 2022). Ogni realtà lavorativa e domestica è riprodotta fin nei minimi dettagli dell’arredo interno, dimostrando la dedizione a restituire la vera ricchezza del tessuto sociale delle grandi città occidentali. Subito dopo si incontra Inventur 2021 (2021) di Pinar Öğrenci (Turchia, 1973), un filmato che vuole essere un remake esplicito del lavoro documentario di Želimir Žilnik che apre la mostra di Kunst Meran, con cui dialoga a stretto contatto, dato che dalla sala in cui è allestito Inventur 2021 ci si può affacciare sulla scala in corrispondenza della quale, un piano e mezzo più in basso, si trova lo schermo che trasmette Inventur Metzstraße 11. Nel lavoro di Öğrenci, che sul piano formale si discosta dall’antesignano solamente per il fatto che gli interpellati, per arrivare alla telecamera, salgono le scale del loro palazzo invece di scenderle, sono gli abitanti di un condominio di Chemnitz a parlare delle proprie storie di migrazione, mostrando un ventaglio di provenienze molto più ampio ed esplicitando quanto un’indagine antropologica di questo tipo abbia valore di testimonianza dei cambiamenti indotti nella società da fenomeni complessi come la globalizzazione. L’ultima parte della mostra è introdotta dall’opera video di Clément Cogitore (Francia, 1983) Les Indes Galantes (2017), con la quale l’autore si appropria dell’omonimo opéra-ballet (1735) del compositore Jean-Philippe Rameau, oggi ritenuto problematico perché intriso di cliché esotici. In particolare, mette in scena una riscrittura radicale dell’Aria dei Selvaggi; se Rameau aveva concepito il balletto ispirandosi ad una danza tribale di nativi americani della Louisiana, Cogitore affida l’interpretazione ad un gruppo di ballerini di strada parigini che praticano il Krump, una danza fatta di ritmi incalzanti di gestualità aggressive nata negli anni Novanta in seno alla comunità afroamericana di Los Angeles come replica nonviolenta ai soprusi a sfondo razzista della polizia. L’aria trionfante si presta così ad una risignificazione emancipatoria.

Più avanti, è esposta una scultura in mattoni e tessuto di Sol Calero (Venezuela, 1982), che mima l’aspetto di una ballerina di salsa (Escultura Salsera II, 2014). Emigrata in Spagna dal suo paese di origine, l’artista ha vissuto sulla sua pelle varie forme di discriminazione, che l’hanno indotta per reazione a studiare molto più a fondo la sua cultura. L’esito è la ricostruzione di scenografie di ambienti tipici diffusi nel suo paese, popolate da figure come questa. Essendo le componenti della scultura assemblate posticciamente tra loro, potrebbero essere riconfigurate a piacere in altre fogge; questo suscita domande sui processi di costruzione delle identità culturali. La mostra si chiude con una scultura sospesa realizzata da Haegue Yang mediante la tecnica del macramè (Woven Archi-Head in Six Folds – Accentuated Nature, 2018). Dal fitto intreccio che compone la sagoma antropomorfa pendono gli oggetti più vari (delle campanelle, degli spiedini da barbecue, alcune collane), che tradiscono diverse origini. Qua e là gli intrecci assumono l’aspetto di spirali di DNA. Sembra in atto una rappresentazione del meticciamento culturale, peraltro resa mediante una tecnica in sé oggetto di migrazioni nel corso di tutta la sua storia, a partire dalla sua nascita nella regione araba e dalla sua successiva diffusione in Europa attraverso la Spagna. La Vielheit si trova così reificata nella forma di una rete euristica di contenuti culturali funzionalmente indipendenti ma inestricabilmente interconnessi.
Per alimentare ulteriormente il dibattito su questi temi, Kunst Meran Merano Arte ha organizzato un public program con proiezioni, talk e workshop. Si segnala in particolare la serie di quattro incontri avvenuti tra giugno e luglio dal titolo Haircuts With Attitude, tenutisi in un salone da parrucchiere fittizio in cui l’artista Filippo Contatore ha tagliato i capelli alcuni ospiti, tra cui la critica d’arte Rosalyn D’Mello e la ricercatrice sulle migrazioni Claudia Lintner, discutendo nel frattempo con loro di questioni inerenti all’identità culturale e alle società post-migranti.