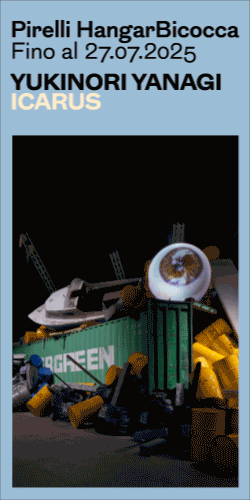Mauro Zanchi: Da dove ha origine il tuo lavoro immaginale?
Marcello Maloberti: Le prime immagini che ci ricordiamo dei nostri primi anni di vita sono come segni del destino, ed è giusto coltivarli e seguirli. Penso che il mio immaginario parta da quando da piccolo, alle messe della domenica, divagavo con l’occhio sul soffitto della chiesa tra i corpi e gli affreschi della storia del Vangelo. Stavo sempre con gli occhi rivolti al soffitto, non ascoltavo nulla della messa, era evadere dalle prediche del prete. La corporeità emana eros, è un’energia cosmica, un’estasi, una vertigine. Quando si usciva dalla chiesa, sul sagrato accadeva un momento di estasi, di pace e conciliazione tra cielo e terra, che si sgretolava non appena arrivati in fondo alle scale.
Giocavo solo per le strade, fuori dai cortili, mi appendevo con le mani e stavo ore appeso con i piedi a penzoloni senza toccare mai terra. Erano gli anni ‘70. Mangiavo sulla finestra non avendo un balcone, la mia casa era al primo piano. Mia nonna era una poesia vivente, alleviava la mia paura di non riuscire a parlare, balbettavo come un trattore. IL MIO LAVORO NASCE DA UNO SPAVENTO. Mischiavo il divino e lo sporco delle strade.
MZ: Se tu avessi la possibilità di viaggiare nel tempo (ma forse già lo fai), dove andresti e in quale tempo storico? Cosa cambierà nel campo dell’arte contemporanea, alla luce delle attuali conseguenze dovute alla pandemia da covid-19? Le intuizioni degli artisti potranno essere messe a disposizione per cercare di arginare possibili altre pandemie future o altri momenti di crisi? Cosa dovremo rivedere e quali saranno gli sviluppi post-crisi?
MM: Il mondo è caricato a salve. Mi sembra che questo modo di vivere, ai limiti dell’umano, fosse in qualche modo presente dentro di noi già da prima, solo non ne potevamo prevedere la forma. Camminiamo per le strade e sembriamo degli zombie, come già aveva detto Carmelo Bene al Maurizio Costanzo Show.
Poi c’è tutta la questione della digitalizzazione e dei social media, che critichiamo tanto, ma alla fine anche io sto al gioco perché in parte mi diverte. In questo momento per me è anche un modo per creare ed è l’unica finestra che ci rimane di contatto. È come toccare del materiale invisibile. Nel discorso di Pier Paolo Pasolini in cui metteva in relazione il fascismo e la televisione, possiamo sostituire quest’ultima parola con “social media” e il ragionamento resta identico.
È così delicato questo momento di trauma collettivo che preferisco restare a respirare piano in silenzio per poi capire come agire. Pensa te che ci voleva questo per unirci. Sul futuro preferisco non esprimermi troppo perché parlarne rischia di risvegliarlo troppo presto e di generare un futuro addormentato. Si tratta di una rivoluzione antropologica, che poteva arrivare solo con un grande spavento. Un’altra parola su cui ragionare è “potere”: che faccia ha il potere oggi? Amazon, Instagram, Facebook, la Silicon Valley? È come essere le cavie di questi grandi poteri. Sembra che questa sia una grande prova generale per verificare il limite del potere che hanno per manipolare l’uomo. La nube dell’informazione mediatica mangia ogni cosa attorno a noi. Il potere è la cosa più anarchica e più sadica, viviamo di pure contraddizioni. Mi sembra che l’uomo pensi che il cambiamento e il futuro possa essere solo quello tecnologico. Non esiste più una spiritualità che va oltre, ogni cosa è con i piedi per terra. Dobbiamo arrivare a trovare un equilibrio per far sì che questa nuova realtà non ci porti ad essere sempre più isolati. Non me la sento di parlare del futuro e non so come l’arte reagirà a tutto questo; il futuro lo puoi toccare, ma senza esserne cosciente, così anche nel mio lavoro forse posso prevedere delle cose ma sempre inconsciamente. Forse l’arte dovrebbe lavorare di più sulla parola e sulla scrittura. “Abbiamo bisogno di libri che abbiano su di noi l’effetto di una sventura, che ci dà molto dolore… un libro deve essere come una scure piantata nel mare di ghiaccio che è dentro di noi” dice sempre Franz Kafka.
Vorrei avere a disposizione infinite vite, perché vorrei essere nato una volta agli inizi del Novecento ed essere io Kafka, poi esserlo nei nostri giorni per poter rinascere all’inizio del Tremila. Nel Novecento c’era la poesia, che se la paragoni a quello che c’è oggi c’è da vergognarsi.
L’ARTE DEL FUTURO PER ME DEVE ESSERE UN’ARTE CHE MI DIA LA SENSAZIONE DI ESSERE VIVO!
MZ: Ci interessa approfondire come hai trattato il tema della corporeità della scultura, sia attraverso il medium fotografico sia attraverso l’informe incognito, che si mette in moto quando chiedi ad altre persone di partecipare alla attivazione di un immaginario.
MM: Il mio primo incontro con l’arte è stato da piccolo, con il grande quadro della Conversione di San Paolo del Caravaggio. In Caravaggio c’è la teatralità della scultura classica, tanto quanto quella della scultura di Michelangelo. Il corpo è il mio legame con la storia dell’arte, è un filo conduttore che parte dalla classicità, IL CORPO HA UNA LUCE COME SE FOSSE ILLUMINATO DALL’INTERNO. L’omologazione e i tatuaggi che coprono la pelle del mondo mi fanno venire il vomito! E la luce del corpo è offuscata, lo stanno facendo diventare buio.
Il corpo è quasi sempre quello dell’altro, anche il mio è estraneo e da solo non può bastare a raccontare tutto il mio immaginario. Solo dal dialogo, dall’urto con l’altro, con culture altre dalla mia, vedo con più chiarezza.
Lavoro con il corpo dagli anni ‘90 e da sempre lo vedo come un momento poetico, come un linguaggio universale. È uno sguardo che cadendo nel particolare lo rende universale. Il mio occhio cade sempre nelle cose marginali. È come se attraverso il nostro corpo parlassimo una seconda lingua, un dialetto, come dice Gilles Deleuze. Una frase di Pier Paolo Pasolini mi martella in testa: “Io sono una forza del passato”. Il mio lavoro è un colloquio continuo con l’arte antica.
Gli artisti negli anni ’70 hanno indagato moltissimo la performance, sublimando il corpo in un modo meraviglioso. Allora mi sembrava più interessante parlare di un corpo collettivo e politico, e per me politico è uguale a poesia.
La performance ha una sua vitalità, non volevo esporre qualcosa di chiuso, morto, ma vivo. Il mio lavoro è sempre stato legato al corpo, inteso come archetipo: quando parliamo del corpo umano si parla di quello della natura, di quello artificiale, è un corpo-mondo, è qualcosa che non ha mai fine nella sua lettura, come la classicità che è inesauribile e che ci apre sempre nuove porte. Siamo noi che apparteniamo all’antico. Nelle mie azioni c’è sempre l’imprevisto, mi piace non poter decidere tutto e questo deriva proprio dal fatto di non poter prevedere l’incontro con l’altro, non posso sapere cosa succederà.



MZ: Quale è la tua riflessione più attuale sulla continua riproduzione delle immagini in una società che pare ormai priva di memoria storica?
MM: Sì, questo deriva dall’idea della continua novità, dalla politica e dall’economia del nuovo che pervadono la nostra società. Il mio occhio invece non è formato dal nuovo, ma dagli strati di esperienza e di memoria vissuta. Io guardo attraverso la stratificazione del passato. Viviamo in un momento di totale inconsistenza delle cose, queste vivono e vengono consumate in tempo troppo breve. Per questo amiamo il classico, perché ha un tempo infinto. L’abbaglio del nuovo non mi ha mai interessato. Nel mio lavoro cerco di costruire immagini e situazioni che spesso rimandano direttamente all’antico. La costante riproduzione delle immagini e l’assenza di memoria storica assieme sono un binomio assurdo; per me non c’è questa contrapposizione perché il mondo, l’immaginario comune, è un grande archivio caotico da cui attingere. L’arte è come scolpire il tempo (Andrej Arsen’evič Tarkovskij).
Quella che viviamo è un’identità molto mobile oggi, forse troppo però. Allo stesso tempo non amo quando l’artista si arena in un suo lavoro perché molto riconoscibile e riconosciuto, mi piace che sia la vita stessa ad apportare dei cambiamenti e che il mio lavoro si sposi con il cambiamento della persona stessa.
“Solo l’amore, solo il conoscere
conta, non l’aver amato,
non l’aver conosciuto. Dà angoscia
il vivere di un consumato
amore. L’anima non cresce più.”
Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice, in Le ceneri di Gramsci (1957).
MZ: Cosa intendi innescare nell’immaginario dei tuoi fruitori, laddove tu metti in scena qualcosa che ha una forma indefinita e imprevedibile, un’opera difficile da ricordare proprio perché non ha una forma definita?
MM: In realtà credo che alcuni miei lavori abbiano un’uniformità più forte, spesso cerco di semplificare l’occhio fino ad arrivare a un’icona ben precisa. Penso a Cuore mio, il lavoro dedicato a Maria Lai, che ha avuto una prima tappa ad Ulassai, città di origine dell’artista, e una seconda tappa a Roma, sua città “adottiva”.
Qualche anno fa ho capito che stavo incappando in questo problema e ho capito che bisogna trovare l’equilibrio giusto tra l’iconico e l’informe.
La parte più sociale del mio lavoro, anche se non amo questa parola, è quella dello spazio d’azione che predispongo per l’altro, per il fruitore e per tutti i partecipanti delle mie azioni, che come sai rivestono molti ruoli differenti. È l’artista collettivo. La vita è forma tra le forme. A Ulassai per esempio al momento di sollevare il cartello io avevo una mia idea su come farlo, fu l’operaio che prese parte all’azione a convincermi a farlo come lui diceva che fosse meglio, secondo la sua conoscenza, e quindi a sollevarlo nel cielo. Questo ha significato un cambiamento nell’opera. Lui ha agito come un soggetto che dirige l’azione, oltre che ad averla svolta, ha avuto contemporaneamente il ruolo di performer e di regista.
SIA LODATO L’IMPREVISTO SEMPRE SIA LODATO. So accogliere e assorbire l’imprevisto. L’altro ha sempre più spensieratezza dell’artista, è libero dal metodo. I miei strumenti sono l’intuito, l’immediatezza e l’ingenuità, sono strumenti del comportamento.
Dovremmo liberarci delle nostre sovrastrutture, l’uomo dovrebbe guardare all’essenza delle cose e alla sua storia. Credo molto nell’artista e nella sua facoltà oracolare, sia attraverso le parole che attraverso le immagini. Cerco di non avere una lingua mia, da sostenere, mi mischio con il linguaggio degli altri, mi piace essere sgrammaticato.
Partire dall’idea di voler innescare qualcosa nell’immaginario altrui è un metodo di pensiero meccanico: chiedersi cosa si voglia provocare nell’altro con l’arte è la cosa più sbagliata, non ho mai un concetto da imporre, questo è fascismo. Mi piacerebbe che lo spettatore si abbandonasse allo sguardo e alle sensazioni per entrare nella mia poetica, con più spensieratezza, con sensazioni più libere e non fritte/attanagliate dai ragionamenti del cervello, ma credo che questa capacità sia un po’ andata persa. Si arriva alle mostre già con dei preconcetti.
In testa non ho mai la relazione causa-effetto, al massimo parto dall’effetto per arrivare alla causa. L’aurea per Benjamin è quando le immagini conservano gli occhi e ti guardano, bisogna trovare gli occhi delle cose, è come se fossi tu ad essere guardato più che essere tu a vedere.
MZ: Nella performance Vir Temporis Acti (2016), un ragazzo ritaglia le immagini dei grandi capolavori statuari neoclassici degli artisti presenti in collezione della GAM di Milano e di altri capolavori della storia dell’arte. L’atto del tagliare immagini d’arte stampate sulle pagine di libri e cataloghi sembra un gesto legato alla sottrazione, al togliere pezzi dal blocco di pietra che si vuole scolpire. Forse rimanda anche a qualcosa che in musica si direbbe in levare. Cosa fai accadere in questa performance?
MM: Vir temporis acti è una serie di azioni che mi piace replicare nel tempo, come una ripetizione che cambia ogni volta. Questi lavori nascono dalla mia ossessione per il ritaglio, amo il collage, ma non amo la colla, perché non mi piace la fissità, amo invece l’idea di movimento, cambiamento. È l’informe di Rosalind Krauss. Tra i diversi gesti di queste azioni ce ne è sempre uno che è come la scena madre nel cinema, e lo fisso nelle fotografie. Mi piace la leggerezza della fotografia, tutto si schiaccia nei miei occhi, il mio lavoro è una sublimazione del piano.
Tu mi chiedi dell’azione della GAM, ma una a cui io tengo particolarmente è Vir temporis acti realizzata per la Quadriennale a Roma. Anche qui questo ragazzo biondo, cereo, esangue, è intento a ritagliare immagini della storia della scultura. Il taglio è un atto scultoreo. Il performer stesso, a torso nudo, è scultura. È l’immediatezza del corpo. In queste azioni ci sono delle opere scultoree che inserisco sempre, sono l’Estasi di Santa Teresa e quella della Beata Ludovica Albertoni del Bernini. La meraviglia di queste sculture sta nell’abilità del Bernini di mostrarci l’estasi del respiro e del reale che vi sta attorno, della luce che entra dalla finestra. Come dice Gilles Deleuze, non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo.
È come se stesse ritagliando tutte le sculture del mondo, dell’intero passato, per la costruzione di un’enciclopedia impossibile. Ma, con le mie azioni, che più che azioni definirei come gesti, poi introduco il caos. È il concetto di archeologia che ritroviamo in Giorgio Agamben e il fatto che l’unico modo per approcciarsi al reale è con il passato. Ma è anche il frammento, che non prevedendo alcuna gerarchia è assenza di potere, in quanto non è mai una forma chiusa, ma sempre aperta. Il frammento è rovine di rovine.
Parlando di scultura non possiamo non parlare anche di pittura, sono due cose che vanno assieme (come nelle antiche sculture greche dipinte di colori brillanti). Nel suo essere piatto, il ritaglio della scultura si fa più vicino alla pittura. Una distesa di sculture piatte ricopre il pavimento come un grande collage, è l’informe delle immagini, che si muove quando le persone camminano. Al passaggio delle persone cambia e muta, tutto scorre, non c’è un prima e un dopo nel tempo, è anche un lavoro sulla temporalità. È un farsi e disfarsi continuo. Camminare attiva la memoria, camminare è sfogliare. È un gioco, è la mania dell’arte, la mania del ritaglio. IL RITAGLIO È LA FORMA SCULTOREA DEL PIANO.
Nel taglio la costruzione e la distruzione coincidono, distruggo i libri per costruire qualcosa di altro. Il mio gesto è come dici tu di sottrazione, perché nella cultura occidentale siamo molto più legati all’idea di aggiungere, io mi sento più vicino a quella di vuoto e di sottrazione. Bisogna pensare anche ai vuoti che rimangono nel libro che utilizzo, è come se la carta fosse la pietra. Il mio lavoro nasce dal non pensare, dallo sfogliare le riviste che è ipnotico, da un momento di sospensione, cercare attimi di grazia oltre alla logica, mi ipnotizza sfogliare le riviste. Sono immagini metafisiche mute, silenziose.
Mi piace pensare che queste performance con i ritagli non abbiano fine, come se i performer abbandonassero il lavoro per poi magari tornare, è un lavoro che può sempre ricominciare ed essere ripreso.


MZ: Mi piace che tu intenda i lavori come fossero dei sentimenti. Il passaggio dallo sfogliare immagini (presenti in libri, giornali, riviste), a contemplare per ore i libri, a creare collages nel tuo blog Marmellate, a spostare tutte le presenze del tuo immaginario in direzione di una nuova opera che dovrai mettere al mondo, cosa attiva a livello sentimentale?
MM: Il mio atteggiamento verso la vita e l’arte alla base parte sempre dal sentimento e dal desiderio che sono alla base di ogni cosa.
Viviamo di contraddizioni, come vedi parlo di archeologia, ma anche di cultura da rivista, non c’è rigidità. Da piccolo ho avuto dei problemi con la parola, per me l’immagine è una scritta contratta, LE ICONE SI SBRICIOLANO TRA LE MIE DITA. Come diceva Luciano Fabro oltre ai cinque sensi comuni (la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto, il gusto) c’è il senso aptico, ossia l’occhio che tocca le cose. Giorgio Agamben vede il nostro leggere i libri sugli schermi dei nostri dispositivi tecnologici come un ritorno al gesto dello scorrere il papiro egizio, dall’alto al basso, è un continuo andare su e giù, non c’è più l’atto dello sfogliare (il libro, da destra a sinistra). Il mio blog e le mie pagine Instagram io li vedo così. Mi piace l’immediatezza che c’è nel passaggio del pensiero a una quantità infinita di persone. Credo che questi mezzi debbano essere usati in modo più creativo e sentimentale, come se fossero delle lavagne infinite di appunti. Questi “spazi/luoghi” sono l’Altro per eccellenza. Quando pubblichi qualcosa questa diventa più fredda e oggettiva, nel lavoro come tu sai il distacco è importante.
È anche vero che Instagram è l’esasperazione dell’archiviazione schizofrenica, dipende sempre molto da come ci si serve di questi strumenti.
MZ: Nell’universo di immagini sempre in movimento o in evoluzione (ammettiamo che esista un immaginario collettivo attivo da millenni e a cui ogni individuo può sintonizzarsi per attingere qualcosa) probabilmente agisce in modo ultrasottile un informe evocativo, difficile da definire. Mi sembra che nei tuoi lavori tu intenda sempre suggerire una ricerca continua di un senso lá dove non dai mai un senso compiuto a priori. Cosa vuoi attingere o innescare nel vasto patrimonio immaginale?
MM: Tutti questi spunti di riflessione che mi suggerisci, sono tutte cose che io vivo molto a livello inconscio. Non è tutto così premeditato, è il gioco, anche se l’arte come dico sempre è un gioco serio. L’uomo nel suo DNA ha tutta la sua cultura, non solo le sue cellule.
“Io credo che si dovrebbero leggere soltanto quei libri che mordono e pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia come un pugno in testa, perché lo leggiamo allora?” (Franz Kafka). Mi sento molto più vicino agli artisti che fanno esperienza del mondo corporalmente, vedi Rainer Werner Fassbinder, Robert Mapplethorpe, Caravaggio, Pier Vittorio Tondelli, Maria Teresa di Calcutta, Franz Kafka, San Francesco, Pina Bausch, Francesca Woodman, Nan Goldin, Diane Arbus, Marina Abramovic e Ulay, Joseph Beuys, Valery Export, Chris Burden… è la differenza tra Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini. Ogni persona ha nel proprio nome il suo destino.
Penso anche alla trilogia di Pier Paolo Pasolini, che esplica il suo rapporto con il reale: da Petrolio, a Salò, alla sua morte, il suo destino era dentro il suo lavoro, che crea poi la sua tragica uccisione. Arte e vita si uniscono in un incubo finale.
Attingo dal vasto patrimonio immaginale, ma non credo nella velocità, uso elementi che sono in me da tanto tempo. Il nuovo è un budino. Sono cose sedimentate che poi escono come urgenze, l’arte è urgenza. Con il mio immaginario cerco di creare una seconda lingua, un gergo.
C’è un inconscio dell’opera e una sua intraducibilità, io non ragiono nell’ordine di questo vuol dire quello, è come per il sogno che ha delle componenti che anche Freud riteneva intraducibili. L’intraducibile è intraducibile. Nell’arte c’è sempre qualcosa che ti resiste. Bisogna tenere quella parte di enigma, oggi l’arte è troppo addomesticata, a volte lo è così tanto che finisce per poter essere scambiata per una bella vetrina, per moda, per del design fatto male, diventa un capriccio formale. Sono d’accordo con l’Arte torna arte diLuciano Fabro, che come forse sai è stato mio professore in Accademia.
L’arte è un pensiero stupendo (Patty Pravo)
MZ: Le tue opere che attivano il corpo performativo della collettività sono atmosfere da vivere ed esperire, temperature emotive da attraversare o cos’altro?
MM: Se quello che dici è vero io sono già contento, il paradiso è già in terra! La mia paura è che l’uomo contemporaneo, specialmente quello dell’arte, abbia perso l’attitudine all’abbandono. Ci si dovrebbe mettere un po’ di sogno e di sonno, accendere il cervello notturno e spegnere il diurno. Le cose che dico sono cose che ripeto sempre anche a me stesso. “Svuota la tua mente, sii senza forma, senza limiti, come l’acqua. Se metti dell’acqua in una tazza, l’acqua diventa tazza” insegna Bruce Lee ai suoi studenti – lo spettatore deve essere un bicchiere non troppo pieno, se no non può accogliere il tuo sapere. E i visitatori sono bicchieri troppo pieni.



MZ: Ci parleresti del rapporto tra lo sciame di sensi delle tue performance, la somma delle energie dei corpi partecipanti, la combinazione delle esperienze collettive e la casualità degli eventi?
MM: Fare un evento è la cosa più delicata che c’è perché è uno spazio aperto. Il pubblico è il mio corpo, in questo paesaggio che creo il pubblico è parte del lavoro… questo aspetto del mio lavoro credo che risuoni ancora più forte oggi nel momento storico che stiamo vivendo. Amo molto i documenti e sono anche queste delle opere, ma amo di più l’esperienza viva. Per vivere oggi serve sentire non solamente il visibile, ma anche l’invisibile. Il mio modo di lavorare cerca di rendere presente le assenze, e più sono urgenti e provenienti da un desiderio vero, più sono condivisibili dagli altri. Gli artisti sono identità condivisibili. L’arte è dimestichezza con l’invisibile. Banalmente pensa a quanti artisti lavorano e studiano di notte.
Le mie idee non coincidono mai con la formalizzazione del lavoro. C’è sempre uno slittamento inaspettato che rimette in discussione un po’ tutto. Non ho un metodo, il mio metodo è dimenticare a memoria. In ognuno di noi c’è, o ci sarà, un momento di profonda comprensione, ma non possiamo sapere quando sarà quel momento in cui l’opera ci si rivela. Per me oggi è il momento per Carmelo Bene, non sarebbe stato così dieci anni fa. Quel contatto con l’opera poi lo porti con te all’infinito.
Una grande parte dell’opera va immaginata, pensa alla mia performance Cicerone, che faceva parte della mostra Sbandata, la mia ultima personale in Galleria Raffaella Cortese: Roberto Carozzi, guida dell’oratorio Suardi, ha descritto al pubblico un affresco di Lorenzo Lotto come se si trovassero all’interno dell’oratorio. Con il suo racconto orale ha evocato un’immagine assente e invisibile, facendo vivere al pubblico un luogo e un’atmosfera che era in realtà lontano da loro. All’udire del suono di una parola ognuno di noi vede qualcosa di diverso (anche se poi anche guardando un tavolo ognuno lo vede a modo suo), non è mai una piatta tautologia.
MZ: Penso al progetto Viaggio in Italia (1984) di Luigi Ghirri e lo collego invece al gesto del bambino che in alcune tue performance ritaglia dai libri immagini che vanno a formare un suo inedito paesaggio, sia fotografico sia scultoreo. Come è evoluto il lavoro sul paesaggio nel tuo immaginario?
MM: Non c’è una fotografia di Luigi Ghirri che non mi colpisca, vorrei avere i suoi stessi tic visivi. Vorrei essere suo fratello, abbiamo lo stesso amore per la provincia. Mi sarebbe piaciuto fare un pique-nique con lui e mangiarci un bel panino col salame.
Avendo una tale sensibilità per l’immagine, il tagliare le montagne non è la stessa cosa che tagliare altro: è come se la carta fosse pietra, il peso dell’immagine è quello della pietra. È l’atto illimitato del tagliare che porta a costruire un paesaggio che cresce all’infinito e che muta incessantemente con il passaggio delle persone.
La mia performance è stata realizzata alla Triennale di Milano perché in fondo anche la natura è una forma di architettura.
MZ: Cosa significano per te, ora, la parola e la voce che la nomina?
MM: Siamo abitati delle immagini, ultimamente invece sono abitato dalla parola e dalla voce. Vedo le parole, vedo le voci. È una cosa che si è sviluppata molto nell’ultimo periodo, che però è profondamente radicata nel passato.
La scrittura è diventata una pratica quotidiana, le mie scritte sono come degli appunti. Per me la parola è oracolare, le frasi che poi annoto mi vengono quasi dette. La parola è proprio l’incontro con l’atro e viene dal dialogo con l’altro. Hanno la velocità dell’intuito e si muovono con la spinta della spontaneità. La scrittura le cattura, cattura la voce, che è un altro lato dell’invisibile e dell’immaterialità di cui parlavo prima.
Le frasi che amo scrivere non sono mai troppo lunghe, quando articoli troppo, la frase diventa troppo narrativa. I miei sono monologhi, che sono aristocratici.
Si è attraversati dalla parola. La parola è preghiera, adesso che non c’è più mia madre che pregava tutto il giorno, penso a quella stanza riempita di parole di preghiera… La voce è una sorta di virus, è invisibile.
Mi piace molto sentire la voce degli altri che con il suo timbro genera per me una visione.
Ogni lingua crea delle sotto-lingue, un gergo, come il volgare e l’italiano di Dante.
Il primo rapporto che l’artista visivo ha con parola è il titolo dell’opera. Per me parte dal titolo di un mio lavoro, La vertigine della signora Emilia. I titoli sono immagini assenti, come nel quadro di Magritte dove sul viso di una donna appare la scritta “montagne”, come se le avesse davanti agli occhi, ci fa vedere quello che non ci è visibile.
Io le parole le chiamo Martellate perché sono dirette e colpiscono proprio come delle martellate. Ho realizzato anche una pubblicazione con Flash Art, MARTELLATE (SCRITTI FIGHI 1990-2019).
Io penso ciecamente. C’è l’arte della moda, del design e così via, ma poi c’è l’Arte. Più si va avanti più diventa difficile stare su questo filo sottile di un rasoio affilato.