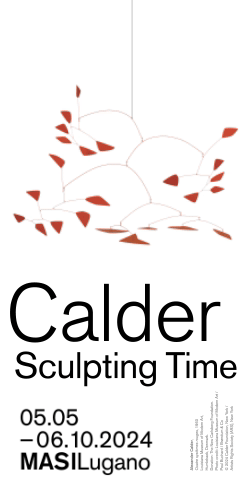L’odio e la discriminazione nei confronti della diversità, sia essa legata all’etnia o al genere, lasciano ferite profonde, talvolta insanabili. Reagire è difficile, ma l’arte può contribuire a catalizzare il dolore in energia, così da trasformarlo in un’arma di emancipazione. È questa la convinzione su cui si fonda la mostra invernale di Kunst Meran Merano Arte, il cui titolo è esso stesso una dichiarazione di intenti. TURNING PAIN INTO POWER (fino al 29 gennaio 2023), a cura di Judith Waldmann, raccoglie opere di 13 artist* che hanno dedicato il loro lavoro alla denuncia di ingiustizie sociali e politiche. I loro contributi puntano i riflettori su atteggiamenti e fenomeni sociali che portano all’emarginazione delle minoranze, offrono strumenti di difesa dalle efferatezze della società patriarcale bianca e raccontano storie drammatiche di vittime di razzismo e violenza di genere, così che possano essere ricordate e celebrate. Apre il percorso espositivo il motto “I won’t shut up”, stampato a caratteri cubitali su una serigrafia (I won’t, 2021) di Monica Bonvicini (Venezia, 1965), una dichiarazione universale di militanza a difesa della libertà di espressione e, allo stesso tempo, un invito per i visitatori a non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie, dato che “aprire la bocca” è sia un diritto che un dovere. Il sollecito è avvalorato da sei disegni a penna su carta di Giuseppe Stampone (Francia, 1974), raffiguranti altrettante figure iconiche della storia contemporanea in atto di alzare i pugni chiusi al cielo. Tra questi, l’atleta afroamericano Tommie Smith, famoso per il gesto compiuto alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 a sostegno del “Black Power”, e Agnese De Donato, pioniera del femminismo in Italia. Il primo ambiente è occupato da più opere di Silvia Giambrone (Agrigento, 1981). Subito si incontra la video-documentazione della performance Traum (2021), che mostra l’artista mentre legge da un foglio di ceramica frasi di dolore, che evocano traumi reconditi subiti nella sfera domestica. Terminata la lettura, il foglio cade a terra e si frantuma in mille pezzi; una deflagrazione di cui si percepisce distintamente l’onda d’urto emotiva e che rappresenta la riemersione di quei ricordi, finalmente sbloccati e processati. In teca è presente un foglio di ceramica privo di testo, che viene idealmente lasciato a disposizione dei visitatori per compiere lo stesso processo catartico. Più avanti seguono alcuni lavori della serie Security blanket (2022): il termine viene utilizzato per riferirsi alle coperte pensate per far sentire i bambini al sicuro, ma su questi tessuti imbottiti sono state ricamate delle frasi tratte da un manuale che dà consigli alle donne su come comportarsi qualora si trovino in pericolo di stupro. Colpisce il contrasto tra le raffigurazioni fiabesche dei ricami e le scritte che invitano ad usare il contenuto delle proprie borse come armi anti-molestie, dalle limette, alle chiavi, alle penne a sfera.


La sala successiva si apre, sulla sinistra, con un poster di Cana Bilir-Meier (Germania, 1986) che riporta la poesia Mein Name is Ausländer, Benim Adım Yabancı (“Il mio nome è straniero”, 1981) della zia Semra Ertan, una lavoratrice e poetessa turca immigrata in Germania per guadagnarsi da vivere che, provata dal razzismo che era costretta a subire, decise di togliersi la vita dandosi fuoco in un mercato ad Amburgo. La famiglia ha raccolto la sua eredità, mediata dalla sua potente scrittura. Le altre pareti sono occupate da lavori di Adrian Piper (Stati Uniti, 1948), artista afroamericana trasferitasi dagli Stati Uniti a Berlino nel 2005 per sottrarsi alla discriminazione di cui era oggetto nel suo Paese di origine, come racconta nel libro Escape to Berlin (2018); il video Adrian moves to Berlin (2007) esprime tutta la gioia di essersi liberata da una condizione di oppressione. Come i Security blanket di Silvia Giambrone, anche My calling (card) #1 e #2 (1986) di Adrian Piper si offrono come strumenti pragmatici per fronteggiare situazioni non desiderate. “Calling card” significa “biglietto da visita”, ma il titolo allude anche all’espressione “to call someone out”, cioè “affrontare qualcuno”. Le due tipologie di biglietti, che i visitatori e le visitatrici sono invitati a prendere con sé, contengono risposte adatte ad affrontare rispettivamente avances indesiderate da parte di sconosciuti e una situazione in cui ci si senta attaccati per il colore della propria pelle. In questo modo la semplice consegna del biglietto permette di non doversi impegnare ogni volta in faticosi tentativi di farsi rispettare. Chiunque è invitato a scrivere il proprio biglietto e ad inserirlo all’interno di un album, così da offrire ulteriori strumenti di difesa ai visitatori successivi. Sulla parete opposta si trova un’opera più spirituale, che incarna il tema della trasformazione del dolore in potere. Mokshamudra Progression (2012) è composta da una serie di fotografie di una mano chiusa a pugno che progressivamente allenta la tensione e si apre in un gesto liberatorio. In molte filosofie orientali il “moksha” corrisponde al processo di affrancamento dai vincoli e dagli affanni dell’esistenza terrena finalizzato a raggiungere una condizione spirituale superiore, mentre i “mudra” sono gesti simbolici utilizzati come complemento delle pratiche religiose per canalizzare l’energia a scopi benefici. Sotto alle fotografie una freccia mette in correlazione le due estremità della serie, che presentano due elenchi contrapposti di concetti. La progressiva apertura della mano, che sembra sbocciare come un fiore, rappresenta il passaggio da “stasi”, “condensazione” e “possesso” a “dispersione”, “evaporazione” e “rinuncia”. La catarsi è compiuta.


Seguono due opere video. L’Arbre d’Oublier (Arvore do Esquecimento) (2013) di Paulo Nazareth (Brasile, 1977) allude ad un rituale voodoo che era imposto agli schiavi africani raccolti presso la città costiera di Ouidah in Benin, prima di partire per le Americhe. Ognuno di loro veniva costretto a girare un certo numero di volte attorno all’Albero dell’oblio, per indurlo a dimenticare le proprie origini; una volta privati della propria identità, gli schiavi avrebbero opposto minore resistenza all’emigrazione forzata. Nazareth concepisce un contro-rituale e si filma mentre gira attorno all’albero, in senso contrario, fino allo sfinimento. Il suo gesto cerca di ripristinare simbolicamente quante più identità possibili, ma non può cambiare la Storia. Hammering Out (an old argument) (1998-2003) di Monica Bonvicini mostra un’altra prova di resistenza: un braccio femminile prende a martellate un muro fino a mettere a nudo i mattoni sotto l’intonaco. L’azione fa riflettere su quanta energia sia necessaria per demolire le convenzioni e le opinioni fossilizzate nella società, allo scopo di far emergere nuove narrazioni. Salendo al piano superiore, si incontrano alcune opere di Regina José Galindo (Guatemala, 1974), incentrate sul tema della violenza contro le donne. Il video El dolor en un pañuelo (1999) documenta una performance compiuta in una galleria di Mexico City. L’artista, completamente nuda, è legata ad un letto alzato in verticale, in una sorta di crocifissione; sul suo corpo sono proiettate pagine di giornale su cui si leggono notizie di femminicidi compiuti nel suo Paese. Il corpo dell’artista, come quello di Cristo nella Passione, si fa carico del dolore di tutte le donne del Guatemala, paese in cui il problema della violenza domestica ha raggiunto la soglia critica. Altre fotografie documentano una performance a Berlino, Monumento a las desaparecidas (2020), in cui ventotto donne totalmente coperte da un velo nero stanno in piedi immobili in un parco. Cala la sera e i loro corpi progressivamente scompaiono nel buio. Il lavoro allude al fatto che in Guatemala ogni settimana ventotto donne scompaiono senza lasciare traccia. Sui muri attigui campeggiano a caratteri cubitali due dichiarazioni di Puppies Puppies (pseudonimo di Jade Guanaro Kuriki-Olivo, Easter Island, 1989), tramite cui l’artista denuncia il fatto che da sempre la società cerca di cancellare dalla Storia l’identità e l’esistenza delle persone transessuali, Gender-Non-Conforming e Two spirit + (espressione usata nelle comunità nativo-americane per riferirsi a quegli individui che si identificano nell’avere uno spirito sia maschile che femminile).



Successivamente sono presentati i risultati di un lungo lavoro condotto da Giulia Iacolutti (Cattolica, 1985) in un carcere maschile di Città del Messico. Casa Azul (2017-19) restituisce il ritratto di cinque donne trans detenute in quella struttura e perciò costrette a indossare abiti maschili e ad interrompere le terapie ormonali. Alle pareti sono appese delle cianotipie che mostrano i volti delle donne e gli oggetti che rappresentano la loro identità femminile: la tonalità blu imposta alle immagini dalla tecnica impiegata allude al colore degli abiti di detenzione, ma diventa anche il simbolo di un’altra prigione, quella del proprio corpo. Il percorso prosegue con un nutrito gruppo di lavori di Philipp Gufler (Germania, 1989), la cui pratica artistica si avvale dell’ausilio del Forum Queeres Archiv München, dedicato alla storia e alla cultura queer in Germania. Kostüm Kakaduarchiv (2022) è una tunica indossabile dall’artista per condurre delle performance, decorata al centro da un grande triangolo rosa. Il “Rosa Winkel” veniva utilizzato nei campi di concentramento per marchiare le persone omosessuali, ma nella Germania postbellica è stato riscattato dalla comunità LGBTQ+ come bandiera contro l’omofobia, oltre che come monito delle atrocità compiute dai nazisti. In Lana Kaiser (2020) Gufler traccia un ritratto commosso dell’omonima cantante pop transgender nata come Daniel Küblböck, che ebbe il periodo di massima risonanza mediatica intorno agli anni 2000-2010. Il video porta alla luce e celebra il suo lato più autentico, montando in sequenza spezzoni di concerti e di apparizioni in TV, da cui traspare tutto il dolore di essere duramente contestata per la sua identità di genere. L’opera è un omaggio postumo, perché Lana Kaiser si suicidò nel 2018 gettandosi nel Mare del Labrador da una nave da crociera. La sezione finale del percorso, ormai giunto all’ultimo piano della sede espositiva, ospita opere poetiche che paiono levitare nella luce del lucernario e delle vetrate che danno sulla terrazza. Tre specchi dai colori cangianti (2022) sono l’esito dei tentativi di Gufler di trovare un’alternativa alla bandiera LGBTQ+, così da dare spazio allo spettro di identità queer che non si sentono adeguatamente rappresentate da essa. I baluginii di luce sulle superfici riflettenti accendono i colori di sfumature sempre diverse. Più avanti, in disparte, un altro specchio si bagna di sole. Si tratta di Everything #4 (2004) di Adrian Piper, oggetto che fa parte di una serie di opere di diversa natura accomunate dalla presenza della frase “Everything will be taken away”. L’affermazione suona ambivalentemente come un monito e come una rassicurazione: nel bene e nel male tutto è transitorio. Il volto riflesso sullo specchio invecchierà, ma alla fine svanirà anche il dolore. Al termine del percorso un codice QR dà accesso al soundpiece Sucking that Orange (2022) di Rosalyn D’Mello (India, 1985), scrittrice e critica d’arte indiana, ma emigrata in Alto Adige, che parla in modo molto personale della propria esperienza di visita alla mostra. In omaggio al lavoro di Paulo Nazareth, il racconto procede a ritroso dall’evanescenza dello specchio di Adrian Piper fino alla dichiarazione programmatica di Monica Bonvicini: perché, dopotutto, “ciò che puoi fare quando tutto ti è stato portato via è avviare la ricostruzione a partire dalle macerie; in quell’atto di ricostruzione, il dolore si trasforma in potere”. Il potere di far sentire la propria voce.