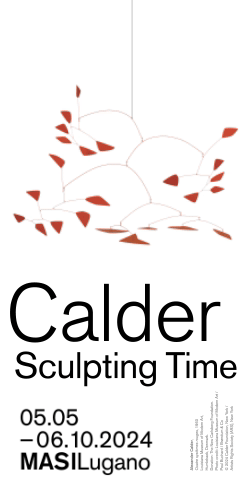Il Parco Arte Vivente di Torino ospita Ecologies of Loss, la prima personale italiana dell’artista indiano Ravi Agarwal, fotografo, attivista ambientale, scrittore e curatore.
La mostra, curata da Marco Scotini, porta avanti l’interesse per le pratiche artistiche d’origine asiatica fortemente connesse a un pensiero ecologico, già inaugurato con la mostra dell’artista cinese Zheng Bo Weed Party III.
Ho incontrato Ravi Agarwal per parlare della sua ricerca che, sebbene abbia visto la fotografia come mezzo d’elezione, prende diverse forme, dal video, all’installazione, agli interventi di arte pubblica, alla redazione di testi.
Mariacarla Molè: Partirei dal titolo Ecologies of Loss, mi colpisce che ecologies sia al plurale e, quanto al loss, vorrei chiederti cosa sia andato perduto, e cosa segue a questa perdita.
Ravi Agarwal: Parlo di ecologie perché credo sia importante ricercare e proporre molteplici punti di vista sul modo di concepire la Terra, per modificare il nostro concetto di natura e il modo in cui ci relazioniamo a essa. Quanto alla perdita mi riferisco agli esiti disastrosi che hanno sull’ambiente processi industriali ed economici che non tengono conto delle forme di vita non-umane, mettendone in pericolo l’esistenza stessa.
È il caso della popolazione di avvoltoi che contava dieci milioni di esemplari nel sud dell’Asia, ora quasi del tutto scomparsa a causa della messa in commercio di un farmaco analgesico usato negli allevamenti di bestiame che, restando nelle carcasse degli animali, finisce per avvelenare gli avvoltoi che se ne nutrono. Extint (2008), la foto di grande formato che ho installato all’esterno del Pav, ne ritrae alcuni esemplari; è il mio modo di ricordare la loro scomparsa e per restituirgli lo spazio di cui sono stati privati. Un’altra storia di perdita è quella legata alla coltura dei garofani, cui ho dedicato Have You Seen The Flower on the River (2007), un lavoro composto da una serie di stampe, un video, un’installazione e una pubblicazione. È una coltura assai diffusa in India, perché è molto sostenibile e redditizia, ma sta rischiando di scomparire a causa dell’interesse, da parte del mercato, di acquisire terreni più fertili, in seguito all’espansione della città e alla costruzione del Commonwealth Games Village. La fertilità del capitale sta avendo la meglio sulla fertilità della terra, rischiando di spazzare via una tradizione antichissima.
Queste forme di estinzione sono state all’origine delle mie riflessioni, e credo si debba partire dalla perdita alla ricerca di pratiche che tengano conto delle forme di vita non-umana, e mettano in discussione il nostro modo di relazionarci all’ambiente.


M.M. La serie fotografica Alien Waters (2004-2006) racconta le tue esplorazioni delle rive del Yamuna, il fiume che attraversa Delhi, luogo che ha accolto le fasce più povere spinte sempre più ai margini della città da una violenta opera di gentrificazione, legata all’organizzazione dei Giochi del Commonwealth del 2010. Le carcasse di oggetti ridotti a rifiuti che hanno dimenticato la loro funzione e, al contrario, la riconfigurazione dei rifiuti in oggetti di uso comune, mi fanno venire in mente le atmosfere desolate di The Waste Land di T.S.Eliot, tuttavia il tuo sguardo sulle ‘rovine’ intorno al fiume sembra privo di un sentimento crepuscolare.
R.A. Si, è un paesaggio fatto di rovine, ma ad esse attribuisco una grande carica positiva, essendo delle preziose fonti di narrazioni, su chi le abita e sul paesaggio. Con i miei lavori ho voluto reimmaginare la narrazione dominante legata al fiume come luogo sporco e inquinato, per renderlo di nuovo bello e accessibile a tutti: un ecosistema vivo.Sono moto legato al fiume Yamuna, da piccolo andavo lì a nuotare, è un luogo che mi attrae molto.
Il mio lavoro è nato così, da una forte attrazione per questo luogo, che mi ha spinto a tornare e ritornare in quei due anni, a parlare con chi lo abita, e solo in un secondo momento è diventata la documentazione di un processo in atto. Molti miei lavori sono mossi da una forte attrazione iniziale verso un oggetto, verso un passaggio, verso la storia di una comunità, e solo in un secondo momento diventano documenti e assumono un altro significato.
M.M. Da sempre la fotografia è stata per te la forma più immediata per comunicare il tuo punto di vista, la più istintiva. Ma i testi hanno presto iniziato a nutrirla, accompagnarla e ispirarla. Mi racconti che importanza ha la scrittura nella tua pratica? In mostra troviamo molti dei diari relativi ai tuoi progetti. L’uso che fai della scrittura libera, dell’annotazione di pensieri estemporanei mi ricorda l’approccio del femminismo degli anni settanta alla scrittura intesa come strumento di presa di consapevolezza.
R.A. Lo spazio della scrittura è per me qualcosa di più di uno spazio fisico che permetta di mappare il corso di un progetto, è uno spazio politico e culturale in cui prendere atto di un cambiamento; è sicuramente uno spazio riflessione. Il diario mi permette di raccontare cosa è accaduto a un paesaggio, ma anche di andare oltre, in maniera più introspettiva, di farmi accedere ad altri livelli di riflessione. I diari non sono da intendersi come restituzioni dei miei lavori, non li documentano, non vengono dopo, ma insieme ad essi, li costeggiano in un certo senso.
Da sempre prendo appunti che diventano poi parte del lavoro.
Così come le foto non sono semplici documenti visivi, ma elementi che insieme ad
altri linguaggi danno corpo alla mia pratica. Perché l’arte visiva non può
esaurirsi nei mezzi visivi, esistono talmente tanti linguaggi che, di volta in
volta, mi piace trovare il più congeniale a uno specifico progetto.


M.M. Mi incuriosisce il modo in cui si definisce la tua pratica artistica e di attivista come una forma di ‘personal ecology’. In un’intervista ad Amitav Gosh apparsa su Il Manifesto lo scrittore e attivista sottolineava la natura illusoria dell’idea di affrontare i cambiamenti climatici a partire da un livello individuale, un approccio che sarebbe figlio dell’egemonia della cultura neoliberista. Un atteggiamento miope che occulta un fattore decisivo, ovvero la straordinaria efficacia e l’importanza decisiva dell’azione collettiva. Gosh rintraccia nella possibilità di immaginare una collettività umana l’unica risorsa per combattere i cambiamenti climatici. Mi chiedo come questa concezione si sposi con l’idea di ‘personal ecology’.
R.A. Sono d’accordo con Gosh, lo trovo uno scrittore formidabile, ma credo dipenda da cosa si intende per individuo; bisogna attuare un processo di rinegoziazione del sé, del suo concetto. Per me l’individuo è sempre inserito in un contesto da cui non può essere dissociato, è una presenza etica, mai chiuso nella sua singolarità, ma sempre inserito in una comunità. L’individuo non è un essere isolato, ma vive insieme ad altri esseri, umani e non-umani. Al centro della ‘personal ecology’ c’è un individuo che include al suo interno il modo lì fuori, la comunità, i non-umani, gli uccelli… È un’idea estesa di sé, che permette di costruire una nuova concezione del mondo, fuori dal pensiero tecnologico e finalmente più sostenibile. Si parla di energie rinnovabili, di responsabilità dei singoli ma non è sufficiente, bisogna ridefinire in nostro concetto di mondo e di noi stessi, formulare nuove categorie di sé e di natura.
M.M. Quello che proponi è quindi un abbandono del concetto di natura, di matrice occidentale, che si rivela essere un’invenzione, un’astrazione, una forma simbolica. Qual è l’alternativa?
R.A. Ho passato del tempo nel sud dell’India in un villaggio di pescatori. A loro ho chiesto come concepissero il mare e cosa rappresentasse nelle loro vite. Nelle parole che hanno usato, che sono le stesse che ho mostrato nei cartelli piantati nella spiaggia nella stampa fotografica Rhizome (2015), ho trovato dei riferimenti molto fisici, legati alle loro interazioni materiali col mare, al modo in cui la loro esistenza dipende da esso. Non ho trovato alcuna astrazione e nessun riferimento alla sua bellezza né a una dimensione vagamente contemplativa.
In questo senso trovo altrettanto prezioso il linguaggio usato nella letteratura Sangam; ne ho inserito un corpo di poesie in Sangam Dialogue (2017), dove una voce che ne legge alcuni estratti accompagna un fermo immagine su un paesaggio. Anche qui nessuna astrazione, nessuna metafora, nessuna costruzione umana. L’astrazione della natura è pericolosa, e trovo che bisogna piuttosto tornare a farne parte, evadere le categorie generate da isolamenti posticci, andare oltre i piccoli orizzonti di senso che ci rendono miopi. Quello che mi auguro è una natura che faccia parte della nostra esistente, una natura che sia rete di relazioni, non solo apprezzata ma agita. So che sto immaginando un cambio di immaginario enorme ma forse questo momento di grande crisi è quello giusto per tentare questa rivoluzione cosmica.