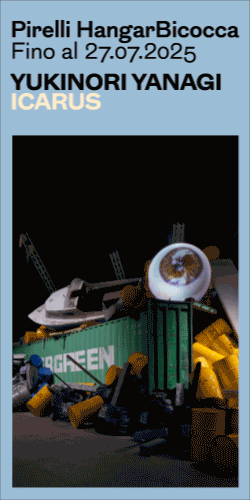La mostra collettiva Performativity, a cura di Denis Isaia e Sara Enrico, che ha inaugurato il 21 giugno a Centrale Fies, Dro, Trento, visitabile gratuitamente fino al 27 luglio (qui le info: centralefies.it/ipernatural), si inserisce nel programma estivo di Centrale Fies art work space, anticipando l’evento site specific Orestea / fin dentro la sera fin dentro la notte di Anagoor del 30 giugno: la mostra raccoglie una serie di artisti le cui ricerche hanno una vocazione performativa e cerca di indagare i rapporti tra performance e oggetto artistico, tra arte visuale e performatività. Si tratta della prima mostra di una trilogia di progetti espositivi che indagherà le nozioni di performabilità e performanza.
«Alle fonti del progetto Performativity – spiegano i curatori – c’è l’assunto che l’azione performativa, sia essa un atto volontario pubblico o privato, è uno dei principali strumenti per la generazione e l’affermazione di senso, le cui verità sono organizzate attraverso forme e linguaggi. Nel percorso espositivo il livello di complicità fra gli oggetti e la performance è variabile, a volte rimanda a un’azione precedente, altre volte è raccolto nel processo, altre evoca una coreografia latente o precisa l’oggetto della riflessione.»
Questi sono gli artisti in mostra: Marion Baruch (Timisoara, Romania, 1929), Une chambre vide, 2019; Alessandro Di Pietro (Messina, 1987), Shelley, 2019; Sara Enrico (Biella, 1979), Untitled (Jacquard), 2013; Philipp Gehmacher (Salisburgo, 1975), Untitled, (London), 2017; Francesco Gennari (Fano, 1973), Autoritratto su menta (con camicia bianca), 2011; Esther Kläs (Mainz, Germania, 1981), Introvert Girare con te #02, 2017; Andrea Kvas (Trieste,1986), Senza titolo, 2014; Nicola Martini (Firenze, 1984), Testimone, 2019 Courtesy DITTRICH & SCHLECHTRIEM, Berlino e Testimone, 2019 Courtesy l’artista; Tania Pérez Córdova (Città del Messico, 1979), Human, Nonhuman, Human, 2017; Alessandra Spranzi (Milano, 1962), Due fogli nel nero (Selvatico o colui che si salva), 2008; Davide Stucchi (Vimercate, 1988), V135, 2014, Naso (Pisello) I, 2017 e V Naso (Pisello) II, 2017; Franz Erhard Walther (Fulda, Germania, 1939), SchluBstein 1986.

Atpdiary rivolge alcune domande sulla mostra ai curatori.
Mi piacerebbe, Denis, che approfondissi le fonti storiche che hanno dato il via al progetto di Performativity: che pensieri hanno sviluppato, nella tua riflessione critica, le pratiche artistiche dei vitali anni ‘50, ’60 e ’70? Il gesto di Fontana, quelli di Vedova, l’uso della fiamma ossidrica di Burri, l’uso delle modelle da parte di Klein o l’uso dell’impronta digitale di Manzoni come firma, come si connettono ai comportamenti, ai gesti e alla performatività degli artisti di oggi?
Come noto dopo il 1945 assistiamo a una rivoluzione dei linguaggi artistici. Le coordinate spaziali astratte – la cornice e il piedistallo – vengono abbandonate a favore di un interscambio con la vita e con il mondo. Da questo punto di vista, la performance storica, quella che attribuiamo solitamente alle madrine e ai padrini della disciplina come Yoko Ono, Vito Acconci, Gilbert & George, Chris Burden, Marina Abramović, è solo la punta dell’iceberg di un rivolgimento formale e poetico evidentemente più ampio, che, fra l’altro, non ha rinunciato all’oggetto. A questo punto andrebbero fatti dei distinguo, ma ciò che pare evidente è come la necessità storica e mercantile di avere fra le mani un oggetto abbia portato a uno squilibrio nei rapporti fra l’azione e la sua documentazione, tanto da non comprendere chi sia sussidiario a chi, se la documentazione all’azione, come la logica suggerisce o viceversa. Allo stesso tempo alcune derive date dalla perdita delle coordinate spaziali tradizionali hanno portato a una spettacolarizzazione delle arti che oggi spesso pare condurre a dei vicoli ciechi. Non è un caso che Harald Szeemann sia stato protagonista sia di Live in Your Head: When Attitudes Become Form. Works – Concepts – Processes – Situations – Informations – la mostra che meglio ha raccontato l’irrompere del processo e del comportamento – che di Platea dell’Umanità – Pleateau of Humankind – Plateau der Menschheit – Plateau de l’Humanité, la Biennale veneziana del 2001 che con la precedente dAPPERTutto suggellano il monumentalismo artistico ad uso e consumo di un evento. Queste considerazioni ci hanno permesso di osservare alcuni artisti a noi più vicini, la cui opera evoca o è generata da un gesto di tipo performativo. Per capire l’accento con cui abbiamo attraversato la questione è utile partire dal lavoro di Franz Erhald Walter che oltre a segnare materialmente il punto di avvio storico della mostra, diviene perno di uno dei principali motivi che la attraversa. Walter usando il tessuto per fare scultura ha reso la plastica scultorea, tradizionalmente fissa, continuamente plasmabile, in un certo senso ne ha dilatato nel tempo la plasiticità. Le sue opere, anche quando non sono attivate dal pubblico o dall’artista e sono quindi in fase di stasi, rimandano alla presenza viva di un corpo, c’è in esse sempre un corpo, seppur in stato di latenza. Walter, come dicevo, ha per noi aperto lo sguardo su quello che potremmo definire il “tissutale”, un argomento presente da molto tempo anche nel lavoro di Sara Enrico e su cui molto Sara ha lavorato. Il “tissutale” è una membrana che permette ai lavori di operare degli sconfinamenti e repentini rientri nei ranghi. L’opera è certo statica, ma è attraversata da un’energia che la muove o pare scuoterne l’anima.

Spiegami quest’idea di «porosità» della performance intesa come «nutriente poetico e formale per gli artisti visivi»: perché è così vitale la carica performativa nell’arte visiva contemporanea e cosa interessa a te di questo specifico linguaggio?
Entriamo in un campo minato. Un po‘ perché il termine «porosità» che io stesso ho usato è nel suo momento magico e pare buono a giustificare ogni scelta, un po‘ perché per risponderti mi piacerebbe avventurarmi in una questione d‘ordine sociologico che poco maneggio. Limitandomi ad alcune evidenze credo di non sbagliare se affermo che dopo anni di oblio, la performance vive una nuova giovinezza pari a quella degli anni ‘70 e spesso con finalità emancipative, pur affrontando tematiche differenti. Il lavoro che sta facendo Fies negli ultimi anni sulla performance è importante poiché mappa alcune fra le emersioni più interessanti mostrando come l’interesse degli artisti per la performance tout court, e non parlo di quella artistica, ma di quella con cui quotidianamente facciamo i conti. Forse potremmo a questo proposito parlare di “performizzazione” della vita cercando così di evidenziare il primato del tempo sullo spazio (i social media ne sono la migliore rappresentazione) nonché l’esaltazione del primato in sé.
Da un punto di vista più strettamente formale l’idea che ci siamo fatti è che la performance e le sue declinazioni più sfumate, come quelle in mostra, sia ancora un terreno poeticamente e linguisticamente fertile con cui gli artisti amano confrontarsi anche perché si tratta di un campo allargato e diversamente declinabile. Se ciò mette a rischio la precisione stessa della mostra Performativity, le permette di non essere una definizione stagna, ma una raccolta non esaustiva di esempi con cui alcuni fra gli artisti che ci piacciono decidono di attraversare l’arte e il proprio tempo.

Mi parli, Sara, del concetto di «state of distraction» teorizzato da Walter Benjamin che ti è tornato alla mente quando Denis ti ha proposto di pensare insieme la mostra?
Quando Denis mi ha parlato di alcune riflessioni che stava facendo sulla performatività, coinvolgendomi poi nel progetto, ho iniziato ad immaginare, quasi subito, di percorrere uno spazio, facendo incontri con delle opere che sarebbero state ideali in questo senso: forme la cui presenza non si limitasse al dato materiale ma manifestasse quel tanto di vitale in esse contenuto, seppur in maniera latente, nascosta, talvolta difficile da afferrare nella sua interezza. Queste presenze vitali, che venivano in superficie e man mano si mostravano, erano come fantasmi, apparizioni che si accendevano al mio passaggio per svelarmi quella sostanza invisibile ma fruttifera che poteva rendere questi oggetti significativi, ognuno a modo suo. Quasi fossi uno spettatore privilegiato che passando distrattamente, ma grazie a una facoltà piovutami da chissà dove, potessi vederne l’anima e la storia che ha dato loro origine.
Nell’inseguire questa fantasia, del muoversi distrattamente nello spazio, mi è poi tornato in mente quel passaggio di Walter Benjamin(1): lui parlava di ‘state of distraction’ riferendosi alla modalità con cui si guarda spesso l’architettura, o più in generale quegli spazi a noi familiari. Ci muoviamo senza prestar loro troppa attenzione, attraversandoli quasi con un’inerzia meccanica o inconscia, perché contengono un insieme di informazioni che conosciamo o riconosciamo come vicine. E ci si destreggia allora entro questi campi secondo automatismi, quegli ‘stati di distrazione’ di cui diceva Benjamin. La ridefinizione di una sostanza e vicinanza tattile, comportamentale, in divenire e vivace, al cospetto della dimensione puramente visuale e contemplativa, porterebbe questi ‘stati di distrazione’ ad un livello di significazione forte. Questi assumerebbero una forma di conoscenza nella quale l’aspetto visivo non si esaurirebbe in se stesso ma comprenderebbe diversi livelli di esperienza. Abbiamo costruito un racconto fatto di opere che a gradi diversi pongono in luce questa indole legata alla performatività di un’opera visiva, che forse potremmo dire essere molto vicina a questa idea di vitalità. Nel contesto corale della mostra, dall’orizzonte non necessariamente e volutamente rigoroso, troviamo rispecchiamenti, vicinanze, attriti, spostamenti di senso: le narrazioni nascono e si attivano dalle superfici, e dalle forme, dalla relazione tra i materiali e dalla memoria della genesi stessa dei lavori, dal loro posizionamento nello spazio. Alcuni lavori si mostrano, altri si presentano parlando per assenza, alcuni si impongono, altri ancora si spostano, rimangono più silenziosi. Sono ‘personaggi’ di una messa in scena, nella quale si concatenano temperamenti diversi, come una raccolta di ghost stories.
(1) La riflessione del critico tedesco è contenuta e proposta nel testo di Robert McCarter, The space within. Interior Experience as the origin of architecture, London, Reaktion Books, 2016, p. 30.
PERFORMATIVITY A CENTRALE FIES
a cura di Denis Isaia e Sara Enrico
21 giugno – 27 luglio 2019
Centrale Fies art work space, Dro, Trento