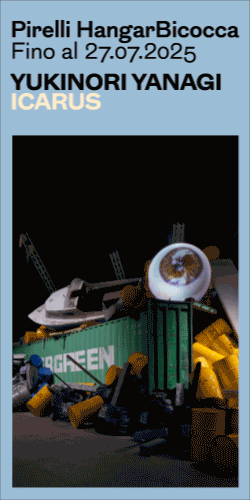“Un petit-tour in una stanza”; è con queste poche parole che Giulio Paolini (Genova, 1940) restituisce l’essenza della sua settima mostra personale alla Galleria Studio G7 di Bologna, dal titolo Un posto vuoto (fino al 4 gennaio 2025). I lavori esposti, in parte inediti, intendono evocare nel cubo bianco della galleria l’intimità dello studio dell’artista, ipocentro di una galassia di echi e memorie di altri autori che hanno nutrito il suo vocabolario concettuale, creando un prisma di traiettorie divergenti che scardina l’ortogonalità dello spazio verso altre possibilità immaginative. Fulcro nevralgico della mostra èUltimo modello, un lavoro del 1992 qui ripreso e modificato nella forma di un assemblaggio prismatico di strutture in plexiglass, un cubo quadripartito da due muri divisori interni, anch’essi trasparenti. La struttura, posta al centro della sala, richiama idealmente lo studio stesso dell’artista, ma è in parallelo anche una sorta di stanza della memoria all’interno della quale sono incastonati dei frammenti di fotografie: la materializzazione del serbatoio di immagini a cui l’artista attinge nella sua pratica, reso opera a sé stante, così che il cubo trasparente che lo delimita assume il valore di una teca di museo. Attorno a questa teca si dispongono quattro presenze tra loro simmetriche, in contemplazione: dei calchi in gesso identici del busto di Efebo, emblema della più pura bellezza classica (Efebo, 2024). In un ideale moto di rivoluzione attorno al centro di gravità rappresentato dalla teca e dai suoi spettatori si pone sulla diagonale della stanza una riproduzione fotografica dell’Estasi di San Sebastiano (1490-95) di Lorenzo Costa, posta di sbieco su un passe-partout bianco e circondata da una cornice dorata circolare. A supporto dell’allegoria cosmica, l’immagine del santo è posta su un piccolo contenitore di plexiglass, che contiene a sua volta la fotografia di una nebulosa; è a quella elevazione cosmica che aspira con la propria sofferenza, indotta da una matita nera che lo trafigge, e che al contempo pare l’asse di rotazione di questo satellite (Estasi di San Sebastiano, 2024).



Sul lato opposto della diagonale, un calco in gesso della Ebe (1796) di Antonio Canova si è rivolta verso l’angolo della stanza, dopo essere emersa dal deposito-crogiolo di immagini archetipiche. La dea Ebe, figlia di Zeus e di Era, è vestita di un lungo drappo su cui campeggia un cielo solcato da nuvole, su cui sono posati una pietra di ametista e una genesa crystal (una sfera vuota composta da anelli intersecati tra loro, antica geometria spirituale). Secondo l’artista, la dea “fugge e si sottrae al nostro sguardo: anche il cielo che la sovrasta sembra avvolgere il suo corpo e dar luogo a un’imminente e vertiginosa sparizione”; prossima al muro perimetrale di questo sistema stellare isolato, in perfetta corrispondenza con il San Sebastiano presente sul lato opposto, è prossima alla trascendenza verso un Altrove ineffabile, che non le si è ancora manifestato. Si squaderna invece in due collage appesi alle pareti, che condividono lo sfondo di una veduta prospettica di architetture stilizzate convergenti verso un punto di fuga centrale: finestre aperte sull’Ordine che sottende la realtà. Nella prima opera, una statua classica inquadrata di spalle si scherma il volto, sopraffatta dalla visione di quell’Altrove, verso cui si sporge dal promontorio ultimo della dimensione terrena, come alluso dal titolo Finis Terrae (2023). Infine, in Un posto vuoto (2024), in corrispondenza di un altro accesso verso quella dimensione altra, ecco una poltrona vacante; dal suo studio, crocevia dell’immaginario collettivo, l’artista ha varcato la soglia di una più compiuta consapevolezza.