
Gli archivi storici, con il loro patrimonio sopito di fotografie e documenti, sono la scenografia in cui si ambienta la ricerca artistica di Giulia Andreani (Mestre, 1985), che da tali coacervi di informazioni relative a figure e contesti dimenticati estrae con uno sguardo femminista storie significanti, per poi reinterpretarle in pittura attraverso gli strumenti compositivi del ritaglio e del montaggio. Seguendo questo iter ben collaudato, l’artista ha concepito un progetto espositivo per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia a partire dall’interazione con alcuni archivi della città. L’improduttiva (aperta fino al 10 marzo 2024), sua prima personale in Italia, presenta al pubblico un nuovo corpus di lavori ad acrilico ed acquerello, tutti datati al 2023, che rappresentano per l’artista un importante punto di arrivo di oltre dieci anni di lavoro, da quando ha cominciato a dipingere a Parigi, dopo la formazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia e poi alla Sorbona. Per l’occasione sarà prodotto un volume con testi critici della curatrice della Pinacoteca Agnelli di Torino Lucrezia Calabrò Visconti e del filosofo Emanuele Coccia. Per le fasi di ricerca preliminari Giulia Andreani si è dedicata allo studio della storia di Reggio Emilia, con una particolare attenzione alla comprensione di contesti e dinamiche legati al genere femminile. Ciò ha permesso di gettare nuova luce su figure e vicende più o meno note del passato recente della città: i fondi della Biblioteca Panizzi e dell’Istoreco (Istituto per lo Studio della Resistenza e della Società Contemporanea) hanno offerto la possibilità di avvicinarsi agli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, mentre tramite la Biblioteca Scientifica Carlo Livi e un ulteriore archivio privato è stato posto un focus sulle storie delle numerose donne che fino agli anni Settanta sono state internate nell’ospedale psichiatrico di San Lazzaro.

La prima sala è dominata dalla grande tela di formato orizzontale dal titolo La traghettatrice, una summa tersa e monumentale delle ricerche svolte, dato che i suoi personaggi sono prelevati da fotografie provenienti da tutti gli archivi consultati, per poi essere giustapposti tramite un atto di fotomontaggio analogico che molto deve alla pratica dell’artista d’avanguardia Hannah Höch. L’attrice reggiana degli anni Venti Maria Melato traghetta dei bambini su una zattera di fortuna che solca un mare aperto a perdita d’occhio – nella visione dell’artista, uno scenario in cui il livello dell’acqua si è alzato al punto da arrivare a sommergere la città. La monumentalità del dipinto non è funzionale alla narrazione di un episodio epico, bensì a restituire tracce del passato locale, mostrando identità laterali ai grandi avvenimenti del passato che fanno riemergere storie di emarginazione, resistenza ed emancipazione; non casualmente l’attrice è accompagnata dal figlio avuto da nubile, che, avanti sui tempi, riconobbe e crebbe da sola. A prua, invece, è seduta un’anonima bambina, fotografata mentre era internata a San Lazzaro, che torna a respirare l’aria frizzante del mare dopo decenni di oblio. In cielo due aerei da combattimento, uno tedesco e l’altro italiano (prodotto dalle Officine Meccaniche Reggiane), evocano lo spettro della guerra; un momento comunque cruciale per il percorso di emancipazione delle donne, dato che in quel periodo ebbero la possibilità di acquisire maggior peso sociale a causa della drammatica convocazione di massa degli uomini al fronte. Le quattro figure sono fantasmi riaffiorati dalla Storia con sguardi penetranti che inducono ad una prima presa di coscienza del sommerso. Nella stessa sala si trovano in posizione defilata altri dipinti più piccoli e strettamente connessi tra loro. La politica (la Nilde) riproduce una fotografia del 1983 di Nilde Iotti, politica reggiana legata a Palmiro Togliatti, il cui viso è parzialmente celato da un ventaglio. In una conversazione con chi scrive, Giulia Andreani ha dichiarato che per lei “Nilde Iotti simboleggia un aspetto dell’emancipazione femminile che, attraverso la politica, ha dovuto fare i conti con un Partito che avrebbe dovuto difendere la causa delle donne, ma in cui regnava anche un pensiero misogino e omofobico. Il fatto che si nasconda con questo ventaglio sottolinea anche la dimensione della maschera in politica, del compromesso che ha dovuto fare con gli uomini e con la Storia ufficiale”. In prossimità di un altro angolo della stanza, il dittico La distratta si compone di un acquerello orizzontale, che riprende una fotografia scattata durante una commemorazione della Liberazione negli anni Cinquanta, e un acrilico verticale che ingrandisce una porzione localizzata di quello scatto, cioè il dettaglio di una bambina annoiata che si appoggia alla ringhiera della tribuna, circondata da uomini in abiti militari. In quella circostanza ufficiale, istantanea della vita politica dell’immediato dopoguerra italiano, la “Distratta” diviene inconsciamente una “figura di dissidenza” nei confronti dell’ordine prestabilito. “Quando i visitatori accedono alla mostra, trovano l’opera alle loro spalle. C’è quindi un’altra inversione: lei diventa spettatrice del pubblico e di ciò che accade nella mostra, e persino della mostra stessa”.


Nella seconda sala ad accogliere il visitatore è uno sguardo penetrante che si leva da L’improduttiva, il dipinto che dà il titolo alla mostra. La composizione è tratta da una foto d’epoca scattata in un laboratorio della scuola di sartoria di Reggio Emilia fondata da Giulia Fontanesi Maramotti, madre del fondatore della casa di moda Max Mara (l’edificio che ospita la Collezione fu la prima sede dell’azienda). Tra le decine di ragazze che stanno in piedi ai tavoli dei cartamodelli o sedute alle macchine da cucito, soltanto una guarda nell’obiettivo, parzialmente nascosta da una compagna assorta nel proprio lavoro: il suo sguardo, tra il divertito e il beffardo, è un ponte attraverso i decenni che colpisce e coinvolge l’osservatore in una riflessione sul lungo e tortuoso percorso di emancipazione compiuto dalle donne reggiane; il fugace atto “improduttivo” di alzare lo sguardo dal proprio lavoro e di prendersi gioco del “male gaze” incarnato dal fotografo, analogamente al fare disinteressato della bambina nell’opera precedente, si fanno emblema di una nuova postura storica. Le opere di Giulia Andreani sono tutte accordate su una tonalità molto specifica, il cosiddetto grigio di Payne, steso ad acrilico o ad acquerello. Questo colore, che prende il nome dal suo inventore, il pittore romantico William Payne, è stato storicamente denigrato in quanto inadatto alla pittura accademica. Andreani lo riscopre e lo rivendica, allo scopo di evocare più efficacemente i neri e i grigi sbiaditi delle fotografie d’epoca; ma il colore si presta anche a sottili sfumature più calde o più fredde – quelle che Payne riteneva perfette per dipingere i suoi crepuscoli lattimi – che lo rendono intrinsecamente fantasmatico e capace di veicolare un ritorno straniante del rimosso storico. È ciò che avviene nella terza sala in La scuola di taglio e cucito, trasposizione ad acquerello in grande formato di una foto di gruppo, con al centro la fondatrice Giulia Maramotti, nitida e demarcata, mentre tutto intorno i connotati delle altre donne sbiadiscono in spettri. Per contro, sulla parete adiacente spicca una serie di sette primi piani di donne, Sette sante internate a San Lazzaro: dalle loro fredde schedature psichiatriche affiorano sfumature caratteriali ed emotive, che restituiscono parzialmente giustizia e umanità a identità comunque destinate a rimanere anonime. “L’idea – aggiunge l’artista – è di ridare loro vita, di riprendere questi volti e consentire un vis-à-vis, dare loro la possibilità di esistere al di fuori delle pubblicazioni scientifiche dell’epoca che operavano una catalogazione di volti femminili in relazione alla follia”.
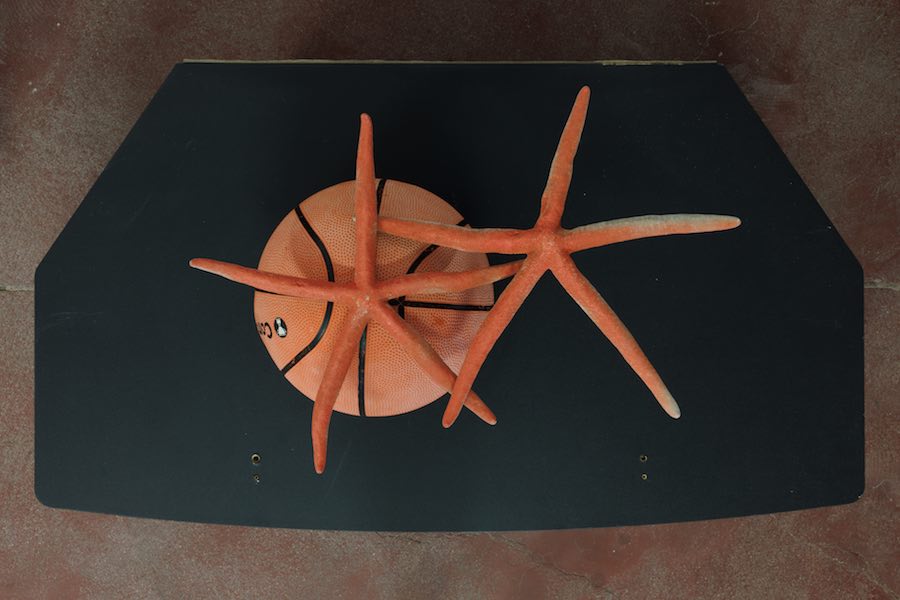
In altri ritratti, sui volti femminili in scale di grigio si posano maschere rosse o dorate, elmi o diademi che li ammantano di nuovo potere. Tra questi si distingue La gitana anarchica (Djali-Leda), rappresentazione della poetessa e scrittrice Leda Rafanelli, una figura complessa dell’anarchismo italiano prebellico (dichiarava di essere di origine zingara, di essere cresciuta in Egitto e di essersi convertita all’Islam) che arrivò ad assumere lo pseudonimo Djali, in arabo “colei che si è liberata”. In mostra si adorna di una maschera dorata di forma triangolare, che sembra alludere ad una qualche forma di illuminazione interiore. In La Mère corbeau è il ritratto a figura intera di un’altra donna internata nell’ospedale psichiatrico ad ammantarsi di una maschera librante. Il titolo, “la madre corvo”, gioca sulla doppia accezione che questa espressione assume rispettivamente nella lingua tedesca e nella cultura Hopi; se in Germania con quel termine si allude negativamente ad una madre che non si prende cura dei suoi figli, al contrario per i nativi americani ci si riferisce ad uno spirito positivo che in qualche modo evoca l’idea di una società matriarcale. Andreani ha chiesto al proprio figlio piccolo di colorare a suo piacimento la maschera, ispirata ai tipici cimieri alati dei nativi. L’atto spontaneo del bambino restituisce colore e gioia alla testimonianza visiva della sofferenza di una delle tante donne dimenticate di San Lazzaro. Nell’ultima sala si trova un nucleo di dipinti che ruota attorno ai temi della genitorialità, della famiglia e dell’anarchia, a partire dalle fotografie scattate dall’anarchico reggiano Vernon Richards, al secolo Vero Recchioni, il cui fondo situato alla Biblioteca Panizzi conserva anche un’immagine di George Orwell insieme al figlio Richard (La paternità). Il controverso scrittore e anarchico britannico, che non fu estraneo ad atteggiamenti omofobi e misogini e che aveva accettato con riluttanza l’adozione del figlio tanto desiderata dalla moglie Eileen O’Shaughnessy, si presenta in una inedita veste di padre amorevole. Ma in questo album di famiglia bloccato nel presente eterno di un istante idilliaco compare anche il corrispettivo di quell’atto paterno, cioè uno scatto in cui Eileen tiene in collo il piccolo Richard (La Madre). La donna, poi scomparsa prematuramente a causa di un intervento chirurgico andato male, contribuì in modo cruciale all’ispirazione e alla promozione delle opere del marito, ma questo ruolo è stato a conti fatti occultato da Orwell, al punto che solo recentemente è stata riconosciuta la sua importanza in merito. La mostra di Giulia Andreani contribuisce così a restituire anche a lei nuova visibilità. “Il personale è politico”, dichiarava il motto dei moti femministi degli anni Settanta; oggi più che mai tale assunto è ancora valido.











