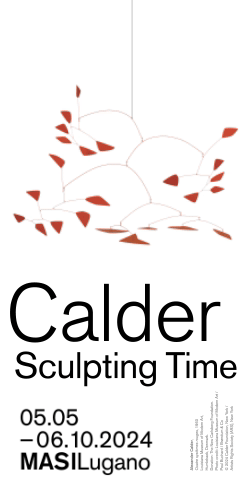Orientarsi tra le tante partecipazioni nazionali che presenziano ad ogni edizione della Biennale di Venezia è da sempre un obiettivo arduo; ancora più arduo, forse, è rilevare le proposte più interessanti e raccontarne compiutamente i progetti. I bignami che riassumono i migliori padiglioni in un elenco rapido di voci, per quanto utili come primo e più immediato strumento di navigazione dell’offerta artistica globale espressa in tutte le sezioni della Biennale, rischiano di risultare insufficienti, sul lungo periodo, per valutare criticamente quanto proposto da ogni comitato organizzativo. Pertanto, abbiamo deciso di rinunciare all’immediatezza e di avventurarci in alcuni focus su sezioni specifiche della 60° edizione della Biennale di Venezia, con l’obiettivo di indagare il lavoro di quelli che riteniamo essere i migliori padiglioni nazionali, senza rinunciare ad uno sguardo “topografico” d’insieme che cerca di preservare la percezione della convivenza, nei luoghi della Biennale, tra realtà geograficamente e culturalmente lontane, che è uno degli aspetti più arricchenti dell’esperienza della Biennale. Aspetto, peraltro, che quest’anno appare particolarmente attuale, dato che uno degli obiettivi dichiarati è quello di restituire la parola agli artisti che sono stati sistematicamente emarginati in funzione della loro origine geografica; dunque, a chi si è formato e ha praticato la propria arte in Paesi esterni al Nord globale, come a chi ha dovuto emigrarvi per motivi di sopravvivenza, cercando poi di far dialogare la propria cultura con i contesti di arrivo. Questo primo focus è dedicato ai migliori padiglioni che, all’interno del percorso dell’Arsenale, trovano posto nelle cosiddette Artiglierie.


Proprio alla luce di quanto premesso, pare significativo aprire questa rassegna citando la prima partecipazione nazionale del Benin, che approda a Venezia con la mostra Everything Precious is Fragile, una collettiva di quattro artisti curata da Azu Nwagbogu. Pare altrettanto importante che l’occasione di presentare al mondo dell’arte internazionale la cultura e la produzione artistica beninese segua a stretto giro il ritorno in patria dal Musée du Quai Branly di Parigi, nel 2021, di ventisei tesori saccheggiati durante la conquista coloniale francese del regno di Dahomey (1894). La preparazione di questo padiglione, nella perfetta cornice di una Biennale che vuole dare rappresentanza alle voci marginalizzate, si instrada dunque in un percorso molto consapevole attuato negli ultimi anni dal Benin nella direzione della valorizzazione del proprio patrimonio culturale. La mostra si riferisce a diversi tratti connaturanti la storia e la cultura del Paese, ossia la spiritualità Voodoo, la tratta degli schiavi e la figura dell’Amazzone, letti attraverso la filosofia Gèlèdé: un insieme di pratiche performative rituali che trova espressione in una regione geografica che si estende anche oltre il confine con la Nigeria; questo aspetto, come la decisione di selezionare un curatore di origini nigeriane, vale come proposta programmatica di superamento delle identità nazionali imposte in epoca coloniale. Tali pratiche ruotano attorno alla celebrazione del potere delle donne all’interno delle comunità. Il Gèlèdé, che celebra la fragilità e insieme la preziosità della vita, si presta pertanto ad un’attualizzazione in funzione del pensiero femminista, che interpreta la restituzione dei beni saccheggiati in epoca coloniale sotto la lente teorica della “rematriation”: una versione virata al femminile del termine “repatriation”/“rimpatrio”, che sta per “ritorno alla patria”, da “patriarkhes”, “padre comandante/capostipite”. “Rematriation” è un termine intraducibile, se non con un neologismo ancora da coniare nella lingua italiana, e questo proprio perché storicamente in molte culture europee le donne non erano autorizzate a possedere la terra, per cui era di fatto inconcepibile, sul piano pratico come su quello linguistico, il ritorno “alla terra delle madri”. Il padiglione beninese vuole mettere enfasi su un femminismo nero, che rimanda al ruolo della madre nella spiritualità Voodoo, alla mitica regina Tassi Hangbè fondatrice del regno di Dahomey, alle innumerevoli donne anonime soggette alla tratta degli schiavi. Ne emerge una figura archetipica di donna guerriera, “ventre del mondo”, che rigenera e cura col proprio abbraccio la violenza della rimozione e della cancellazione.

Ishola Akpo (1983) in Ìyálóde, facente parte della serie Traces of a Queen, riproduce su un tessuto jaquard di sette metri di larghezza una fotografia d’archivio che mostra una rappresentanza delle Amazzoni di Dahomey, un reggimento militare storicamente composto da sole donne, disposte ai lati del trono del re Béhanzin, la cui figura è però stata sostituita dalla rappresentazione di una regina immaginaria, unica figura a colori, adornata da un filo rosso. In parallelo, Moufouli Bello (1987) ritrae in variazioni di blu alcune donne della propria comunità con i loro preziosi abiti tradizionali nella serie di dipinti dal titolo Night birds (2022); i dipinti si alternano agli scaffali di una Library of Resistance, composta da volumi di tematiche femministe disponibili per la consultazione. Heure Blue (2024) di Chloé Quenum (1983) associa una riproduzione fedele, in scala 1:1, della finestra del padiglione, sospesa alla stessa altezza e nelle sue prossimità, ad una serie di strumenti tradizionali del Benin realizzati in vetro, afferenti a diversi gruppi etnici che facevano un tempo parte del regno di Dahomey; questi strumenti venivano suonati durante le celebrazioni delle Amazzoni. La scelta del vetro per la riproduzione di questi strumenti rappresenta un preciso riferimento alla storia della schiavitù nell’Africa Occidentale, perché le perle di vetro di Murano erano una delle principali merci di scambio per il baratto; inoltre, sono messi in relazione con l’architettura dell’Arsenale per riportare alla luce il passato con cui Venezia stessa deve fare i conti, dato che le navi impiegate per la tratta venivano spesso costruite proprio nei suoi cantieri navali. Tanto è eterea e fragile l’installazione di Quanum, tanto è massiccia l’opera Ashé (2024) di Romuald Hazoumè (1962), una capanna semisferica composta da 520 taniche-maschere di metallo rivolte verso l’interno e adornate di monili sempre diversi, che secondo l’artista sono da leggersi come i volti degli schiavi deportati, delle Amazzoni di Dahomey, di spiriti voodoo, di donne beninesi di oggi; parte per il tutto degli abitanti del Paese.

Un simile processo di rilettura in chiave femminista di tratti culturali tradizionali è anche al centro della riflessione di un altro padiglione delle Artiglierie, quello del Libano, che condivide con il Benin il fatto di essere approdato da poco alla Biennale di Venezia, trattandosi della sua seconda partecipazione. Con il suo mito lei danza, personale di Mounira Al Solh (Beirut, 1978) a cura di Nada Ghandour, espone una serie di oltre quaranta opere multimediali – dipinti, disegni, sculture, ceramiche, tessuti e un’opera video – che ribaltano la narrazione canonica del mito del ratto di Europa da parte di Zeus nelle sembianze di un toro. L’artista racconta nel video la storia della principessa fenicia, che aveva attirato l’attenzione di Zeus mentre raccoglieva dei fiori su una spiaggia di Tiro ed era stata rapita quando il dio, trasformatosi in toro, le si era avvicinato; condotta fino alle coste di Creta, secondo il mito vi subì una violenza. L’artista dice anche di essere partita alla sua ricerca e invita il visitatore a partecipare a questo viaggio per mare, usufruendo della barca situata al centro del padiglione, sulla cui vela viene proiettato il filmato. E la ricerca condivisa ha già dato dei frutti; i tessuti dipinti e i disegni su papiro, tutti schierati da un lato del padiglione, delineano in una gamma cromatica ricchissima nuove iconografie, che mai sono state impiegate per rappresentare le vicende di questo mito: Europa si è fieramente emancipata dal suo aggressore e promuove piuttosto i valori dell’uguaglianza dei generi. Se nella storia originale la principessa fenicia deve soccombere alle richieste del dio, nella riscrittura di Mounira Al Solh si fa portavoce di nuove istanze di emancipazione dal male gaze e dal potere patriarcale, rappresentato in mostra da una serie di maschere mostruose disposte in linea sul lato opposto della sala, le quali continuano a costituire una minaccia non così remota. Si noti che la barca si trova esattamente a metà strada tra i due schieramenti; in più, essa appare evidentemente incompleta, a simboleggiare il fatto che il percorso di riscatto non è ancora del tutto compiuto e anzi continua a persistere il pericolo di un rivolgimento reazionario.



In questo contesto, meritano una segnalazione anche due partecipazioni europee, che propongono interventi sobri e ovattati, che parlano di utopie multidimensionali o procedono addirittura a ironiche decostruzioni dello stesso contesto espositivo. Il padiglione della Lettonia è occupato unicamente dall’ingombro di una serie di strutture lignee di scala comparabile o anche superiore a quella umana, alcune salde a terra, altre appese o aggrappate alle pareti. Trattasi di opere di Amanda Ziemele (1990), superfici monocromatiche rette da telai lignei variamente orientati e giuntati, che consentono ad esse di autosostenersi e di trovare un proprio baricentro, appoggiandosi sulle proprie estroflessioni. Così, in qualche modo, assumono anche il connotato di sculture bifacciali: da una parte dominano sensuali campiture di colore, le cui pennellate appaiono tutte orientate conformemente ai profili di volta in volta variabili delle superfici; sul lato opposto, configurazioni analoghe caratterizzano le ramificazioni strutturali dei telai, lasciate a vista e anzi subito evidenti a chi entra nel padiglione. La mostra, curata da Adam Budak, prende il titolo di O day and night, but this is wondrous strange… and therefore as a stranger give it welcome: una celebre citazione dall’Amleto di Shakespeare, ripresa nel romanzo di fantascienza Flatland: A Romance of Many Dimensions (1884) di Edwin A. Abbott. Lo stupore di Orazio rispetto a quanto rivelato dallo spettro del padre di Amleto (“Oh luce e tenebre! Ciò è stranamente meraviglioso”) e la risposta dello stesso Amleto (“E perciò diamogli il benvenuto, come ad uno straniero”) si prestano, nella novella matematica di Abbott, ad esprimere vicendevolmente lo stupore del lettore rispetto alle dinamiche che regolano il mondo a due dimensioni di Flatlandia e quello provato dal protagonista, un quadrato, quando entra in contatto con una sfera proveniente da un altrove tridimensionale. E, in fondo, è lo stesso senso di spaesamento e sorpresa che prova in un primo momento chi entra nel padiglione, trovandosi accerchiato da questi volumi lignei, che alludono pertanto a dimensioni ulteriori, nel registro del pensiero; campi di possibilità che, nella narrazione dell’artista, vogliono rappresentare isole di rifugio e accoglienza della diversità, corpi queer espansi oltre ogni connotazione di genere; “stranieri” a cui dare il benvenuto. Sul lato interno del padiglione, tre creature oziose: una arancione “stesa” a terra, una ocra “in piedi”, una azzurra “appoggiata” all’angolo della stanza; sembra spontaneo leggerne le posture in stretta relazione con la propria corporeità, nonostante la loro dichiarata “estraneità” dimensionale. Nel lato più prossimo alla finestra vetrata, due volumi contraddistinti da piani inclinati “guardano” verso l’esterno; le loro superfici, rispettivamente di colore rosso mattone e turchese, a certe ore del giorno sono screziate dalla luce che filtra dalla raggiera della vetrata. In alto, una “foglia” verde e una creatura gialla osservano in silenzio chi transita.




Nel suo percorso lineare attraverso le Artiglierie, il visitatore si imbatte all’improvviso in un ambiente pressoché spoglio, che a prima vista appare come un luogo di servizio, una camera di decompressione dalla sovrastimolazione provata nel susseguirsi dei padiglioni precedenti. Alle pareti, solo elementi di non facile identificazione, come delle sagome sghembe disposte in modo apparentemente casuale o degli oggetti in plastica che appaiono come inglobati nei muri. Trattasi, in realtà, del padiglione dell’Islanda, che ospita il progetto That’s a Very Large Number – A Commerzbau di Hildigunnur Birgisdóttir (1980), a cura di Dan Byers. Il titolo riecheggia il celebre Merzbau del dadaista tedesco Kurt Schwitters, una monumentale opera astratta percorribile ed abitabile, assemblata mediante materiali di scarto in un flusso di continua rielaborazione e “digestione” degli oggetti più vari. Se Schwitters aveva tratto il termine “merz” da una pagina di giornale su cui compariva la dicitura “Commerz Und Privatbank”, certificando ma allo stesso tempo dissimulando attraverso la radicale anti-estetica dada un legame con il mondo della produzione di massa e del commercio, nell’attualizzazione di Birgisdóttir quel rapporto è reso nuovamente lampante: attraverso il recupero del prefisso “com”, l’abbacinante opera d’arte totale di Schwitters è ridimensionata ad un white cube che mormora sobriamente – e con un velo sottile di ironia – il linguaggio del tardocapitalismo nella sua fase più decadente. Non è più il tempo dell’ascesa trionfalistica della società dei consumi, con i suoi spot pubblicitari accattivanti e l’estetica della saturazione e dell’eccesso sfoggiata dalla Pop Art; il sistema riflette su se stesso e sulle proprie fallacie e avvia l’auto-decostruzione. Ecco spiegate le due sculture di plastica appese alle pareti, ricavate dai pannelli di controllo di una stampante (Fake News [never!]) e di un frigorifero (Fake News [always?]). Entrambe lampeggiano senza sosta, segnalando errori fantasma (rispettivamente l’inceppamento della carta e la porta del frigo lasciata aperta): il malfunzionamento è strutturale e va oltre la contingenza del singolo elettrodomestico. Fuori dalla finestra e dunque dal perimetro circoscritto del padiglione, si può osservare uno schermo LED che trasmette in diretta la pubblicità riprodotta da un cartellone situato al lato di un’autostrada nella periferia di Reykjavik (Approx. 7%); ma tutto il suo appeal consumistico appare inevitabilmente sbiadito, e può capitare di passare oltre senza neanche accorgersene. Disseminati qua e là sulle pareti, giocattoli di plastica originariamente concepiti in piccolo formato per le case delle bambole sono stati scansionati e ingranditi ad una scala equivalente o persino ridondante rispetto a quella degli oggetti di cui sono imitazione: una pizza, un attrezzo da dentista, una bistecca manifestano con le loro forme semplificate e le giunzioni plastiche la loro natura artificiale. Completano la sequenza di oggetti applicati alle pareti alcune sculture realizzate rispettivamente con materiali riciclati, che siano sacchi di caffè in juta o denim, riproducenti le forme di usuali tipologie di imballaggi che proteggono i prodotti acquistati durante le spedizioni (19:1 (Window Piece)). I giocattoli di plastica e le sagome da imballaggio sono stati realizzati con il supporto di due aziendeche si aggiungono alle numerose altre della filiera – oltre 70 – che hanno contribuito all’allestimento del padiglione nel suo complesso; i loghi compaiono tutti uno accanto all’altro sull’arredo più appariscente della sala, un grande pannello che funge anche da apparato informativo della mostra, ma che in verità è esso stesso un’opera ibrida, dal titolo Infoxication, realizzata a partire dal reimpiego di una porzione di pavimento proveniente dal padiglione argentino della Biennale Architettura 2023. Oltre ai loghi, alle informazioni relative allo staff del padiglione, agli indirizzi web che rimandano al sito internet e al press kit, ad una descrizione sommaria delle opere esposte, presenta anche un effetto olografico simile a quello delle banconote, che conferisce ad esso una certa aura di preziosità, del tutto immotivata; l’olografia, peraltro, non fa altro che ripetere il nome dell’azienda che se ne è occupata. Al centro della stanza, il modesto tavolino che negli altri padiglioni è utilizzato dallo staff per i rapporti con i visitatori è ricoperto di buste di salviette umidificate (Healthy Gums. Healthy Life). Nei mesi estivi si riveleranno utili; ne prendiamo una e passiamo oltre.