
Intervista con Filippo Minelli —
Mauro Zanchi: In certe fotografie (vedi per esempio alcune opere di John Baldessari, Keith Arnatt, Mel Bochner, John Hilliard, William Wegman), le parole a volte sono presenti per mettere in discussione l’oggettività dell’immagine, altre volte per segnalare l’artificio della comunicazione, per indurre una riflessione sul potere descrittivo della fotografia, per creare un cortocircuito o altro. In questi casi che rapporto si costituisce tra linguaggio scritto e immagine?
Filippo Minelli: La parola è un elemento come un altro, un segno, che se inserita in un contesto può aggiungere, sottolineare, rimuovere o invertire significato; è popolare nell’accezione positiva e disastrosa del termine. È particolarmente evocativa perché invece dell’immagine assume la forma più esplicita di messaggio per via della sua forma testuale, e quindi è più immediata. È anche un elemento distintivo del contemporaneo, perché si lega all’estetica della pubblicità, della cartellonistica, delle telepromozioni. A livello visivo la parola è anche seducente per il carattere e la spaziatura delle lettere, riesce a cambiare il sapore della narrazione come un sottotitolo sbagliato, o spinge lo sguardo distratto a una lettura più profonda. La cosa più intrigante per me è che non può mai essere interpretata in un solo modo, perché essendo così legata alla narrazione assume anche significati diversi in base al periodo storico, alla formazione ed esperienza personale dell’osservatore.
MZ: Nell’opera Vera Fotografia, Mimmo Jodice sembra contraddire qualcosa di quello che è visibile. Il linguaggio verbale e quello visuale, insieme, paiono tradire qualcosa del reale, o forse solo il tentativo di mentire al fruitore di un’immagine. Quest’opera ha parentele o legami con la tua poetica?
FM: In realtà non sono un grande conoscitore di fotografia, ma credo che tradire il reale e mentire al fruitore siano due pratiche essenziali sia nella fotografia che nell’arte, e che di fatto ne garantiscono la loro sopravvivenza nella storia, a dispetto della situazione temporale in cui sono create. Un lavoro che ho fatto tanti anni fa (forse 2002) durante l’accademia forse è un buon esempio da legare all’opera menzionata di Jodice: la parola ‘sentence’ (frase) scritta su un muro sembra un bianco e nero, chiaro rimando alla fotografia di Jodice. Bugia allora ma di fatto anche ora, erano semplicemente un muro in cemento e vernice spray nera, la fotografia in realtà era a colori e non c’era nessun rimando: allora non avevo la minima idea di chi fosse Mimmo Jodice.
MZ: Hai inserito parole come “Myspace”, “Second Life”, “Youtube”, “Facebook” in zone povere e degradate del mondo e poi le hai fotografate. Quale cortocircuito inneschi evocando social network, tecnologia e modernità affiancati a discariche o sobborghi decadenti?
FM: Sono lavori che ho iniziato nel 2007 durante un viaggio di qualche mese nel sud est asiatico, altri in Mali e altri ancora in comunità marginali dei deserti californiani. Quello che mi interessava era la relazione fra il mondo dei social network che allora stava nascendo, e quindi la diffusione più democratica dell’accesso a internet, e come si confrontava col paesaggio naturale. Mi interessavano le implicazioni di internet nel paesaggio e nella politica, e i comportamenti che ne derivano sia a livello di sottomissione statale che di uso privato. È stato un privilegio vivere il passaggio fra società della produzione e quella dell’informazione, e gli elementi più tangibili dei metodi di interazione attraverso la tecnologia sono sicuramente quegli aspetti divertenti e a volte tragici, che esistono nello spazio tra realtà e rappresentazione.

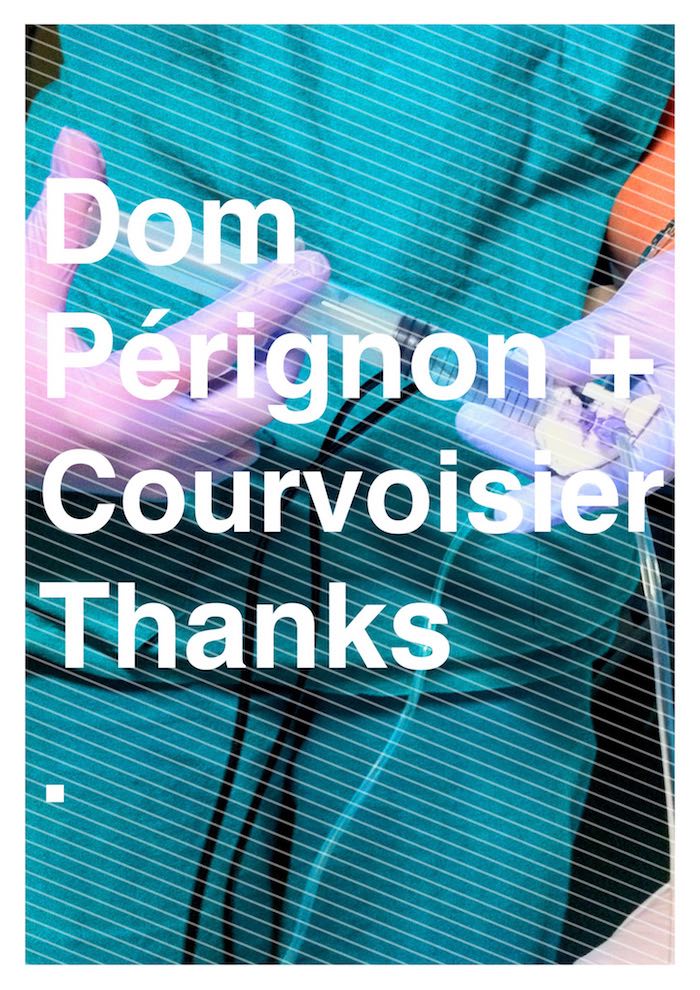
MZ: Le tue parole fotografate sono dispositivi o punti di partenza per tentare un altro utilizzo del linguaggio, anche dotato di capacità rivoluzionaria, per indurre disillusioni ottiche?
FM: Di questo non sono sicuro, però sicuramente mi intriga l’effetto che fanno le parole nel paesaggio. Come dicevo prima le parole sono molto evocative e assumono sfumature differenti a seconda del vissuto delle persone e del contesto storico. C’è chi ci può leggere anche cose a cui forse neppure pensavo.
MZ: Cosa rappresenta per te il contrasto e l’uso di una parola simbolica entro contesti paradossali? La parola “Democracy” compare su una nave in disfacimento nelle coste della Mauritania. La scritta “Ctrl+alt+delete” sul muro vicino al checkpoint Qualandiya (realizzato nel 2007 in Palestina).
FM: La parola fa parte di una pratica più generale che ha mi formato negli anni dell’accademia, un metodo di unire immagine, azione e fotografia, una sorta di teatralizzazione del paesaggio attraverso associazione di idee. Per certi versi l’appropriazione di immagini su internet per unirle a concetti funziona alla stessa maniera, ma è un linguaggio che si è sviluppato successivamente.
MZ: Cosa volevi innescare mettendo la scritta “NONSENSE” (con tutto quello che ne consegue) in mezzo al deserto?
FM: Volevo dare una forma a un’idea, a un significato. L’ho realizzata nel deserto della Mauritania, l’Adrar, durante un viaggio per conoscere alcuni dei luoghi che in quel periodo erano snodi fondamentali di quello che è diventato il contemporaneo; tratta di migranti, presuntuose politiche europee funzionali alla dominazione economica, integralismo religioso, traffici e terrorismo. Ho provato a realizzarla la prima volta nel Western Sahara in realtà, lavorando con artigiani nelle aree della diaspora Saharawi del sud del Marocco, ma per vari motivi non sono riuscito a completarla in quel posto. Di per sé il deserto è un luogo incontrollabile, la storia delle popolazioni che lo vivono lo sottolinea in maniera chiara. Mi divertiva la possibilità di spingermi fino là per realizzare un rimando a una palizzata da casa suburbana. Il paesaggio può essere un dato di fatto, può evocare, ma la cosa più interessante è che può essere una chiave di lettura.
MZ: Mi ricorda in qualche modo la scritta “NAUSEA” installata su una spiaggia americana e poi fotografata da Shannon Ebner (USA, 2003), ma nel tuo contesto sembri suggerire un vuoto più drammatico, un deserto comunicativo.
FM: Più che altro esistenziale, le cose fuori dal nostro controllo vanno lasciate andare. La vita ci porta in molte occasioni a cercare di controllare gli eventi per svariati motivi (protezione, vantaggio, morbosità) e questo si rispecchia anche nelle sovrastrutture che creiamo nella società. È un metodo propedeutico, ma non ho mai capito se aiuti quando il metro di valutazione sono la serenità, il benessere.
MZ: E invece l’utilizzo dello sticker con parole (tipo Google appiccicato sulle scogliere di Bilbao) ha altre connotazioni?
FM: Quello era quasi un gioco. In quel periodo Google stava lanciando talmente tanti servizi che l’impressione di spostamento storico fra paesaggio naturale e digitale sembrava incredibilmente netto. Ne ho fatti parecchi e con varie connotazioni, spesso site-specific e rivolte alla lettura del paesaggio. Uno che mi divertiva l’avevo messo sulla muraglia cinese non distante da Pechino: Google Walls, riferimento anche al firewall con cui il governo cinese scherma molti indirizzi internet. La banalizzazione dell’immaginario visivo passa soprattutto dalle policy aziendali di chi seleziona o distribuisce contenuti, grande responsabilità in cui nessuno vuole mettere il becco.



MZ: Che significato e valore ha per te il concetto della contraddizione?
FM: La contraddizione è un modo di sottolineare che c’è qualcosa che non funziona, in termini generali. Per certi versi, oltre una descrizione è anche una denuncia, ma soprattutto mette in luce le alternative. Mi viene in mente un vecchio e poco conosciuto lavoro di David Shrigley, una fotografia a un prato verde con un piccolo cartellino rosso che dice ‘imagine the green is red’. Questo periodo storico è la contraddizione per eccellenza e questa caratteristica si rispecchia anche nel mondo della cultura, rendendola quindi anche molto democratica: come tale la contraddizione è un buon modo di ridimensionare tutto, relativizzare sia eventi sia persone.
MZ: Un ulteriore significato e uso sembrano alludere le parole presenti sulle tue bandiere. Coinvolgono altre questioni?
FM: Più che mie quelle parole sono dei performers che coinvolgo nei vari progetti, chiedendo loro di sintetizzare con una parola la ragione per la quale il luogo a cui si sentono di appartenere condivide qualcosa con un altro luogo del pianeta. A volte sono ragioni politiche, a volte provocazioni, a volte nonsense, a volte sono rimandi descrittivi o geografici, ma restano sempre contenuti molto intimi ed è per quello che mi interessano: riportano l’identità a una dimensione umana. Le prime bandiere le ho realizzate nel 2010 viaggiando per conto mio, a volte per altri progetti a cui ero invitato. Le ultime invece mi sono state commissionate per Manifesta12 e ho chiesto di realizzarle a distanza. Questo metodo non mi appartiene molto, ma mi ha aiutato a capire come la mia presenza durante le performance può in certi casi interferire con alcune scelte.
MZ: La parola costituita da capelli tagliati, in Chemotherapy Update (2010), apre un altro discorso. Così pure la scritta Dom Perignon associata a una siringa da ospedale crea un’ulteriore connotazione?
FM: Associazioni, negazioni, decontestualizzazione, sono tutti metodi di lettura efficaci e divertenti per mutare la narrazione delle cose. Difficile però definirlo progetto quello, forse lo è diventato grazie al fatto che ha avuto un inizio e una fine, e al fatto che Domenico Quaranta ne aveva scritto e che successivamente con Fabio Paris mi ha chiesto di esporlo per il loro Link Center. È stato il periodo della mia vita in cui non potevo viaggiare, per ragioni mediche appunto, e mi sono messo a giocare con una app, per impaginare flyers di eventi e per raccontare via internet agli amici che non potevo incontrare i piccoli momenti della vita in ospedale, che in quei mesi incerti avevano il sapore di eventi veri.
MZ: Il filosofo analitico John Langshaw Austin, in Sense and sensibilia (1962), sostiene che per dimostrare quello che qualcosa è bisogna dimostrare ciò che non è. Partendo da questa modalità, Keith Arnatt nel 1972 si è fatto fotografare in strada mentre indossa un cartello che recita la scritta: I’M A REAL ARTIST. In un’altra versione di Trouser-Word Piece (1972), la fotografia è stata poi esposta con accanto una grande cartolina che riproduce un brano del libro di Austin. L’artista sembra mettere in azione qualcosa che nega ciò che porta scritto a grandi lettere e che sembra voler affermare. Qui che valore ha la parola fotografata?
FM: Sembra un contesto adeguato per andare a rispolverare un breve intervento di Heidegger a una conferenza, Principio di Identità, ma penso si possa più semplicemente tornare a quello di cui parlavamo prima: realtà e finzione e l’importanza della loro differenza. Nell’arte ha senso applicare gli stessi metodi di ragionamento che si utilizzano per altri aspetti della società, o il valore più grande è mettere in discussione i valori stessi e come essi vengono attribuiti?














