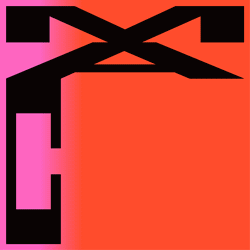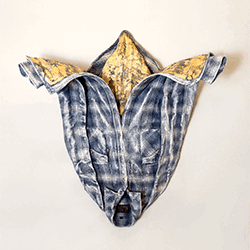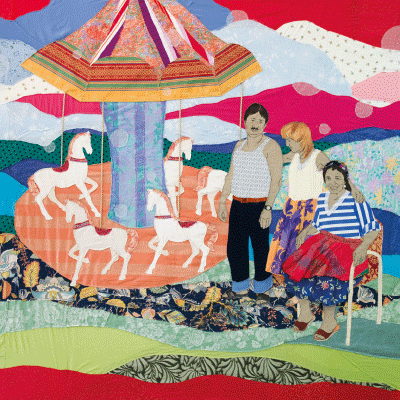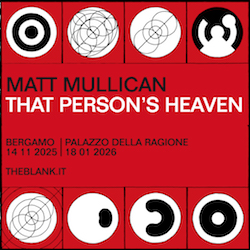how we always survived è il titolo della mostra monografica di Pauline Boudry / Renate Lorenz, a cura di Lucrezia Calabrò Visconti, Head Curator dell’Istituto Svizzero di Roma, che porta per la prima volta in Italia il duo attivo dal 2007, includendo nuove commissioni e opere esistenti (visitabile fino al 1/02/26). Nella loro pratica multidisciplinare, Boudry / Lorenz fondono scultura, performance, coreografia, musica e film in installazioni che mettono alla prova le logiche espositive del white cube e del black box. Nel 2019, il titolo del loro intervento installativo al Padiglione Svizzero durante la 58esima Biennale di Venezia era, significativamente, «Moving Backwards», un’esplorazione di pratiche resistenziali attraverso il connubio di tecniche di guerriglia e coreografie postmoderne. Questa singolare specificità, che connette la ricerca di Boudry / Lorenz alla cultura underground queer, nonché alla militanza politica e alle teorie postcoloniali, investe con forza disarmante e capacità penetrativa anche il progetto per l’Istituto Svizzero.
La mostra si sviluppa come un dispositivo visivo complesso in cui il movimento dei corpi (quelli dei visitatori e delle visitatrici) genera un movimento di prossimità capace di significare lo spazio, e la visione, insieme a – e non in opposizione con – quanto viene mostrato e messo in scena. Lo spazio diventa così un palcoscenico aperto – ce lo ricordano, entrando, i microfoni a parete – Microphone Piece (unconscious rehearsal), 2023 – e i pavimenti in PCV nero – Dancefloor Piece (Portrait of Jules Cunningham), 2025; Dancefloor Piece (Portrait of Werner Hirsch), 2024; Dancefloor Piece (Portrait of Daniela Gallegos), 2024, che ostacolano la visione del grande scalone di rappresentanza della Villa. La non neutralità dello spazio è perciò rievocata attraverso slittamenti costanti di senso generati da scelte attente a tutto ciò che circonda gli schermi, i props, e così via. La scelta di temporizzare le video-installazioni è ciò che colpisce nella resa funzionale di questo grande organismo sonoro che è la mostra così concepita; una scelta coraggiosa, e situata, che consente di entrare a pieno nella ricerca di Boudry / Lorenz.


C’è un movimento fluido che transita da una sala all’altra, e che in qualche modo consente al corpo unico dei visitatori di muoversi all’unisono, generando una coreografia collettiva che sembra, in un gioco a specchio di tipo esperienziale, aggiungere un livello ulteriore all’interno del dispositivo-mostra tout court. Questo parziale occultamento introduce anche un secondo livello, che ha che fare con l’opacità, o meglio con la centralità del concetto di opacità così come è stato raccontato da Édouard Glissant: “Per questo io chiedo per tutti il diritto all’opacità. Non mi è più necessario ‘comprendere’ l’altro, cioè ridurlo al modello della mia propria trasparenza, per vivere con quest’altro o costruire con lui. Il diritto all’opacità sarebbe oggi il segno più evidente della non-barbarità”. In questo senso, anche la relazione tra corpi – quelli dei visitatori, quelli dei/delle performer – viene ripensata a partire dalla necessità di veicolare un modello decentrato che si distacca dalla metafisica tradizionale di stampo europeo – ovvero quella che intende la relazione con l’altro/l’alterità come un adeguamento dell’altro e, quindi, un meccanismo incontrovertibile di controllo, esercizio di potere e di trasparenza a discapito dell’altro. Nel diritto all’opacità si riflette quello alla differenza e alla possibilità di vivere al di fuori delle strutture normative del riconoscimento. È anche da queste tracce concettuali che risulta evidente la rilevanza della figura di Chelsea Manning – il titolo how we always survived è, non casualmente, tratto da una frase dell’attivista contro la guerra e attivista Trans.
In questa narrazione dello spazio, la costante è l’idea della non sincronicità legata alle temporalità che abitano lo spazio e l’intera installazione: se nella lettura diacronica della storia e degli eventi, il rimosso fatica ad emergere perché costretto nella morsa del tentativo normativo di riportare tutto ad una prospettiva lineare, in questo approccio a-sincronico è enucleata tutta la potenza delle storie e degli eventi che compongono l’universo, ampio e stratificato, reso per immagini, suoni, coreografie e gestualità all’interno della mostra.


È un po’ come nella concezione di una “storia pre-postera” nell’indagine di Mieke Bal in “Quoting Caravaggio” (1999): ciò che sembra cronologicamente precedente agisce come un effetto successivo, causato dalle immagini/contenuti/storie prodotte dopo. I materiali del passato (il materiale documentario) non è visto come qualcosa di inerte, ma come materia viva a cui associare un ruolo di agency ben preciso. Estrapolare e appropriare materiali dal passato serve a esercitare uno sguardo analitico, e di prossimità, con la decisione consapevole a non ripetere – o perpetuare – atti di svalutazione: “We ofen work with materials from the past that show bodies that have been marked as ‘other’, freaky, perverse, racialised or socially outcast. But when we do this, we ask a lot of questions about how we can work with these documents without repeating processes or acts of devaluation of these bodies”. (in “Stages: A Conversation Between Andrea Thal, Pauline Boudry, and Renate Lorenz”, Berlin, September 2010). È per questa stessa ragione, ad esempio, che per Boudry / Lorenz la performance non esiste al di fuori del film, i due momenti sono strettamente connessi, e inseparabili. Non c’è voyeurismo. Il film non rappresenta, per trasposizione, una documentazione della performance. Allo stesso modo, la danza e la coreografia diventano un’estensione della parola, arrivando anche a sostituirla (All The Things She Said, 2025). Il suono è il tramite attraverso cui le coreografie e i soggetti che performano sono in grado di prendere la parola. La musica funziona da tramite cioè per la significazione di corpi in movimento, irriducibili nelle loro singolarità opache.
La costruzione di una contro-narrazione – una, tra le molteplici possibili – rappresenta perciò l’invito a muoversi insieme, creando una comunità effimera in cui la disillusione politica intreccia desideri e nuove frequenze. Attraverso un intreccio di corpi, materiali artificiali, voci, e musica la mostra esplora il potere del suono e del movimento collettivo come strumenti capaci di esprimere ciò che il linguaggio non riesce a dire.
Cover: Pauline Boudry / Renate Lorenz, Bar Piece (2025), All the things she said (2025), Installation view how we always survived, Istituto Svizzero, Roma, 2025 © Annik Wetter Courtesy Marcelle Alix & Ellen de Bruijne Projects