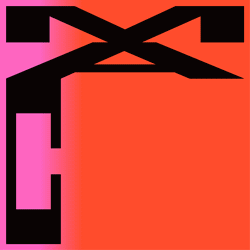Mauro Zanchi: Quale ricerca attuale con il medium fotografico ti interessa di più?
Pino Musi:Oggi, le fotografie che mi attraggono sono quelle indomabili, che hanno la loro origine in un’area di latenza. Evocatrici, ma altrettanto sottilmente equivoche, queste immagini cercano possibili combinazioni con altri linguaggi, soprattutto per somiglianza endogena. La fotografia è straordinaria quando, cercando dialoghi antagonisti, percorsi di migrazione dei segni, si dispone ad essere messa sotto torchio dall’intelligenza e dall’acutezza dello sguardo dello spettatore, sempre aperto ad “altre” possibili letture. Oggi mi è chiaro, che non è poi più così necessario produrre nuove immagini, ma che è vitale rendere più acuto, più attento, lo sguardo, attraverso un esercizio di riattivazione delle immagini preesistenti, intuendo soprattutto possibili connessioni, anche anacronistiche, ed andando a riflettere su analogie sottili tutte da scoprire. Il prodotto di queste relazioni rimodella l’identità delle immagini, senza forzatamente produrne di nuove, che spesso vanno solo a riempire un serbatoio già in eccesso.
MZ: Questo è anche un po’ il motivo conduttore della piattaforma sperimentale on-line MUSI-UM, da te creata con Vittorio Iervese. Di cosa si tratta?
PM: Il sito è diviso attualmente in tre sezioni: la prima, Collection, è organizzata in diversi set, che aumenteranno nel tempo a seconda delle mie pulsioni verso immagini estratte da lavori di diversi autori e che poi rilancio in un puzzle visivo, proponendone nuove e impreviste interazioni; la seconda sezione, Parallel space, curata da Vittorio, cerca di cortocircuitare la fotografia con nuovi media e con il cinema, il teatro e altro ancora; la terza sezione (in perpetua costruzione), Library, consiste in una selezione di libri di fotografia e d’arte, che si orienta verso una riflessione sulle diverse modalità di costruzione della “macchina” libro, intesa non come contenitore di pagine da riempire, non come come catalogo, ma come architettura in cui gli elementi che la compongono, dalle immagini ai testi, dal design alla meccanica progettuale, maturano formalmente con comunanza di intenti. L’input è quello di dare l’opportunità, a chi naviga nella piattaforma, di partecipare con noi a questo esercizio selettivo, di intersecare il nostro sguardo con il loro, attivando altre possibilità combinatorie e la fuoriuscita da una serie di cliché di giudizio che il mondo della fotografia, in qualche modo, ha condizionato negli anni. Oggi si ritiene necessaria una leva di sblocco che vada ad aprire un recinto in cui la fotografia si crogiola autocompiacente, una leva che permetta di uscire dai “generi”, per esempio.
MZ: Che cosa intendi per “generi”? E cosa significa per te andare oltre quello che fino a ora è noto della fotografia?
PM: I generi sono insiemi di convenzioni che hanno organizzato e continuano ad organizzare le aspettative, guidando scelte sia operative sia fruitive. Questi insiemi di aspettative producono vincoli e standardizzano, comprimendolo, il processo espressivo, orientandolo sempre più verso stereotipi che opprimono le opere. La divisione in generi aggrega luoghi comuni entro cui restano ingabbiate le possibili variabili delle forme visive. La fotografia, in bilico fra figurazione e trasfigurazione, è spinta a confrontarsi, mescolarsi, ma anche a contraddirsi con la realtà, diventando intrigante quando è capace di trattenere e sconfinare al contempo. Un “oltre” è insito nell’irrequietezza, a cui non può essere dato traguardo. Rimettendo un pochino in discussione qualche rigida impostazione della storiografia ufficiale, provando ad espandere i punti di vista che, partendo dalla fotografia, vanno a confrontarsi con assonanze esterne, si scopre come molta libera sperimentazione sia stata compressa in specifici “movimenti” o “correnti”, come siano state apposte etichette di comodo a lavori “fuori schema”, inafferrabili, non inquadrabili all’interno di percorsi omologabili, lavori che si spingono verso sponde enigmatiche. La mobilità dello sguardo all’interno di tante immagini porta a definire connessioni, giuste o arbitrarie, ma, spesso, viene attratta da qualcosa di non incasellabile. Lo spiazzamento che apporta questa constatazione è già qualcosa che stabilisce un’unicità all’opera. Per questo motivo tendo, come fruitore, a confrontarmi in primis con le immagini, per poi risalire solo in un secondo momento al loro autore ed alla coerenza del suo universo poetico. Con queste modalità di approccio, la pratica “evolutiva” che può essere presa ad esempio per spingersi “oltre” diventa attività costante di scambio fra immagine e fruitore: l’evoluzione è direttamente proporzionale all’intuizione ed all’articolazione della risposta interpretativa di chi introietta l’opera per poi donarle nuovi impulsi, non solo di chi la partorisce. Solo di recente si comincia ad assistere ad interessanti combinazioni di sguardi incrociati sulle opere, capaci di far cortocircuitare la fotografia dal di dentro e con altre discipline. La fotografia ha prevalentemente citato sé stessa, i suoi percorsi interni, con scarsa capacità di rimbalzi esterni. L’immagine, invece, nei suoi innumerevoli spunti inattesi di dialogo, nutre un immaginario senza confini.



MZ: Hai individuato nelle tue continue ricerche un grande precursore, che in passato ha intuito questioni presenti nella fotografia contemporanea e per qualche ignoto motivo è rimasto nell’ombra?
PM: Prendiamo un caso per me emblematico, certamente non esaustivo. Uno indietro nel tempo, riferito a quel periodo cosiddetto “pittorialista”, il lavoro di Fred Holland Day The Last Seven Words, del 1898. Holland Day, americano, fotografo, intellettuale, filantropo e mentore, dopo un attento studio delle espressioni della teatralità popolare e della coreutica durante le processioni della settimana Santa nell’Oberammergau, in Baviera, attuò un transfert nella figura del Cristo morente, probabilmente andando in autoipnosi, dopo aver predisposto un set fotografico che gli permettesse di essere ripreso, sotto sue precise coordinate, in pose che rimandavano agli ultimi stadi di vita del Cristo crocifisso. Le sette immagini furono poi sviluppate in una sequenza che riproponeva con straordinaria efficacia espressiva la tensione solenne di quegli attimi sulla croce, quindi poi definita, sigillata, in un blocco di legno intarsiato su cui erano riportate the last seven words. Al di là delle implicazioni psicoanalitiche, i riferimenti che quest’opera mette in campo sono, se li si esamina con attenzione, straordinari e molteplici. Oltre che essere stato uno dei primi e sofisticati esempi di autoritratto e di foto-scultura, penso che questo lavoro si possa considerare uno dei primi esempi performativi nella storia dell’arte, un esempio antesignano di body-art e, sicuramente, per la metodologia della messa in scena, un momento importante da cui poter far scaturire riflessioni sull’espressione del corpo, con riferimento alla sperimentazione teatrale delle avanguardie del ‘900, da Antonin Artaud, passando per Jerzy Grotowski, fino a Eimuntas Nekrosius ed altri.
MZ: A seguito della pubblicazione delle prime interviste della serie “Visioni”, alcuni difensori della fotografia tradizionale mi hanno scritto per chiedermi chiarimenti in riferimento ai termini “metafotografia” e “oltrefotografia”. Lo chiarisco qui prima di porti le successive domande. “Metafotografia” allude alle questioni aperte da Umberto Eco (l’opera aperta) e dalla semiotica, ovvero alla possibilità di trovare nuovi sensi nel passaggio da un linguaggio a un metalinguaggio, dalla “scrittura di luce” alla “metascrittura di luce”, dagli algoritmi ai meta-algoritmi. E non si tratta di innestare la fotografia con ibridazioni e con altri media. Quando utilizzo il termine “oltrefotografia”, invece, mi riferisco a qualcosa che la fotografia non ha ancora mostrato o colto, ovvero qualcosa che è in grado (forse più avanti attraverso le scoperte e le teorie della fisica quantistica) di raccordare le varie possibilità del tempo, ovvero di mostrare nello stesso istante “passato | presente | futuro”. L’oltrefotografia dovrebbe (o potrebbe) mostrare ciò che la fotografia non ha ancora “fotografato”, perché è qualcosa che le sta oltre, e probabilmente la trascende, in un’alterità non definibile, nell’ineffabile. Potrebbero essere le immagini dell’inconosciuto, dell’inconscio, delle proiezioni oniriche, dei desideri non consci, le preveggenze, le immagini archetipali, o altro ancora. I profeti, i veggenti, gli sciamani, i geni (in ogni disciplina) hanno utilizzato qualcosa che è simile al concetto di oltrefotografia, che potremmo anche definire come ciò che si svincola dal limite del medium. Sembra un discorso distopico, ma invece appartiene solo alla casistica delle possibilità. È solo questione di tempo, fino a quando verrà inventata una macchina in grado di rendere visibili immagini interiori, fantasie, idee concettuali, astrazioni, sogni, visioni, premonizioni, o altro. Quando sarà utilizzabile una macchina oltrefotografica verrà oltrepassato un confine ulteriore, quello vincolato allo scatto e a qualcosa che accade veramente nella realtà esterna, nella storia, nel visibile quotidiano. È possibile che venga realmente creata una macchina oltrefotografica? I sogni e le immagini interiori verranno tradotti in codici numerici o in un’altra modalità e riprodotti attraverso un visore o un altro dispositivo?
PM: Le suggestioni che tu innesti sono ammalianti e sicuramente premonitrici di paesaggi futuri, in quanto esiste un’attendibilità delle ricerche in questo senso in ambito di scienze e neuroscienze. La stessa fotografia analogica, agli inizi del secolo scorso, si orientò verso uno scostamento netto dalla realtà e furono gli scienziati del diciannovesimo secolo ad apparire come i veri visionari, aprendo la strada a tutta la produzione del ventesimo secolo, periodo in cui la fisica, la chimica, l’ottica, cominciò ad elaborare i suoi strumenti. Alcuni fotografi lavorarono con gli ottici, chiedendo loro di studiare e produrre aberrazioni alle lenti, non per mirare esclusivamente a ottenere una “pasta” simile ad un’iconografia pittorica, come sostengono alcune riduttive valutazioni di quel periodo, ma, attraverso quella richiesta (che sarebbe stata contraddetta successivamente con l’avvento su larga scala delle affilate ottiche “tecniche” di precisione), si disposero a lasciarsi sorprendere dal risultato finale, ad inserire sgambetti ai processi, accogliendo le potenzialità rivelatrici degli strumenti. La fotografia fu un gioco molto serio. Fu vivo, in quegli autori, il desiderio di far lavorare le macchine, le ottiche, con un certo margine di autonomia. Ci sono passi interessanti di carteggi fra fotografi e ottici, su questo argomento, per esempio proprio fra Holland Day ed Henry Smith (cofondatore della Pinkham & Smith Optics Company di Boston) ed, ancora, corrispondenze con Alvin Langdon Coburn, Herbert Copeland, Gertrude Käsebier, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Clarence H. White, solo per citarne alcuni, conservate nella collezione dei manoscritti della Library of Congress di Washington.
MZ: L’inconscio tecnologico contenuto nella macchina è in grado di immaginare tutto quello che appartiene a ciò che non è conscio per l’essere umano?
PM: Per quel che riguarda “l’inconscio tecnologico”, lo stesso William Henry Fox Talbot, ancora prima negli anni, verso il 1844, nel suo The Pencil of Nature, anticipò, intuì in embrione, quello che poi molti anni dopo svilupperà Vaccari con le sue riflessioni, spostandosi radicalmente verso un’azione della macchina come strumento in grado di produrre registrazioni e memorie autonome. Talbot, tra l’altro, scrisse: “…succede spesso – e questo è uno dei fascini della fotografia – che l’operatore scopra ad un esame successivo di aver raffigurato in fotografia molte cose di cui non aveva idea al momento…a volte si vede un quadrante distante, e su di esso – inconsciamente registrata – l’ora del giorno in cui la presa fotografica è stata effettuata”. Nel 1932, più o meno negli anni in cui Walter Benjamin scrisse la sua Piccola storia della fotografia, la relazione fra azione dell’operatore e fenomeno di scoperta dell’immagine, venne espressa, dal punto di vista del chimico, in un capitolo del Geschichte der Photographie, testo seminale dell’austriaco Josef Maria Eder. Alcuni passaggi di quel testo sono riportati nel recente volume di Peter Geimer Une histoire des surgissements photographiques (Les presses du réel, 2018). Geimer si sofferma sul concetto di “residuo irriducibile”, cioè quell’elemento che si presenta nell’immagine o che sorge sull’immagine discostandosi dall’intenzione e dal controllo dell’operatore. Finché la fisica, l’ottica e la chimica agisce nella progressione temporale di processi fluidi, costantemente in divenire precario, la fotografia continua a respirare in un corpo caldo, avvolgente, pulsante, avendo coscienza che anche dall’accettazione di un fenomeno naturale per definizione, si può determinare, come in un’epifania della visione, che l’immagine si compia.



MZ: Le tecnologie più avanzate – ovvero quelle che sono al contempo scientifiche, visionarie, veggenti, e aperte alle intuizioni artistiche più ardite e interessanti – spingeranno ancora più in là il processo evolutivo della fotografia. Saranno in grado di mostrare nello stesso istante il presente, il passato e il futuro, per andare oltre la quarta dimensione sfondata da Duchamp e ancora oltre, verso qualcosa che ora nemmeno riusciamo a immaginare?
PM: Nel 1922, Duchamp, colloquiando con Stieglitz a proposito della fotografia, disse: “sai esattamente come la penso riguardo alla fotografia. Mi piacerebbe vederla guidare le persone a ignorare la pittura, fino a quando qualcos’altro renderà la fotografia insopportabile”. Ecco, oggi quel qualcos’altro è un germe interno che può far sviluppare un organismo sano oppure farlo deteriorare irreparabilmente. Ciò che rende insopportabile la fotografia generata dal sistema di condizionamento delle case produttrici di software è l’informe calderone ecumenico che rischia di condurre chi ne è immerso ad un grado acritico di rapporto con le immagini, all’incapacità di giudizio, con conseguente totale schiavitù agli stereotipi. E non c’è nessun santone della condivisione dal basso in grado di convincermi del contrario. L’effetto show, lo spettacolo di fuochi d’artificio propinatoci che si ripete, ha immiserito l’immaginario collettivo, imponendosi soprattutto attraverso i social media.
Ciò che, invece, ci fornisce una possibilità di spingere altrove la nostra immaginazione, rinvigorendola, è l’uso degli algoritmi collegato a nuove forme di design, di proiezione parallela, quella che tenta di connettersi ad una dimensione più espansa, introducendo altri enigmi. Enigmi di “matrice” diversa, appunto, ma paralleli a quelli della fotografia analogica. Un raffreddamento poetico, incorporeo, altrettanto intrigante, anche se opposto a quel corpo caldo e pulsante di cui parlavo prima. Ryoji Ikeda spiegava recentemente, in occasione della sua installazione Continuum al Centre Pompidou, a Parigi, che nella sperimentazione contemporanea collegata alle composizioni visivo-sonore, vi è una “iperprogettualità” che, paradossalmente, fornisce alcune interessanti variabili prodotte dall’uso dei numeri.
La “scoperta” deriverebbe, quindi, proprio da un estremo grado di sapienza progettuale, intesa come capacità di far interferire fra loro differenti approcci ai software. Per evitare la prevedibilità, bisogna quindi portare alle estreme conseguenze il grado di controllo delle macchine e dei programmi, amplificando, moltiplicando gli intrecci dei codici. Ecco, quello che ritengo importante, per cercare di essere coerente con quello che ho espresso finora, è l’attenzione ai processi, perché so che questi ci porteranno davvero a nuove immagini; vorrei godere appieno l’iter di questi processi, step by step, immaginando qualcosa che forse non ha bisogno di etichette, evitando l’incasellamento delle attività sperimentali. Per la ricerca di nuovi sensi nel passaggio dalla scrittura di luce alla metascrittura di luce, lasciamo che la scienza, prendendosi il suo tempo, spalanchi la strada e fornisca agli artisti nuove chiavi d’incanto.
Bio
La ricerca fotografica di Pino Musi ha intersecato molteplici aree d’interesse come l’antropologia, l’architettura, l’archeologia o, ancora, la produzione industriale. L’articolazione del suo lavoro trova il miglior mezzo espressivo nella realizzazione di libri. Sono più di venticinque i volumi pubblicati finora, e varie le esposizioni. Le opere di Pino Musi sono presenti in collezioni private e pubbliche, tra cui la Fondazione Rolla, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la Fondazione Fotografia di Modena, il FRAC (Fonds régional d’art contemporain) Bretagne.